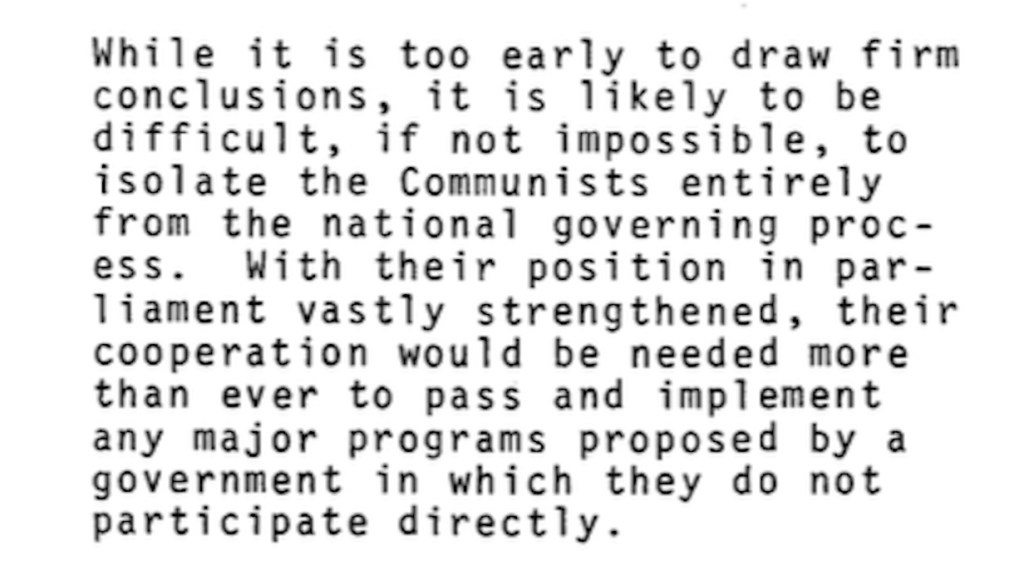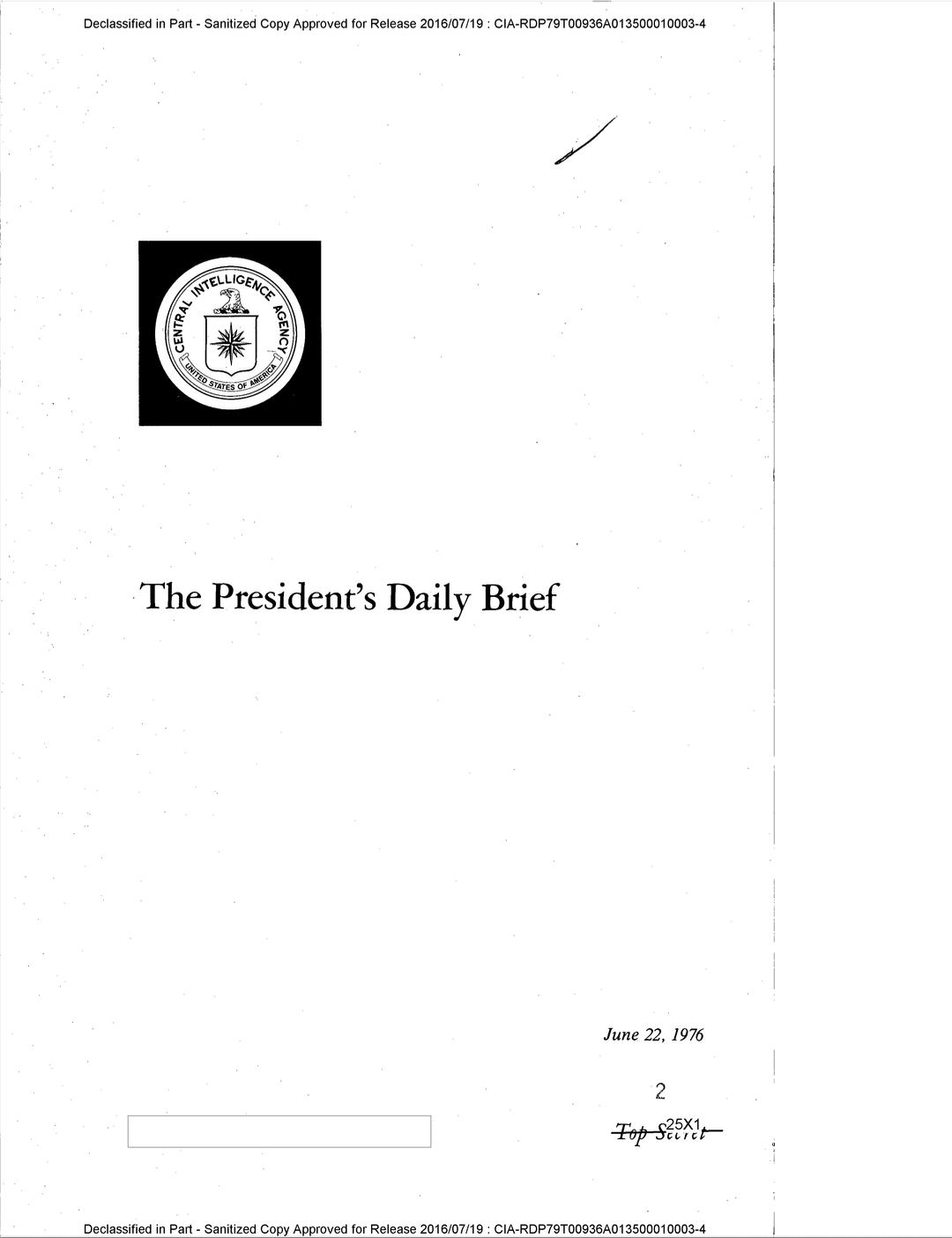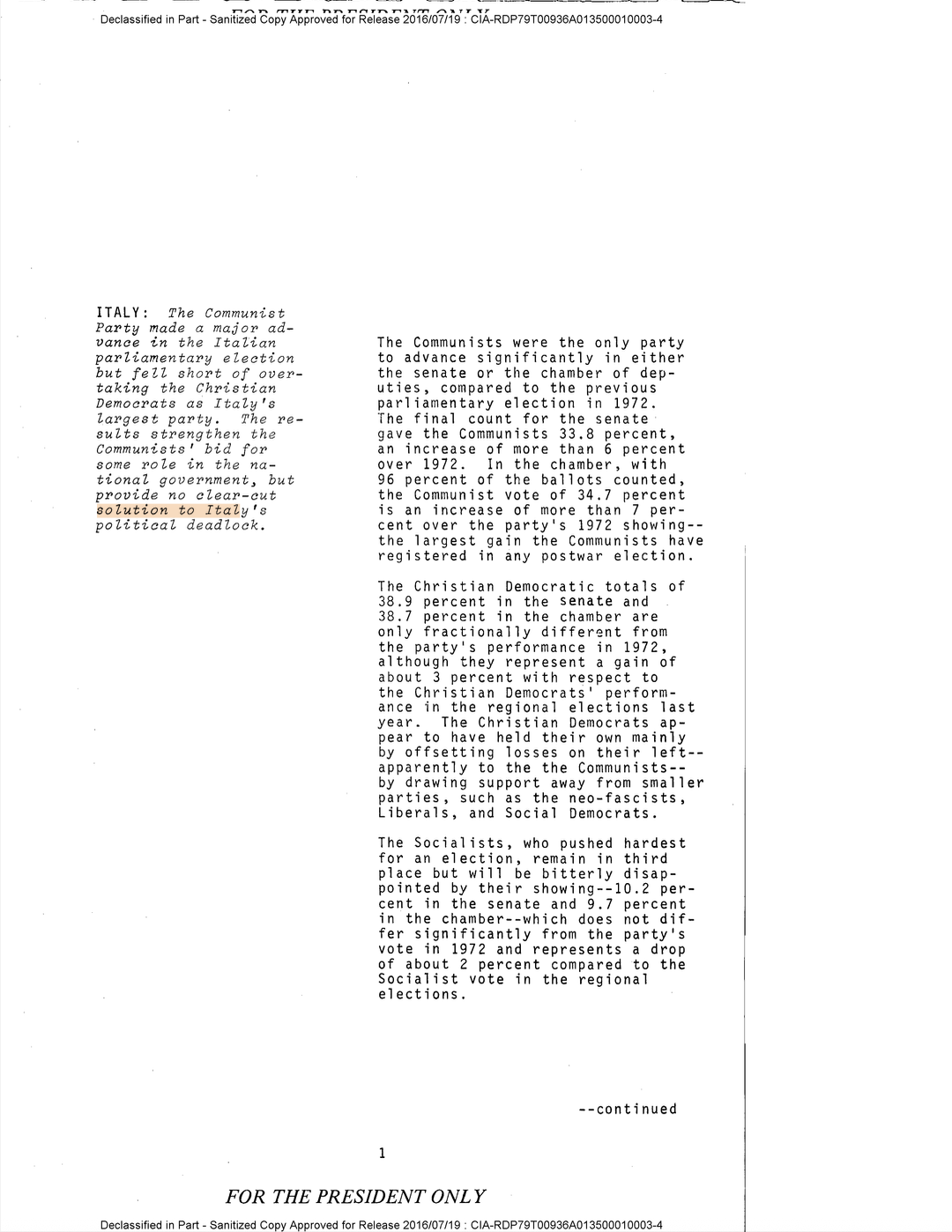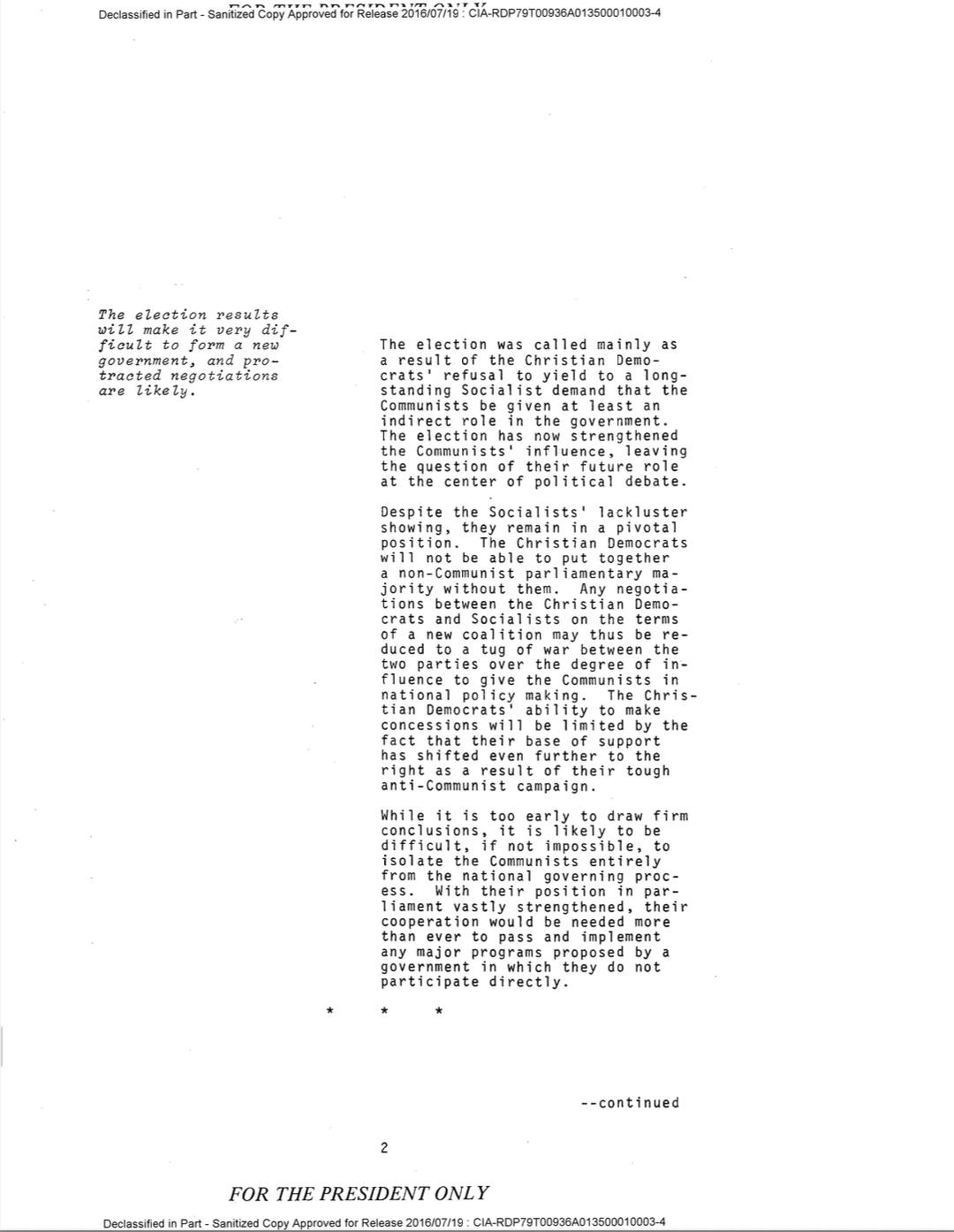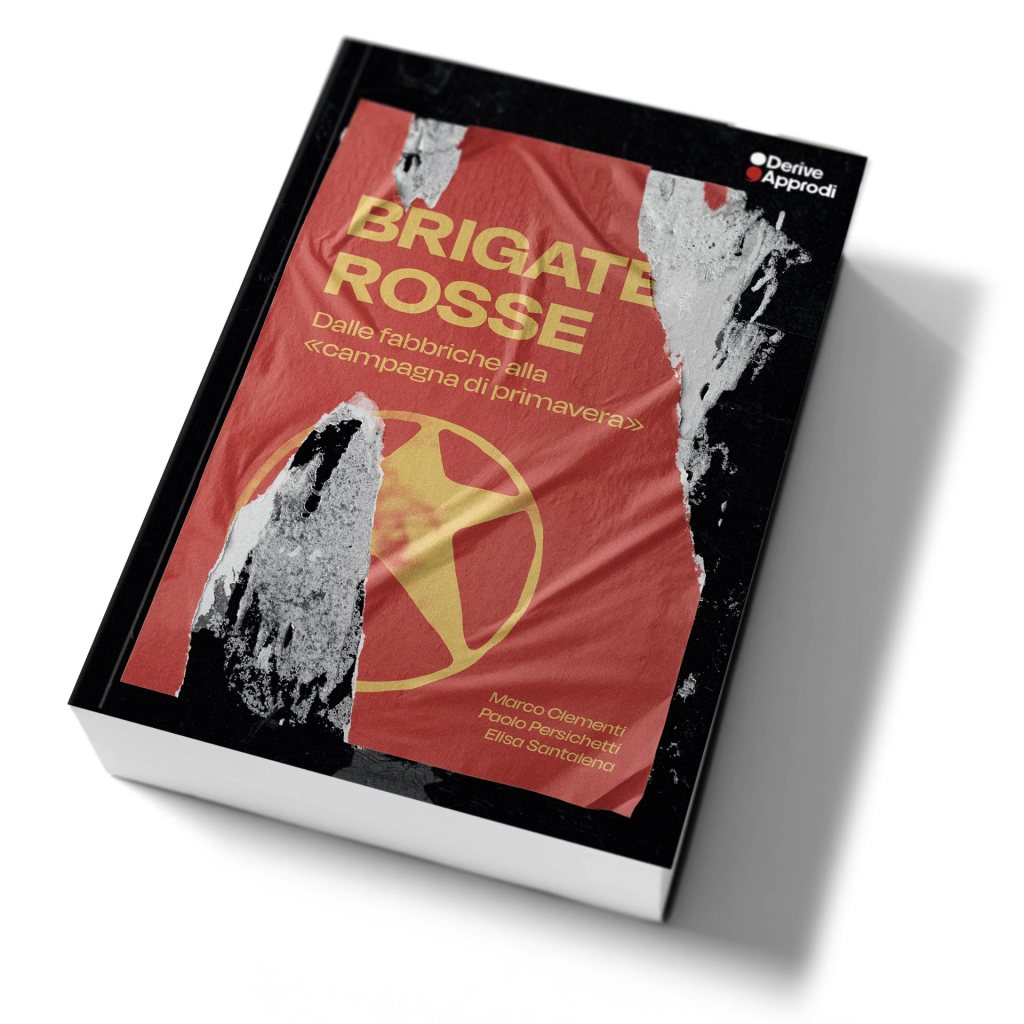Riparte il processo di Alessandria per la sparatoria del 5 giugno 1975 davanti la cascina Spiotta, nella quale trovarono la morte la fondatrice della Brigate rosse Mara Cagol e il cararbiniere Giovanni D’Alfonso. Si è svolta martedì 27 gennaio 2026 l’ottava udienza

«Tra i rapitori di Gancia c’era forse qualcuno di origine calabrese?», la domanda sollevata dal legale di parte civile, Nicola Brigida, è risuonata più volte volte nella nuova aula che ha accolto la riapertura del processo per la sparatoria del 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta, in località Arzello di Acqui Terme, dove trovarono la morte l’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso e la fondatrice delle Brigate rosse Mara Cagol. I singolari quesiti, rivolti ai soli due testi che hanno accettato il contraddittorio processuale, hanno accentuato l’effetto surreale e straniante che si è respirato per l’intera mattinata. Dopo che Lauro Azzolini, lo scorso marzo 2025, con una deposizione spontanea ha rivelato di essere lui il brigatista sopravvissuto al conflitto a fuoco e poi fuggito nel bosco, il processo sembra trascinarsi. Pubblica accusa e parti civili, spiazzate dall’inaspettata rivelazione, hanno visto la loro strategia processuale incepparsi. Le parole di Azzolini hanno spazzato via le congetture complottiste delle parti civili e tolto argomenti ai pm, chiarendo come quella mattina, lui e Mara Cagol, fossero stati colti di sorpresa reagendo in modo improvvisato, senza seguire alcuna direttiva impartita da presunti vertici. Come invece sostenuto nel teorema della pubblica accusa per tirare in ballo anche la responsabilità penale di Renato Curcio e Mario Moretti, non tanto nel sequestro dell’imprenditore vinicolo Vallarino Gancia, che Cagol e Azzolini custodivano all’interno della Spiotta, reato ormai largamente prescritto, ma in qualità di mandanti apicali del conflitto a fuoco (anche se non presenti) e dunque nella morte dell’appuntato Giovanni D’Alfonso. Accertata l’identità del fuggitivo, per ritrovare un senso il processo dovrebbe allargare il suo raggio d’azione anche sulle circostanze della morte di Mara Cagol, chiarendo una volta per tutte come la donna venne uccisa, alla luce anche di quanto recentemente emerso sul bossolo proveniente da un arma dei carabinieri, ritrovato accanto al luogo dove giaceva il suo corpo.
La ripresa delle udienze
Dopo una sospensione di sei mesi dovuta alla sostituzione della giudice a latere, martedì 27 gennaio il processo è ripartito con l’ottava udienza. Tra i testimoni convocati: Biancamelia Sivieri, moglie di Lauro Azzolini, non si è presentata avvalendosi della facoltà di non rispondere, poiché testimone imputata di reati connessi. Scelta condivisa anche dall’altro teste, Antonio Savino. I due hanno inviato delle lettere alla corte tramite il loro legale. Analogo atteggiamento c’è stato da parte della ex brigatista Nadia Mantovani, catturata nel gennaio del 1976 nella base di via Maderno a Milano insieme a Renato Curcio, che però è venuta in aula a comunicare davanti alla corte la sua indisponibilità. Al contrario Enrico Fenzi, già collaboratore di giustizia, ha preferito rispondere alle domande anche per correggere le affermazioni fatte durante un’audizione della commissione Moro 2, presieduta da Giuseppe Fioroni, e ribadite agli autori di due recenti volumi complottisti, Simona Folegnani e Berardo Lupacchini, che su quelle affermazioni avevano costruito una sprovveduta narrazione del rapimento Gancia e della sparatoria davanti la Spiotta, ormai utile solo alla critica dei roditori.
«Mi sono sbagliato su Moretti, non era lui il fuggitivo»
Fenzi, ormai ultraottantenne, come alcuni degli imputati alla sbarra, ha ammesso di essersi sbagliato. Le sue – ha affermato – «erano solo impressioni», ricavate nel carcere speciale di Palmi dove si registrava «un clima di ostilità e avversione nei confronti di Mario Moretti che andava al di là delle ragioni politiche». Soprattutto Franceschini – ha sottolineato Fenzi – si mostrava «severo e rancoroso, invelenito personalmente contro Moretti, a cui veniva attribuito il disastro della Spiotta». Allora – ha proseguito l’ex professore della università di via Balbi, studioso di Petrarca: «ho associato questo odio al fatto che fosse Moretti il fuggitivo. Evidentemente mi sbagliavo». Fenzi, a conclusione della sua testimonianza, ha voluto precisare che «Moretti non era una spia», raccontando di come una volta lo avessero messo in cella con Giorgio Semeria, un brigatista milanese che lo riteneva responsabile della sua cattura e del tentato omicidio nei suoi confronti da parte del brigadiere Atzori, su una pensilina della stazione centrale di Milano, il 22 marzo del 1976 (oggi sappiamo che a consegnarlo fu il confidente del Sid Leonio Bozzato, suo contatto diretto nella colonna veneta). «Il carcere era un laboratorio», ha spiegato Fenzi, e qualcuno ai vertici dell’amministrazione penitenziaria voleva vedere cosa potesse accadere.
Nella sua lunga deposizione, dovuta alle numerose domande del pubblico ministero Emilio Gatti, uno che ricorda quei giocatori di golf che non riescono mai ad andare in buca, Fenzi ha ridimensionato anche il suo ruolo nelle Brigate rosse. Ha raccontato di essere stato arruolato nella colonna genovese da Gianfranco Faina, era il 1976, ma che dopo una fase iniziale fu congelato, prima di essere arrestato nel maggio 1979, smentendo così la tesi di una colonna genovese fondata dagli intellettuali di Balbi che si trascinarono dietro pochi marginali, sostenuta dallo storico Sergio Luzzato nel suo recente volume, Dolore e furore, per altro citato in aula dallo stesso pm Gatti, che tiene a mostrare di aver studiato.
«Solo dopo la scarcerazione», nell’estate 1980, Fenzi ha raccontato di aver preso parte alla burrascosa direzione strategica di Tor san Lorenzo. Era lì per esporre le critiche mosse dal collettivo dei prigionieri di Palmi, anche se cambiò presto opinione e si avvicinò a Moretti, soprattutto al momento della separazione della colonna milanese Walter Alasia dalle altre colonne Br. A quel punto fu incaricato di salire a Milano per tentare di ricucire i rapporti col gruppo dissidente. Attività che si interruppe con l’arresto, accanto a Moretti, del 4 aprile 1981.
Le carte segrete dell’avvocato Brigida
E’ a questo punto che la Calabria ha fatto improvvisamente irruzione nel processo per fatti accaduti nelle lontane Langhe dell’alessandrino. Il legale di parte civile Brigida ha chiesto a Fenzi se era mai stato in terra calabrese e avesse soggiornato a Soverato: «Ha mai saputo se nelle Br c’era un militante calabrese? Perché secondo Gancia, uno dei suoi rapitori aveva un accento del genere». Fenzi ha risposto che nel 1980 era stato ad Africo, ospite di Rocco Palamara, un noto anarchico impegnato nelle lotte delle braccianti raccoglitrici di bergamotto, nemico giurato della ‘ndrangheta locale, e che per questo era stato gambizzato. Una storia narrata anche da Corrado Staiano in Africo. Gli avvocati della difesa hanno contestato la pertinenza dei quesiti con le vicende della Spiotta, dove per altro nessuno degli inquisiti o sospettati nelle indagini è mai risultato avere origini calabresi. E’ apparso chiaro che tra le parti civili ci sono avvocati che stanno utilizzando il processo di Alessandria come trampolino di lancio per ennesime piste di indagine, magari sul sequestro Moro o in vista di una nuova “strabiliante” puntata di Report.
Se la storia la fanno i Ros
L’udienza è proseguita con l’esame di un maresciallo dei Ros di Torino, tra gli autori della informativa riassuntiva delle indagini. Come già accaduto in una precedente udienza del giugno scorso, nella quale aveva deposto un suo collega del Ros di Roma, ci si è trovati di fronte ad una situazione imbarazzante. I detective dei carabinieri sono stati chiamati a svolgere un lavoro di archivio e storico-interpretativo che esula la semplice catalogazione di fatti giuridici, come sentenze o vecchie indagini. Questi analisti si sono dovuti misurare con un ostacolo a volte molto più grande delle loro forze e conoscenze, anche in ragione della loro età anagrafica. Così durante il controesame le difese hanno avuto agile gioco nell’evidenziare le numerose contraddizioni o inesattezze: Maraschi forzosamente collocato nella colonna milanese anziché in quella torinese, dove era riparato dopo le indagini sulla comune lodigiana di provenienza, per dimostrare che il sequestro fu opera non solo della colonna di Torino ma anche di Milano e così poter meglio accusare Curcio e Moretti. Oppure i ripetuti errori sul ruolo dello stesso Moretti (che entrò nelle Br nei primi mesi del 71 e non nel 70; non fu lui a interrogare Sossi ma Franceschini); l’anticipazione del valore operativo attribuito alle bozze di una discussione prolungatasi un intero anno sulla futura struttura interna delle Br, varata solo dopo i fatti della Spiotta e non prima; la tendenza a percepire alcuni concetti, divenuti anche codici linguistici, come «rompere l’accerchiamento», in termini unicamente forensi e non politici. Limiti di una indagine per fatti lontani cinquant’anni che inevitabilmente non riesce a misurarsi con la storia. Perché la storia non si fa con in processi penali.
Sostieni Insorgenze
https://paypal.me/insorgenzeonline