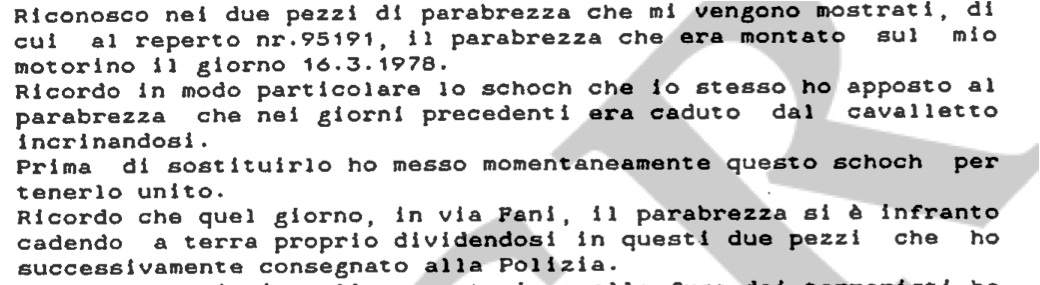Giulio Petrilli ci ha lasciato prematuramente questo notte a causa di una embolia polmonare. Ricoverato d’urgenza non ce l’ha fatta. Corpo possente da vero rugbista lo ricordiamo per la sua incredibile umanità, per la generosià debordante. Nonostante l’assoluzione finale, i sei anni di detenzione trascorsi nelle carceri speciali con l’accusa di partecipazione a banda armata l’avevano segnato. In prigione, nel 1984, era stato anche duramente picchiato dalla polizia penitenziaria dopo una fermata all’aria di protesta fatta con si suoi compagni per denunciare le condizioni di detenzione. Una volta uscito aveva speso tutte le sue energie nelle battaglie contro il carcere, la detenzione politica e per l’amministia, contro la cultura politica giustizialista che imperversava e imperversa in quel po’ che resta della sinistra, contro il populismo penale, pagando anche di persona, affrontando polemiche velenose e attacchi personali. Si è battuto fino all’ultimo contro il 41 bis, restando vicino e conducendo visite ispettive all’interno di queste sezioni speciali. Viveva come un tormento personale la reclusione di questi militanti, le loro condizioni di isolamento. Partendo dalla sua esperienza personale raccontata nell’articolo qui sotto, scritto il 3 ottobre del 2012, Giulio aveva avviato una lotta senza quartiere contro l’ingiusta detenzione. Nonostate l’assoluzione i giudici avevano rifiutato di risarcirgli i sei anni trascorsi nelle carceri speciali perché – avevano spiegato – il loro errore iniziale era stato indotto dalla sue pessime frequentazioni. Vicenda kafkiana che aveva acceso in lui un fuoco inesauribile che lo spingeva a battersi contro ogni forma di reclusione, di internamento, contro l’esilio, ma che al tempo stesso lo bruciava consumandolo. Ho conosciuto Giulio sulle strade intorno a L’Aquila quando mi recavo in Abruzzo durante i miei primi permessi. Ricordo la volta, poco dopo il terremoto, in cui mi portò nella zona rossa per farmi conoscere le ferite terribili inferte a quella città. E poi le tante telefonate, le discussioni, la sua voglia continua di riaprire battaglie come quella sull’amnistia. Giulio non si arrendeva mai. Ciao Giulio!
Dalla filosofia del diritto alla teologia giudiziaria. L’istituto del risarcimento per ingiusta detenzione è disatteso nella gran parte dei casi da una magistratura aggrappata al dogma della propria infallibilità
di Paolo Persichetti
3 ottobre 2012
Soltanto un terzo delle richieste di risarcimento per ingiusta detenzione trovano soddisfazione. E’ quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall’Eurispes e dall’Unione delle camere penali italiane. Su una media di 2500 domande annuali (nel 2011 ne sono state presentate 2369) appena 800 vengono accolte. Il motivo è semplice e al tempo stesso sconcertante: l’Italia è l’unico paese in Europa dove l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione è regolato da una clausola, inserita nel comma 1 dell’articolo 314 cpp, che esclude il risarcimento nei casi in cui il ricorrente «abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
Secondo la norma per avere diritto al risarcimento non è sufficiente avere dalla propria parte una sentenza d’assoluzione irrevocabile, secondo una delle formule previste dal codice: il fatto non sussiste, oppure non è stato commesso o non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale. Non basta nemmeno che la giustizia abbia riconosciuto l’illegittimità della misura cautelare.
Chi ha ingiustamente subito il carcere deve dimostrare di non aver tenuto un comportamento tale da aver tratto in inganno i magistrati con atteggiamenti omissivi o perché non si è avvalso delle funzioni difensive, che pure restano un diritto fondamentale della persona sottoposta a indagini o imputata, ma anche sotto il profilo delle proprie frequentazioni.
Ciò vuol dire che le sentenze assolutorie non sono valutate come tali ma sottoposte ad un nuovo processo che conduce ad esaminare e giudicare sotto il profilo morale la personalità di chi è stato assolto, introducendo un criterio discriminatorio che inanella una serie impressionante di violazioni: dal ne bis in idem, all’invenzione di una sorta di quarto grado di giudizio capace di resuscitare la colpa al di là di ogni assoluzione fino all’inversione dell’onere della prova.
Nel giugno scorso, la quinta sezione penale della corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di risarcimento per ingiusta detenzione di una persona assolta in via definitiva dopo aver trascorso 6 anni nelle carceri speciali, sostenendo che «nessun diritto alla riparazione spetta a chi, frequentando terroristi, o comunque soggetti appartenenti all’antagonismo politico illegale, abbia colposamente creato l’apparenza di una situazione che non poteva procurare l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Poco importa, ai fini che qui interessano, l’esito del giudizio penale. Occorre distinguere – prosegue il collegio – l’operazione logica compiuta dal giudice del processo penale da quella, diversa, del giudice della riparazione. La reciproca autonomia dei due giudizi comporta che una medesima condotta possa essere considerata, dal giudice della riparazione come contributo idoneo ad integrare la causa ostativa del riconoscimento del diritto alla riparazione e, dal giudice del processo penale, elemento non sufficiente ad affermare la responsabilità penale».
I magistrati hanno teorizzato un doppio criterio di giudizio: il primo sottoposto alle vigenti leggi processuali; il secondo che riabilita la colpa tipologica è non si cura degli effetti legali dell’assoluzione, che seppure elimina la colpa mantiene il sospetto e soprattutto conserva la responsabilità. Siamo di fronte ad un perenne “diritto del nemico” che trasforma in un accessorio a geometria variabile la presunzione d’innocenza recepita dall’art. 27 della costituzione.
Chi viene assolto per reati avvenuti in luoghi dove è presente la criminalità organizzata, diventa responsabile del fatto di aver frequentato contesti che brulicano di pregiudicati; chi è assolto da reati di eversione, se ha frequentato luoghi di conflitto, recepito culture antagoniste, anticonformiste e irregolari secondo la norma politico-morale dominante, è ritenuto responsabile di una corrività ambientale che ha indotto la coscienza del giudice a sbagliare. E’ una colpa di natura etico-morale quella che qui viene scovata e sanzionata con il mancato risarcimento.
Non sfugge che attraverso questo dogma dell’infallibilità assoluta del giudice, come fu per il concilio Vaticano I° che nel 1870 introdusse l’infallibilità ex cathedra del pontefice, si opera il passaggio dalla filosofia del diritto alla teologia giudiziaria. Un’arrogante pretesa che spiega l’errore ricorrendo all’alibi della “colpa apparente”, giustificata non da una cattiva valutazione degli elementi probabotori a carico o discarico ma dalla doppiezza e dall’ambiguità della persona sottoposta a indagine o giudizio, alla stregua del maligno che con le sue arti malefiche confonde e trae il mondo in inganno.
Sarebbe tempo di riportare la giustizia dalle sfere della santità celeste ad una più terrestre dimensione profana.