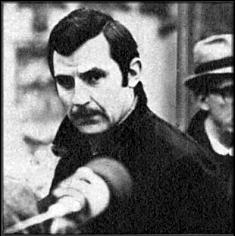PORTA UN FIORE per l’abolizione dell’ergastolo
23 giugno 2012
Viaggio al cimitero degli ergastolani nell’isola di S. Stefano (Ventotene)
Dopo il processo e la condanna all’ergastolo per l’uccisione a colpi di pistola del re Umberto I, la sera del 30 luglio 1900 condanna, l’anarchico Gaetano Bresci giunge nel reclusorio di Santo Stefano il 23 gennaio del 1901. Qui lo attende una casacca con il numero 511, che d’ora in poi secondo il regolamento sarà il suo unico appellativo. Lo aspetta anche una cella particolare fatta costruire appositamente in previsione del suo arrivo, in un’ala completamente isolata del carcere. E’ una cella del tutto nuova, un po’ più confortevole di quella dove era stato recluso a Portolongone. L’ergastolano sarà sempre sorvegliato a vista dai carcerieri in due stanze poste ai lati della camera principale. Bresci si adatta, chiede di poter leggere e poiché la biblioteca del carcere dispone soltanto di tre libri: Le Vite dei Santi, la Bibbia e un dizionario di Francese, sceglie quest’ultimo. Cerca anche di fare ginnastica giocando a palla nella cella, nonostante i ferri, con una palla improvvisata ricavata con un tovagliolo arrotolato.
Bresci non mostra minimamente segni di sconforto, non ha atteggiamenti che lascino pensare alla possibilità di un suicidio. Il suo avvocato Francesco Saverio Merlino sta lavorando per apprestare una richiesta di revisione del processo, nel movimento anarchico c’è la speranza di riuscire ad organizzare una sua clamorosa evasione. Timore che esacerbava le paure del governo. Sul tavolo del governo giungevano quotidiane segnalazioni di possibili cospirazioni anarchiche. Il 18 maggio 1901 una lettera di Malatesta intercettata e sulla scrivania di Giolitti.
Nel pomeriggio del 22 maggio il corpo esamine di Gaetano Bresci penzola dall’unica sbarra ella finestra della cella. Strumento dell’impiccagione un asciugamano, il cui possesso però – si seppe dopo – era vietato.Secondo la testimonianza riportata dal carceriere, Bresci fino alle 14,50 aveva studiato il dizionario di francese. A quell’ora il carceriere si allontana per tre soli minuti a causa di un bisogno corporale, e quando rientra scopre il cadavere.
A mettere in dubbio la dinamica dei fatti saranno i medici incaricati di eseguire l’autopsia, il giorno 26, i quali notano lo stato di un cadavere in avanzato stato di putrefazione assolutamente incompatibile con una morte avvenuta solo 48 ore prima.
Giuseppe Mariani, l’anarchico attentatore del cinema Diana a Milano nel 1921 nelle sue memorie, Nel mondo degli ergastoli, scrisse:Fu detto che si è impiccato; ma come avesse potuto impiccarsi con le catene ai piedi e una sorveglianza continua, e senza far rumore (quando bastava un piccolo movimento perché le catene emettessero il loro suono caratteristico) è quello che nessuno di noi ha mai capito. Per legge le catene erano state abolite, ma a noi qui le lasciarono fino al 1907. Naturalmente condannati che si toglievano la vita ce n’erano anche allora, ma non s’impiccavano. Si strozzavano stringendosi il fazzoletto attorno al collo con tutta la forza fino a rimanere soffocati. Noi lo avremmo considerato un privilegio potersi impiccare come si può fare adesso. E in quanti ci saremmo impiccati!
Da segnalare, infine, la presenza nel reclusorio di Santo Stefano, almeno già dal 18 maggio, di un funzionario centrale inviato dal Ministero, tale Alessandro Doria, conosciuto per la sua esperienza nell’organizzare macchinazioni. Arrigo Petacco, nel suo libro L’anarchico venuto dall’america, ha scoperto la scomparsa della documentazione riguardante Gaetano Bresci sia negli archivi del penitenziario di Santo Stefano, che nell’Archivio Generale dello Stato, dove è conservata la pratica sul regicidio. Non v’è traccia nemmeno nelle carte segrete del fondo Giolitti, dove compare la cartellina vuota, intitolata Notificazioni del suicidio di Bresci compilata dal Doria. Un segreto di Stato conservato alla perfezione.
Testo estratto dal libro di Massimo Ortalli, Gaetano Bresci, tessitore anarchico e uccisore di re, Nova Delphi 2011, pp. 87-95
La segregazione
La punizione che aspetta il regicida è tale da sorpassare, per sofferenze, la pena capitale e Bresci avrà più di una volta da augurarsi di essere mandato all’altro mondo. Chi scrive può accertare che la vita trascorsa degli ergastolani è tale da far preferire mille volte la pena di morte.
La segregazione è pena accessoria ad è computata un sesto della pena. Il minimo della segregazione per chi è condannato all’ergastolo è cinque anni.
Il condannato all’ergastolo con dieci anni di segregazione, prima di entrare nella cella viene rinchiuso in una segreta a mezza luce, larga appena un metro e lunga due. A pochi centimetri da terra vi è una tavola leggermente inclinata larga circa 50 centimetri che serve da giaciglio. Per la nutrizione riceve solo pane e acqua. La porta della segreta durante questo periodo di rigore è sempre tenuta chiusa. Gli ergastolani più temuti sono quelli di Santo Stefano, di Nisida, di Civitavecchia e di Portolongone.
Quando l’ergastolano ha compiuto la pena segreta, se ha tenuto buona condotta passa alla cella ove dovrà espieare gli anni di segregazione. In generale le celle sono poco illuminate, prendono luce da un corridoio. Sono poco più di due metri quadrati. Il giaciglio è il solito tavolo, e il cibo, pane e acqua.
I segregati non possono leggere, né fumare, né scrivere, né lavorare. E’ l’ozio, il più assoluto condito di un assoluto silenzio. E’ raro che il condannato alla pena massima dellìergastolo con dieci anni di segregazione, compia questi dieci anni. O impazzisce o muore, e se si ribella l’attende la camicia di forza, i ferri ed il letto di forza.
Il ministro dell’Interno può con speciali disposizioni inasprire le pene speciali di rigore. Infatti quando Passannante venne condannato a morte e che per somma clemenza del nostro buon Re Umberto, che noi tutti piangiamo, gli venne commutata la pena di morte nella galera a vita, il Ministero ordinò una speciale segregazione scontata nella torre del bagno di Portoferraio, e propriamente nel carcere oscuro che è a due metri sotto il livello del mare.
Passannante vi entrò nel 1881 e me uscì nel 1889 quando per consiglio dei medici venne ricoverato nel manicomio criminale di Montelupo, ove si trova tuttora, affetto da spinite e da pazzia.
Estratto da Massimo Ortalli, Gaetano Bresci, tessitore anarchico e uccisore di re, Nova Delphi 2011, pp.85-86
Ps: Una traccia della pena accessoria della segregazione la ritroviamo ancora oggi negli artt.72 e 184 c.p. che prevedono l’isolamento diurno del condannato all’ergastolo quale sanzione accessoria e aggravante della pena dell’ergastolo. Il regime di segregazione trova un suo corrispettivo nel regime detentivo previsto all’art. 41 bis op (carcere duro).
PORTA UN FIORE per l’abolizione dell’ergastolo
23 giugno 2012
Viaggio al cimitero degli ergastolani nell’isola di S. Stefano (Ventotene)
Il cimitero degli ergastolani di S. Stefano, attiguo al vecchio carcere (1795- 1965), costituisce un luogo simbolico da vedere e far vedere perché racconta in modo emblematico, con le sue 47 tombe senza nome, non solo la spietatezza dell’esclusione degli ergastolani dal consorzio umano anche post-mortem, ma soprattutto ciò che oggi è l’ergastolo. In particolare la tortura dell’ergastolo senza speranza, quello cosiddetto ostativo, in base al quale due terzi delle persone attualmente condannate alla pena eterna, sono sostanzialmente escluse da quei benefici che permetterebbero la concessione, almeno teorica, dell’uscita dal carcere dopo 26 anni di pena scontata. Per questi reclusi l’ergastolo costituisce un “fine pena mai” effettivo, che prevede oltre alla morte sociale e civile, la loro effettiva morte in carcere.
Link
Liberiamoci dal carcere, ancora sul viaggio a santo Stefano
Cimitero di santo Stefano, anche gli ergastolani ora hanno un nome
Resoconto del viaggio al cimitero degli ergastolani
Ergastolo di santo Stefano, un fiore ai 47 corpi senza nomeFine pena mai, l’ergastolo al quotidiano
Sprigionare la società
Desincarcerer la société
Pianosa, l’isola carcere dei pestaggi: luogo di sadismo contro i detenuti
Aguzzini: Lumia, “Riaprire super carcere di Pianosa e applicare severamente il 41 bis”
Basta ergastolo: parte lo sciopero della fame
Boia che non mollano: Cina e Stati uniti in testa alle classiche della pena di morte
Perpetuité
Archivi tag: Gaetano Bresci
Giustizialismo e lotta armata
Secondo Sofri l’uccisione di Calabresi si distinguerebbe dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70-80 perché aveva un contenuto morale che alla lotta armata per il comunismo mancava
Risponde Scalzone che difficilmente una vendetta, un atto di giustizialismo politico, può rivendicare una superiorità morale
Caro Sofri, uccidere Calabresi fu giustizialismo politico
di Oreste Scalzone
Liberazione 2 ottobre 2008
L’incontro patrocinato dal segretario dell’Onu in occasione del Memory day in favore delle «vittime del terrorismo» ha fatto saltare i nervi ad Adriano Sofri. In nome di una indistinta nozione della figura di vittima si è tenuta nelle scorse settimane una cerimonia attorno alla quale sono state raccolte vicende molto diverse tra loro, distanti e persino opposte nello spazio, nel tempo, financo nella loro fenomenologia, morfologia e eziogenesi, come i morti delle Twin Towers, gli scolari trucidati a Beslan, i morti delle stragi di piazza Fontana o l’uccisione del commissario di polizia Luigi Calabresi, per fare solo alcuni esempi.
Condannato per quest’ultimo episodio, ma da sempre proclamatosi innocente, Sofri non ha sopportato l’accostamento. “Io terrorista, alla stregua dei sequestratori di Beslan? No, non ci sto!”. È stato questo il senso della sua indignata reazione per un qualcosa che esplicitamente ferisce il suo onore. Sofri ha giustamente contestato che un episodio come l’uccisione di Calabresi, arrivato al culmine di una sequenza che vide la morte dell’innocente Giuseppe Pinelli e la montatura contro gli anarchici con l’incriminazione di Pietro Valpreda, possa essere messo sullo stesso piano della strage di piazza Fontana, accorpato addirittura a massacri di bambini e deportazioni a volte vicine al genocidio. Sul Foglio del 13 settembre ha sollevato la pietra dello scandalo affrontando la semantica di una delle parole più stregate al mondo: «terrorismo». Termine tra i più compromessi, multiuso, impiegato essenzialmente per delegittimare, mostrificare, demonizzare l’avversario piuttosto che per definire un particolare uso della violenza. Occasione per questo di un infinito autismo comunicativo. Si potrebbe forse obiettare che non ha molto senso rincorrere sul terreno della stigmatizzazione linguistica chi bombarda o ordina martellamenti d’artiglieria e poi rivendica virtuose illibatezze, senza mancare di dare del terrorista ai ragazzini col cappuccio che lanciano sassi, rompono qualche vetrina o riempiono i muri di tag. Da alcuni anni una direttiva europea considera terrorismo il pirataggio informatico o la semplice occupazione illegale di piazze e edifici pubblici. Di fronte a ciò, è lecito chiedersi se si possa passare la vita lasciandosi ipnotizzare nel tentativo di raddrizzare i torti semantici, di (ri)prendersi la ragione rispetto a un intreccio infinito di mascalzonate statali d’ogni tipo…? Forse a questo punto l’unica cosa possibile è fare un’operazione di radicale Jugitzu semantico, come quella realizzata dai movimenti afro-americani, quando decisero di svuotare l’aggressività coloniale e razzista dello stigma negro appropriandosi essi stessi di quella definizione.
La parola terrorismo nasce sulla base di una autodefinizione del rivoluzionarismo statalista-borghese nel drittofilo del diritto di resistenza e del «diritto-dovere a insorgere con le armi alla mano contro il despota e l’usurpatore». Teorie, come quella del tirannicidio, finemente elaborate dai gesuiti spagnoli del 600, Birenbaum e altri, per argomentare la legittimità dell’attentato contro la persona dell’imperatore, se questi entrava in conflitto con l’autorità papale. Dottrine poi riprese con fedeltà mimetica da quello che potremmo chiamare legittimismo del futuro prossimo venturo, di parte repubblicana; e poi di nuovo, alla rovescia, dal legittimismo tradizionalista anti-repubblicano. Termini, dunque, di doppia matrice, cattolica apostolica romana prima e poi – nella teologia politica, con perfetta spinta alla ritorsione mimetica – giacobina. Tanto che potremmo parlare con pertinenza di concetto catto-giacobino.
Che una traccia di filiazione con questa matrice ci sia anche nei vendicatori anarchici – dopo Felice Orsini e gli attentatori della «propaganda attraverso il gesto», i Gaetano Bresci, i Giovanni Passannante, i Sante Caserio, non deve stupire più di tanto. La stessa relazione conduce alle azioni dei populisti, gli amici del popolo, i Narodniki dell’attentato a Stoljpin; o ancora ai nazionalisti – e, se vogliamo distinguere il nazionalismo conculcato e irredentistico da quello già al potere, nazionalitarî; e ancora più in generale ai movimenti caratterizzati da ideologia-passione identitaria nutrita di martirio. La realtà è che le idee delle classi dominanti costituiscono un reticolo concettuale da cui non ci si libera sollevandosi per il codino, come il barone di Munchausen…
Per contro, non a caso il termine è ereditato senza complessi dal filone della sinistra della socialdemocrazia russa, i bolscevichi, e dal loro successivo costituirsi in Komintern. Quasi inevitabile riscontro degli effetti suscitati dalla contraffazione, oltreché lavorista e statalista, teorizzata da Ferdinand Lassalle. Nel programma di Gotha si stabiliva infatti una retrospettica filiazione non certo con l’Associazione internazionale dei lavoratori e la Comune di Parigi, ma proprio col giacobinismo, con certi passaggi dottrinari, in particolare di Robespierre e Saint-Just.
D’altronde Trotsky non ha complessi quando risponde con l’opuscolo Terrorismo e comunismo al pamphlet Comunismo e terrorismo di Kautsky. Nei resoconti delle sessioni del Komintern si dà documentazione dei dibattiti sull’opportunità di ricorrere in talune circostanze a combinazioni e dosaggi di terrore come ingrediente dell’azione. In alcuni suoi passi Lenin argomenta la necessità di instaurare forme di terrore poliziesco, anche come antidoto e argine a una violenza spontanea insorgente, che altrimenti avrebbe fatto scorrere fiumi di sangue ancor più grandi (vengono in mente in questo caso Bronte, la repressione spietata gestita da Bixio, e altrove le osservazioni di Foucault – nel Dialogo con i maoisti e in Microfisica del potere – sulla violenza rivoluzionaria che quando si istituzionalizza in tribunali e carceri si trasmuta nel suo contrario).
Ma queste cose Adriano Sofri le conosce meglio di me. Cionondimeno si è lasciato andare ad una stucchevole danza del ventre rivendicando non l’esistenza di una differenza (quella sì, fondata su una diversità di strategie e tattiche nell’uso della violenza politica, oltreché sugli obbiettivi), ma la presenza di una superiorità morale, di una qualità che distinguerebbe la vicenda Calabresi dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70. A suo avviso il movente dell’indignazione – che per civetteria definisce «privata», ma che vuolsi chiamare civile – sarebbe stata moralmente superiore – e per questo esente dall’infamia d’essere una pratica ritenuta terrorista – a qualsivoglia altra motivazione politica, come quella legata alla pedagogia della «lotta armata per il comunismo». Egli sembra suggerire una definizione della categoria di terrorismo a partire dal movente, per cui l’omicidio ingenerato da indignazione civile ne sarebbe esente e dopo ripetute contorsioni, correzioni, rettificazioni e sfumature via, via aggiunte, arriva anche a precisare quanto da sempre sostenuto dal marchese di Lapalisse: esiste una violenza che non è violenza politica (vedi la strage di Erba), e una violenza politica che non è terrorismo (Corriere della sera del 16 settembre).
Addirittura per rafforzare il suo ragionamento cerca appoggi nelle parole dei giudici che lo hanno condannato, interpretando la mancata applicazione dell’aggravante per «fini di terrorismo ed eversione dell’ordine costituzionale» come il riconoscimento, anche da parte della magistratura, della natura «privata» e non eversivo-terroristica dell’omicidio Calabresi. Argomento, questo, ribadito con ancora maggiore nettezza da Giuliano Ferrara sul Foglio del 22 settembre: «Chi ha ucciso il commissario non aveva un piano terroristico per attaccare il cuore dello Stato, bensì vendicare la morte dell’anarchico Pinelli. Sono due cose completamente diverse, il terrorismo e l’assassinio di Luigi Calabresi».
Errore davvero macroscopico, visto che le leggi speciali dell’emergenza sono state varate sette anni dopo l’attentato, e che dunque la magistratura non poteva qualificare retroattivamente l’uccisione di Calabresi come un atto di sovversione dell’ordinamento costituzionale (come d’altronde avvenne anche per il sequestro Sossi e altri episodi analoghi fino al rapimento Moro), o applicare l’articolo 280 del codice penale, riscritto sempre nel 1979, (attentato con finalità di terrorismo o eversione), piuttosto che il generico 575, omicidio di diritto comune.
Come se non bastasse, nel tentare un parallelo Sofri non trova di meglio che richiamare una delle azioni gappiste più importanti della Resistenza: l’uccisione di Giovanni Gentile. Un episodio che nulla ha di “esclusivo” ma che si iscrive nella strategia della lotta armata urbana condotta dai Gap. Insomma se uno dei requisiti del terrorismo è quello di avere una strategia, e dunque una sua riproducibilità nella azioni – come pare voler suggerire Sofri –, quello dei Gap era terrorismo anti-nazifascista, né più né meno, come si è ritenuto che fosse – a partire da un certo momento in poi – per Prima linea e le Brigare rosse.
Toccherà agli storici futuri stabilire se la lotta armata degli anni 70 lo fu davvero, perché dal punto di vista del diritto non esiste una definizione universalmente riconosciuta, a meno che non si voglia prendere per buona quella offerta dai testi dell’Fbi o del Pentagono. Ciò che invece suscita sconcerto è il fatto che una vendetta, come l’uccisione di Calabresi, qualcosa che si apparenta ad una supplenza soggettiva della giustizia statale, all’epoca per giunta rifiutata da Sofri stesso, una sentenza di morte applicata sulla base di una colpevolezza stabilita sulla scorta di una vox populi, senza nemmeno la farsa di un processo popolare e addirittura considerata oggi un “errore giudiziario”, come lo stesso Sofri scrive, possa essere ritenuta un gesto più nobile degli attentati successivi.
Quello che già allora molti di noi ritennero una forma di giustizierismo politico ci fa orrore, tanto più quando in quell’episodio si arriva ad intravedere un segno del torvo giustizialismo impregnato del paradigma della colpa che sarebbe arrivato 36 anni dopo.
Scriveva Lissagaray, il comunardo che riuscì a scrivere una storia al presente della Comune di Parigi: «Chi diffonde tra il popolo false leggende rivoluzionarie, e lo diletta di storie cantanti, è altrettanto nocivo che il geografo che indirizzi ai naviganti delle carte nautiche che mentono».