L’imponente lavoro realizzato da Sergio Luzzato sull’insediamento delle Brigate rosse a Genova solleva un problema storiografico importante: l’arrivo della Brigate rosse è un parto degli intellettuali radicali della università di Balbi, come sostiene l’autore, oppure prende avvio all’Ansaldo e in porto, come riferiscono alcuni testimoni chiave, protagonisti di quella vicenda?
di Paolo Persichetti
Bisogna riconoscere grande coraggio a Sergio Luzzato per aver provato a ricostruire la storia della colonna genovese delle Brigate rosse fin dalla copertina che ha scelto per il suo volume, Dolore e furore, una storia delle Brigate rosse, appena uscito per Einaudi, titolo suggerito da una sferzante critica indirizzatagli da Rossana Rossanda nel 2010. L’immagine, molto bella, ripresa da una elaborazione grafica di una foto di Viktor Bulla, è stata realizzata da Carlo Rocchi, uno pseudonimo dietro al quale si celava Livio Baistrocchi, ex di Potere operaio, artista di formazione, divenuto uno dei brigatisti più importanti della colonna genovese, latitante da oltre 40 anni.
La «Legera»
Uno dei maggiori meriti di Luzzato è l’imponente mole documentale raccolta, una ricchezza che fornisce al lettore e allo studioso infiniti spunti e poi la dovizia descrittiva che lo ha portato a immergere – com’è giusto che sia – quella vicenda in una ancora più grande: la storia della città di Genova tra gli anni 60 e 70. Una impresa di oltre 700 pagine da cui è scaturito un affresco vivido di biografie, percorsi, colori, idee, immagini, situazioni, storie che sono al tempo stesso ritratto sociologico, culturale, politico, etnografico di Zena. Le duecento pagine iniziali sono senza dubbio, insieme al taglio letterario della prosa e all’intreccio dei percorsi biografici, la parte più riuscita del libro. Dal porto, cuore pulsante, alle sue fabbriche, a Balbi, l’università con i suoi intellettuali ultraradicali; dai marginali della Garaventa, nave di correzione minorile, alla nuova classe operaia che anche a Genova, come negli altri poli del triangolo industriale, si era popolata di giovani migranti meridionali insofferenti alla disciplina del partito e del sindacato che spesso si sovrapponeva a quella dell’impresa, fino a raccontarci del conflitto sulla «Legera». Uno scontro di culture, una distanza antropologica che aveva messo contro le vecchie maestranze super professionalizzate, impregnate di ideologia del lavoro, di «doverismo morale» e fedeltà al Pci e i nuovi arrivati che non volevano sentir parlare di etica del lavoro e mal sopportavano il controllo politico, morale e professionale dei primi. Nuove leve operaie insofferenti alla presenza opprimente dell’attivista sindacale: «che se non lavori come lui desidera, va dal capo e dice che sei una legera e gli chiede di prendere provvedimenti, che se vai sottomutua o se sei un estremista comincia ad odiarti e a farti dispetti. La possibilità di organizzare gli operai estremisti e leggere è dunque sistematicamente spezzata dalla presenza capillare degli operai super professionalizzati».
Luzzato non si ferma qui, ci descrive la presenza della chiesa reazionaria e anticonciliare del cardinale Siri e il suo contraltare: i preti di strada come don Gallo, allontanato dalla Garaventa perché inviso per la sua pedagogia radicale, la comunità del Molo, circoli come il clan della Tortilla che furono incredibili crogioli, le idee dei basagliani che si facevano strada, gli intellettuali non più organici come l’avvocato Edoardo Arnaldi, Sergio Adamoli, medico chirurgo al san Martino, che tanti brigatisti ha rappezzato, figlio di Gelasio sindaco partigiano della città nel secondo dopoguerra, membro del Pci al pari di Giovanni Nobile, dirigente della federazione che vide la figlia Marina tra gli effettivi della colonna genovese. Gianfranco Faina l’enfant prodige della Fgci genovese che rigetta la carriera già pronta nel Pci per costruire la sua via alla rivoluzione sulle tracce di un comunismo libertario, dietro di lui molto più defilato Enrico Fenzi, il suo amico Andrea Canevaro che intreccia la sua biografia con quella di Giovanni Senzani, di cui Luzzato segue ostinatamente le orme genovesi antidatandone erroneamente l’ingresso nelle Br. Lungo questo tragitto, l’autore incrocia di nuovo Guido Rossa a cui aveva già dedicato una monografia, per rivelarne senza reticenze il lavoro informativo condotto in fabbrica per conto di un apparato riservato di controllo e contrasto della lotta armata messo in piedi dal Pci.
Chi era Dura?
Luzzato racconta al lettore con un’apprezzabile trasparenza l’origine della sua curiosità per gli anni genovesi della lotta armata, quando nel 1985, giovane ricercatore, scorgeva chini sui tavoli dell’allora biblioteca nazionale Richelieu di Parigi alcuni fuoriusciti italiani degli anni ’70. Raffrontare le loro biografie di sconfitti con quelle dei rivoluzionari francesi fuggiti a Bruxelles l’intrigava, si domandava se anch’essi fossero «assediati dalla loro propria memoria», se «continuamente riabitassero il passato degli anni di piombo, per difendersi dal presente nel presente», per scoprire come i loro predecessori parigini: «quanto la posterità fatichi a essere imparziale». L’altro interrogativo dell’autore riguarda la figura di Riccardo Dura, narrato da sempre come un «fantasma». Chi era veramente? Da dove veniva? Il volume parte dall’unica traccia istituzionale conosciuta sul giovane: il fascicolo psichiatrico che racconta i suoi due internamenti nel manicomio di Genova Quarto e poi gli anni nella Garaventa, la nave correzione per minorenni in difficoltà. Le perizie mediche ritrovate e le interviste con i dottori che lo visitarono rendono giustizia della leggenda nera costruita dai criminologi del tribunale e da alcuni pentiti dopo la sua esecuzione a freddo del marzo 1980. Adolescente in difficoltà, in conflitto con una madre possessiva ma al tempo stesso anaffettiva, il ragazzo non aveva sopportato la separazione dei genitori. Gli scontri in casa erano sempre più accesi e la madre non trovava di meglio che chiamare i carabinieri col risultato di farlo internare. Inizia così, in una società dove ancora non si era affermata la rivoluzione basagliana, l’infelice tragitto di questo adolescente con il mondo contro. Il racconto di Luzzato in questa prima parte è empatico, tifa palesemente per il ragazzo che studia anche con profitto, sperando che alla fine riesca a venirne fuori. E Riccardo ce la fa, uscito dalla Garaventa ormai diciottenne recide ogni legame materno e si imbarca come marittimo nella scala più bassa dei lavori del mare: mozzo o ragazzo da camera.
La colonna genovese è nata tra gli universitari di Balbi?
Sorge qui il primo problema storiografico posto dal libro di Luzzato: non riuscendo a trovare tracce significative di Dura al porto, salvo alcuni rollini con i suoi numerosi imbarchi, l’autore ricostruisce una genealogia della colonna genovese seguendo biografie intellettuali che invece hanno lasciato dietro di sé molta documentazione e anche auto-narrazioni. Dura riappare solo nel racconto di Andrea Marcenaro che l’accoglie in Lotta continua tra l’agosto del 72 e il settembre del 1973, quando preferisce andarsene perché non condivideva la distanza mostrata verso il gruppo XXII ottobre. Senza Dura e senza le fabbriche inevitabilmente l’università di Balbi si ritrova al centro della trama della futura colonna con le figure intellettuali di Faina e Fenzi, il primo importante, il secondo semplice gregario, e più in là Senzani che, contrariamente a quanto tenta di dimostrare Luzzato, entrerà nelle Br solo nel 1979 a Roma quando prenderà la responsabilità del Fronte carceri, oppure Adamoli e Arnaldi, certamente con un ruolo più significativo nello sviluppo della colonna. Un récit che ricalca la teoria dei «cattivi maestri», del ruolo nefasto degli intellettuali, del loro veleno ideologico senza il quale tutto non sarebbe potuto nascere, tanto caro al generale Dalla Chiesa. Per Luzzato se la storia delle Br era stata fatta, come gli aveva scritto Rossanda nella critica mossagli anni prima, «da persone un po’ qualsiasi», operai, tecnici, studenti, giovani delle periferie, a Genova le cose sono andate diversamente: «intorno a un chirurgo come Sergio Adamoli, a uno storico come Gianfranco Faina, a un filologo come Enrico Fenzi, le parole sono diventate pietre».
All’Ansaldo qualcuno già guardava alle Br
Il volume ruota attorno a questa convinzione nonostante Luzzato stesso dissemini alcuni indizi che mettono in dubbio la sua tesi: nel dicembre del 1973 nello stabilimento di Sampierdarena dell’Ansaldo Meccanico Nucleare viene distribuito un volantino identico a quello diffuso a Torino per il sequestro del capo del personale Fiat Amerio rapito dalle Br, salvo differire nel titolo: «Oggi Amerio, domani Casabona». Effettivamente Vincenzo Casabona, capo del personale dell’Ansaldo verrà rapito dalla colonna genovese delle Brigate rosse il 23 ottobre del 1975. Chi aveva diffuso quel volantino aveva già dei contatti con le Brigate rosse.
Nel 2012, Augusto Viel della XXII ottobre racconta nel libro di Donatella Alfonso di aver conosciuto Riccardo Dura nel 1967, quando questi era ancora diciassettenne, insieme a Giuliano Naria in un circolo marxista-leninista di Pegli, davanti a Porto, fondato dal partigiano Agostino Marchelli. Dopo il suo arresto Dura era sempre andato a trovare la madre, sfidando i controlli e quando fu massacrato questa lo pianse come un figlio.
La versione di Moretti: «No, le Br genovesi sono nate al Porto e all’Ansaldo»
Lo storico Davide Serafino nel suo saggio del 2016 sulla colonna genovese ha spiegato come Dura avesse seguito da vicino l’intera vicenda della cosiddetta XXII ottobre, che poi altro non era che il Gap genovese del gruppo Feltrinelli, e ricorda che Naria, dopo l’esperienza in Lotta continua, fece uscire con il collettivo operaio dell’Ansaldo un foglio che appoggiava il sequestro Sossi. A queste testimonianze preesistenti e che Luzzato incomprensibilmente sorvola si aggiunge la versione di Mario Moretti, da me raccolta nel corso dei diversi colloqui che ho avuto con lui nell’ultimo decennio: a chiamarlo a Genova furono Giuliano Naria, che aveva una sua rete all’Ansaldo, e Riccardo Dura dal porto. D’altronde i vasi erano comunicanti, come abbiamo visto i due già si conoscevano. Un copione consolidato che già si era svolto a Torino e poi si ripeterà a Roma con i militanti di alcune strutture politiche delle periferie, a Napoli con Bagnoli. La Brigate rosse sono arrivate a Balbi solo in un secondo momento – precisa Moretti – per incontrare Faina e il suo gruppo, a cui Dura si era legato. Entrarono così anche Fulvia Miglietta e Livio Baistrocchi. Figura incontornabile nella scena politica rivoluzionaria genovese, Faina non fu mai veramente integrato nella colonna, «non per ragioni ideologiche» ma per questioni pratiche: l’emergere di riserve e lamentele interne alla nascente colonna legate alla sua inadattabilità alla guerriglia urbana che ne provocarono l’esclusione, con suo grande rammarico e dolore. Determinante fu poi l’arrivo di Rocco Micaletto che con la sua esperienza strutturò la colonna mentre Moretti, chiamato nella Capitale, si spostò per costruire la colonna romana. Ma c’è un fatto che Moretti sottolinea con forza: «se le Br a Genova catturano per poche ore, processano e poi lasciano libero il Capo del Personale della fabbrica Ansaldo Meccanico Nucleare, come si può pensare che una cosa del genere sia stata possibile se non perché sei già lì, radicato nelle vertenze tra operai e padroni di quella fabbrica, perché ci vivi e lavori gran parte della tua vita, mica perché l’hai letto sui giornali. Guarda caso Giuliano Naria è un operaio dell’Ansaldo. Non è forse questo un buon punto di partenza per fare “storia” sulla genesi della colonna genovese delle Brigate Rosse? Tutti dimenticano che questi compagni erano dei ragazzi di ‘movimento’, che si erano formati in pochi mesi nel grande e vario movimento rivoluzionario di quegli anni».
Giovani operai molto lontani dall’idea di dolore e furore indicata nel titolo. Al pari di Giuliano Naria che venne espulso da Lotta continua perché fumava hascisc, anche Riccardo Dura fumava come tutti gli uomini di mare. Prima di entrare in clandestinità con le Br – racconta sempre Moretti – fece una chiusa di tre giorni fumando hashish in continuazione. Una specie di addio al celibato. Naria probabilmente non smise mai, Moretti ricorda la sua visione orgiastica della rivoluzione dove il proletariato avrebbe dovuto assumere i vizzi della borghesia abolendone solo le virtù. Schizzi di vite che sgretolano il cliché costruito attorno all’unica colonna che aveva arruolato un anarchico ma è stata dipinta come «stalinista, cubo d’acciaio, fantasma senza radici».
Chiaroscuri
Nella seconda parte del volume Luzzato scrive pagine che sconcertano il lettore, inspiegabili scivoloni metodologici che allontanano l’autore dal rigore storiografico dimostrato nel racconto della società genovese. Che senso storico ha rilanciare domande, senza approfondimenti personali e documentazione, ma solo sulla scorta della letteratura dietrologica, sulla reale prigione di Moro e sul numero e l’identità dei brigatisti in via Fani? Nonostante questi incidenti il lavoro di Luzzato è importante perché offre una lezione fondamentale: non può esserci storia degli insediamenti territoriali delle Brigate rosse senza un adeguato approfondimento della temperie sociale, culturale e politica che le ha viste nascere.

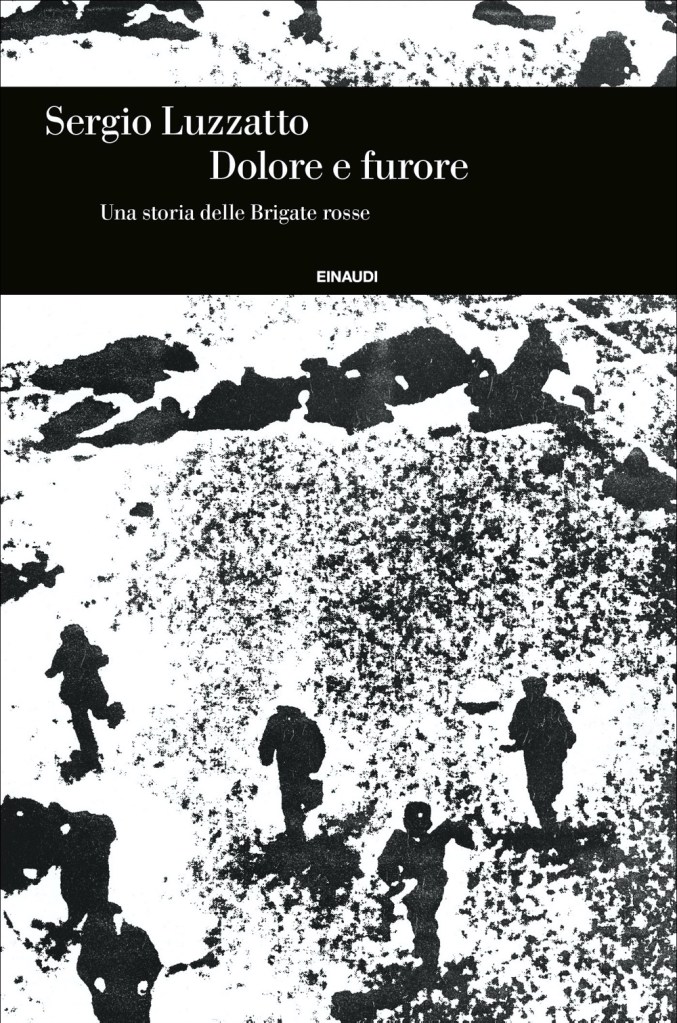

 crescente, invasione delle popolazioni senza risorse. Lotta senza quartiere contro il crimine, tolleranza zero, giudiziarizzazione sempre più estesa della vita sociale e politica, ma legge ed ordine possono arrivare a dominare queste nuove contraddizioni e sfide? O al contrario siamo di fronte ad una cinica panoplia di argomenti che fanno della paura, dell’angoscia e dell’ansia, dei nuovi ingredienti del mercato politico? Dispositivi ansiongeni, deliri sicuritari, demagogia giudiziaria, non rischiano forse di rivolgersi contro i loro promotori al pari di una medicina che uccide il malato?
crescente, invasione delle popolazioni senza risorse. Lotta senza quartiere contro il crimine, tolleranza zero, giudiziarizzazione sempre più estesa della vita sociale e politica, ma legge ed ordine possono arrivare a dominare queste nuove contraddizioni e sfide? O al contrario siamo di fronte ad una cinica panoplia di argomenti che fanno della paura, dell’angoscia e dell’ansia, dei nuovi ingredienti del mercato politico? Dispositivi ansiongeni, deliri sicuritari, demagogia giudiziaria, non rischiano forse di rivolgersi contro i loro promotori al pari di una medicina che uccide il malato?
 riconoscimento residuale della natura politica di alcune infrazioni. Due di queste nuove qualificazioni (esse sono state riassunte in tredici punti) attirano in modo particolare l’attenzione:
riconoscimento residuale della natura politica di alcune infrazioni. Due di queste nuove qualificazioni (esse sono state riassunte in tredici punti) attirano in modo particolare l’attenzione:  sindacalisti della Cgt o le azioni di disobbedienza civile della confederazione paesana di José Bové, come la distruzione di coltivazioni di Ogm, i raids dei portuali o delle coordinazioni rurali e dei cacciatori; tutti costoro avrebbero già largamente commesso azioni da considerare, secondo i nuovi criteri, degli «atti terroristici», al pari dei cattivi per antonomasia, i militanti che di volta in volta si raccolgono nel famoso Black bloc.
sindacalisti della Cgt o le azioni di disobbedienza civile della confederazione paesana di José Bové, come la distruzione di coltivazioni di Ogm, i raids dei portuali o delle coordinazioni rurali e dei cacciatori; tutti costoro avrebbero già largamente commesso azioni da considerare, secondo i nuovi criteri, degli «atti terroristici», al pari dei cattivi per antonomasia, i militanti che di volta in volta si raccolgono nel famoso Black bloc.