Giovanni Barozzino, operaio, delegato Fiom della Sata-Fiat di Melfi, licenziato e poi reintegrato dalla magistratura del lavoro risponde alle accuse anonime pubblicate da Panorama: «“Panorama” scrive il falso. Antisindacale è la Fiat»
Paolo Persichetti
Liberazione 5 settembre 20120

Sergio Marchionne ha l’ambizione di passare alla storia come un grande innovatore. Ma non sarà certo il freeweare, l’abbigliamento informale sui luoghi di lavoro, il maglioncino al posto della cravatta, roba per chi pensa che il ’68 sia stato una moda vestimentaria che ha mandato in soffitta colletti inamidati e cravatte, che marcherà la memoria dei posteri. Il manager che parla di filosofia, il grande guru della «qualità totale», verrà ricordato come l’inventore di un nuovo modello di relazioni in fabbrica: le delazioni industriali. Il settimanale Panorama pubblica questa settimana, con tanto di foto in prima pagina e titolo “Gli eroi bugiardi”, un servizio a firma di Antonio Rossitto che copovolge totalmente la ricostruzione dei fatti sancita dalla magistratura del lavoro e che ha portato al reintegro nello stabilimento dei tre operai della Fiat-Sata di Melfi, licenziati dall’azienda dopo uno sciopero e un corteo interno perché accusati di aver sabotato le linee di produzione ostacolando lo scorrimento dei carrelli.
Ma lo fa sulla base di tre testimonianze rigorosamente anonime. Un fatto giustamente percepito dai lavoratori come una intimidazione mafiosa, un messaggio obliquo, roba da padroni che fanno i padrini. Alcuni degli “anonimi” si presentano come delegati sindacali concorrenti della Fiom. Ed è tutto dire. Che sia la dimostrazione di quella «complicità» sindacale auspicata dal nuovo modello delatorio di relazioni industriali?
L’anonimato, prova a raccontare il settimanale, sarebbe giustificato dal «pesante clima d’intimidazione e violenza» che si vivrebbe in fabbrica ad opera dei lavoratori aderenti alla Fiom per poi subito doversi smentire riconoscendo che «la gente pensa che dobbiamo schierarci con i tre [licenziati] a prescindere», «stanno tutti con la Fiom», «All’interno dello stabilimento, dopo che il giudice ha dato ragione alla Fiom, tutti sono schierati con gli operai licenziati». Sempre secondo i tre anonimi, persino nei paesi dove risiedono la popolazione è schierata con gli operai licenziati.
Certo l’anonimato non è un bel modello di trasparenza e quanto a valenza probatoria è pari a zero. Lo dovrebbe sapere molto bene il settimanale di casa Berlusconi che di processi se ne intende. Che cosa direbbe mai l’attuale inquilino di palazzo Chigi di fronte ad un eventuale tentativo di portarlo in giudizio sulla base di denunce anonime?
Nel corso di una conferenza stampa, tenuta ieri mattina a Rionero in Vulture (Potenza), la Fiom e i tre operai hanno annunciato querela in sede penale e civile contro la pubblicazione di «notizie dal contenuto altamente diffamatorio e che travisano la realtà dei fatti già accertata dal giudice del lavoro che ha condannato la Fiat per comportamento antisindacale». Giovanni Barozzino, uno dei tre licenziati e poi reintegrati, «il delegato più votato in fabbrica», come dice uno dei tre delatori, è abituato a parlare a viso aperto e ribadisce al telefono che «la sera dello sciopero interno, prim’ancora che si sapesse delle sospensioni cautelative dal lavoro di noi tre, tutti i delegati Rsu presenti, cioè Fim, Fiom, Uilm, Ugl, firmarono una lettera in cui si spiegava che lo sciopero e il corteo si erano svolti nel pieno rispetto delle regole».
Allora da dove sono usciti fuori questi tre testimoni anonimi che dicono di essere anche sindacalisti, addirittura presenti quella sera?
Non lo so. Quelli presenti dopo l’atteggiamento provocatorio del preposto aziendale che aggredì verbalmente uno dei lavoratori, non solo hanno tutti sottoscritto un documento in cui si rigettavano le sue accuse, consegnato all’azienda appena mezz’ora dopo l’episodio, ma l’intera Rsu compatta si è poi recata sulle linee per rassicurare il lavoratore aggredito.
Cosa era accaduto esattamente?
Ad un certo punto del corteo ho sentito il preposto aziendale inveire in modo violento e autoritario contro uno dei lavoratori, poi licenziato. Sono intervenuto dicendogli che non aveva alcuna autorità per rivolgersi contro di lui in quel modo, minacciandolo addirittura di licenziamento. Per altro Marco è un ragazzo molto sensibile, più giovane di noi, sta soffrendo molto questa esperienza. In questi giorni ha anche avuto un malore per lo stress.
Ma allora questi testimoni sono dei fantasmi?
Il giornalista di Panorama descrive un quadro aziendale, il terzo anonimo dell’intervista, che avrebbe incontrato sempre in maniera furtiva a fine turno di lavoro, come uno che «odora ancora di sudore e di lamiera». Scrive proprio così, sudore e lamiera. Ora, con tutto il rispetto per i diversi ruoli che si hanno nel lavoro, a puzzare di sudore e di lamiera sono gli operai non i quadri.
Dunque la vostra impressione è che si tratti di una montatura?
Non penso che sia solo la nostra. Noi comunque non vogliamo prestarci a questo gioco. E’ una trappola dentro la quale vogliono farci cadere. Non abbiamo fatto alcun sabotaggio. Chi ha avuto un comportamento antisindacale è stata la Fiat. Lo ha detto una sentenza ed a quella ci atteniamo.
Link
Fumi di democrazia
Maggiordomi Fiat: quando Piero Fassino si dichiarava alleato di Marchionne
Romiti, “A Marchionne dico: operai e azienda, la contrapposizione di interessi ci sarà sempre”
Perché a Romiti non piace il capitalismo di Marchionne
Cronache operaie
Delazioni industriali: la nuova filosofia aziendale di Marchione
Disobbedienza e lavoro in fabbrica, la questione etica degli operai Fiat a Melfi
1970, come la Fiat schedava gli operai


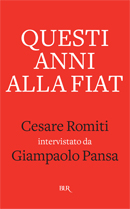

 stabilimenti». Un avvertimento che sapeva quasi di ricatto. Si sa, il governo Berlusconi non è molto amico della Fiat. Espressione di una fazione opposta della borghesia di questo Paese, che raccoglie un blocco sociale composto da ceti imprenditoriali medio-piccoli e colossi legati alla produzione di valore simbolico e alla distribuzione, attraverso il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola aveva replicato in termini molto cauti, rinviando la decisione «a fine novembre, quando avremo i risultati finali». Ieri però, Berlusconi, è stato più esplicito. In diretta su Sky Tg24 mattina ha assicurato che sugli incentivi «il governo non si tirerà indietro». Una piccola svolta nel braccio di ferro, in corso sotto banco da tempo, fra le case automobilistiche che spingono per riavere gli incentivi alla rottamazione anche nel 2010». Soddisfatto per le dichiarazioni del premier, Marchionne ha subito precisato che il sostegno ai consumi per l’acquisto di auto è necessario per un paio d’anni ancora, anche se poi «bisogna trovare – ha aggiunto – il metodo per una uscita graduale da questi incentivi». Sempre secondo l’amministratore delegato Fiat il governo dovrebbe defiscalizzare anche l’acquisto di veicoli commerciali per sostenere «l’attività di artigiani, commercianti e autotrasportatori». Il segretario del Prc Paolo Ferrero ha censurato duramente l’annuncio di Berlusconi: «gli incentivi promessi – ha detto – nascondono la solita regalìa dei governi di tutti i colori alla Fiat. Mai una volta che i soldi elargiti sotto forma d’incentivi vengano concessi ai lavoratori», attraverso l’aumento dei salari o sotto forma di riduzioni fiscali sul lavoro dipendente e le pensioni. Questi incentivi avranno un’efficacia limitata sull’economia nazionale perché già ora un terzo della produzione Fiat si svolge in Polonia, ha ricordato Enzo Masini (Fiom auto). Non solo, Marchionne, che rifiuta di sedersi al tavolo delle trattative con la Fiom, incassa gli incentivi senza fornire garanzie sui livelli occupazionali e il mantenimento degli stabilimenti.
stabilimenti». Un avvertimento che sapeva quasi di ricatto. Si sa, il governo Berlusconi non è molto amico della Fiat. Espressione di una fazione opposta della borghesia di questo Paese, che raccoglie un blocco sociale composto da ceti imprenditoriali medio-piccoli e colossi legati alla produzione di valore simbolico e alla distribuzione, attraverso il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola aveva replicato in termini molto cauti, rinviando la decisione «a fine novembre, quando avremo i risultati finali». Ieri però, Berlusconi, è stato più esplicito. In diretta su Sky Tg24 mattina ha assicurato che sugli incentivi «il governo non si tirerà indietro». Una piccola svolta nel braccio di ferro, in corso sotto banco da tempo, fra le case automobilistiche che spingono per riavere gli incentivi alla rottamazione anche nel 2010». Soddisfatto per le dichiarazioni del premier, Marchionne ha subito precisato che il sostegno ai consumi per l’acquisto di auto è necessario per un paio d’anni ancora, anche se poi «bisogna trovare – ha aggiunto – il metodo per una uscita graduale da questi incentivi». Sempre secondo l’amministratore delegato Fiat il governo dovrebbe defiscalizzare anche l’acquisto di veicoli commerciali per sostenere «l’attività di artigiani, commercianti e autotrasportatori». Il segretario del Prc Paolo Ferrero ha censurato duramente l’annuncio di Berlusconi: «gli incentivi promessi – ha detto – nascondono la solita regalìa dei governi di tutti i colori alla Fiat. Mai una volta che i soldi elargiti sotto forma d’incentivi vengano concessi ai lavoratori», attraverso l’aumento dei salari o sotto forma di riduzioni fiscali sul lavoro dipendente e le pensioni. Questi incentivi avranno un’efficacia limitata sull’economia nazionale perché già ora un terzo della produzione Fiat si svolge in Polonia, ha ricordato Enzo Masini (Fiom auto). Non solo, Marchionne, che rifiuta di sedersi al tavolo delle trattative con la Fiom, incassa gli incentivi senza fornire garanzie sui livelli occupazionali e il mantenimento degli stabilimenti.