Intervento – A proposito della recente polemica tra Paolo Morando e Vladimiro Satta sul ruolo avuto da parte di apparati e settori dello Stato nella stagione iniziale dello stragismo degli anni 70
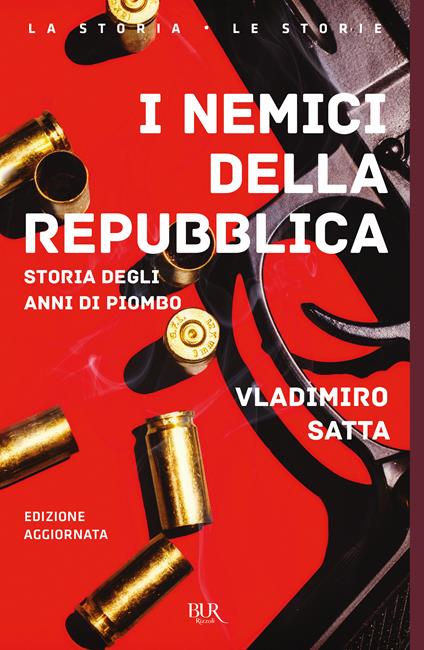
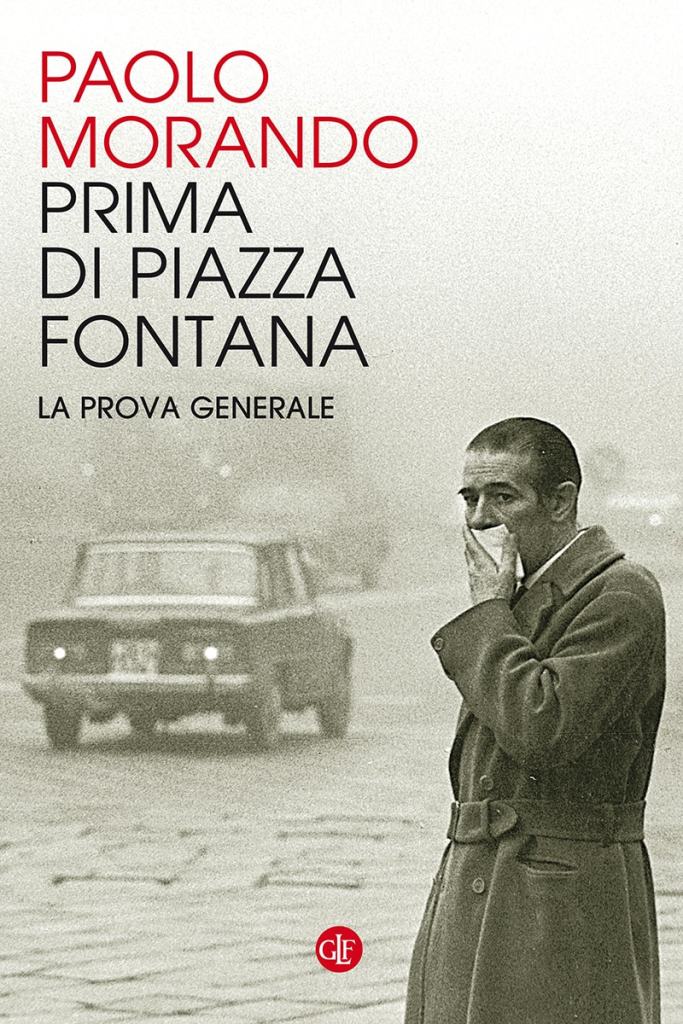
di Paolo Persichetti
Il 6 settembre scorso in un post sulla sua pagina faceboock Paolo Morando ha segnalato una serie di errori fattuali commessi da Vladimiro Satta nella appendice della edizione aggiornata del suo I nemici della repubblica, Rizzoli, 2024 (prima edizione Rizzoli 2016). Inesattezze contenute in alcuni passaggi che criticavano il suo libro del 2019, Prima di Piazza Fontana. La prova generale. Ad avviso sempre di Morando, quegli errori non erano veniali poiché, oltre a chiamarlo in causa, avrebbero ingannato il lettore.
Nella sua replica Satta ha riconosciuto che vi erano delle imprecisioni per poi aggiungere che il vero oggetto della divergenza portava nella diversa «valutazione storica degli attentati minori che nel 1969 precedettero la strage di Piazza Fontana a Milano».
Se per Morando si trattava, con la scrupolosa citazione degli episodi, della prova che le indagini furono orientate volutamente nella direzione degli anarchici, valutazione fatta soprattutto alla luce di quanto poi avvenne il 12 dicembre in piazza Fontana, a Milano, all’interno della Banca nazionale dell’agricoltura dove morirono 17 persone dopo l’esplosione di una bomba e altre 88 rimasero ferite. Per Satta invece l’Ufficio politico della questura avrebbe agito senza secondi fini, indotto nell’errore dall’abitudine di alcuni ambienti anarchici a commettere piccoli attentati dinamitardi e soprattutto l’esito finale dei processi, che condusse all’assoluzione di gran parte degli inquisiti, avrebbe smentito la teoria della macchinazione o per meglio dire del pregiudizio politico da parte della questura. Insomma si sarebbe trattato di una legittima indagine che grazie alle garanzie processuali e ai contrappesi costituzionali, commisurò le reali responsabilità sui fatti accaduti.
Il secco botta e risposta (lo potete leggere in fondo) che i due studiosi si sono scambiati, riveste una certa importanza poiché solleva una rilevante questione storica sul ruolo avuto da parte di apparati e settori dello Stato nella stagione iniziale dello stragismo degli anni 70.
L’esplosione di due bombe il 25 aprile 1969, alla fiera campionaria (20 feriti) e alla stazione centrale di Milano, provocò l’arresto di sei persone di area anarchica su impulso di una indagine condotta dal commissario Calabresi. Ai sei vennero contestati complessivamente 18 attentati esplosivi, 12 dei quali considerati «stragi» (ricordo che il reato di strage, trattandosi di reato di pericolo, è punibile sulla sola base delle intenzioni anche se la strage non viene poi commessa e vi sono solo danni materiali, addirittura senza feriti), Vennero anche incriminati per falsa testimonianza e rinviati a giudizio l’editore Feltrinelli e la moglie.
La prima circostanza singolare di questa inchiesta sta nel fatto che nonostante gli arresti siano scaturiti dopo la bomba alla fiera campionaria, i sei non vennero accusati di strage per questo attentato, l’unico che ebbe feriti. Alla fine solo tre dei sei arrestati vennero condannati, tutti a pene molto lievi, per sei episodi minori avvenuti in ore notturne unicamente con danni materiali. Delle altre 12 esplosioni: le due più importanti, quelle del 25 aprile alla fiera campionaria con 20 feriti, e alla stazione centrale, furono – solo anni dopo – attribuite in via definitiva alla cellula ordinovista di Padova guidata da Freda e Ventura; delle altre 10 (minori avvenute in ore notturne, senza feriti), nulla si è mai più saputo.
Ora secondo Satta, l’iter giudiziario con l’assoluzione finale dei più proverebbe che non vi fu alcun intento persecutorio ma solo un fisiologico funzionamento dell’azione di controllo repressivo delle forze di polizia e di verifica della giustizia. «Non si può dire – scrive – che il procedimento giudiziario sia stato persecutorio, e ancor meno che fossero stati dolosamente colpevolizzati gli anarchici per arrivare a Feltrinelli e alla sinistra tutta». Ed è qui che le sue argomentazioni suscitano le prime perplessità: perché se è vero che in sede di dibattimento tutto si sgonfiò, non fu la stessa cosa durante l’inchiesta di polizia e l’istruttoria, che all’epoca era nelle mani del giudice istruttore, il quale – cito le parole di Morando: «si limitò a vidimare l’esito l’esito delle indagini dell’Ufficio politico della Questura di Milano, condotte dal commissario Calabresi, e a rinviare a giudizio tutti gli arrestati, tranne due due, una coppia di amici di Feltrinelli, ritenuti i vertici della cellula terroristica, prosciolti dopo oltre sei mesi di carcere». Ci sono poi altri dettagli che per brevità tralascio rinviando alla lettura completa dei due post chi fosse interessato. Poiché Morando conclude il suo post con un esercizio retorico che lascia al lettore valutare se i fatti accaduti siano stati «una macchinazione o che gli inquirenti fossero tutti dei gran cialtroni, giudichi il lettore», nella replica Satta fa notare che dolo, «la macchinazione», e cialtronaggine non sono la stessa cosa, invitando Morando a decidere su quale delle due optare.
Ha ragione Satta a sottolineare che il dolo presuppone intenzionalità mentre la cialtronaggine solo colpa, anche se ciò non esclude che le due cose possano marciare insieme. La vita reale è piena di “dolosi cialtroni” e viceversa. Vengono alla mente alcuni esempi clamorosi di altre famose inchieste, come la telefonata di Mario Moretti del 30 aprile 1978 attribuita alla voce di Toni Negri o quella del 9 maggio successivo di Valerio Morucci imputata a Pino Nicotri… Il risultato finale cambia poco.
In realtà quello che più sorprende negli argomenti proposti da Satta è la convinzione che l’assoluzione finale dissolva ogni cosa impedendo di evocare il dolo.
Questa convinzione mostra una certa confusione tra attività di polizia, funzione inquirente (all’epoca vigeva il rito istruttorio) e attività giudicante. Ora, se la funzione giudicante corregge in sede di dibattimento i comportamenti scorretti, inesatti o altro che possano accadere nelle prime due istanze, il dolo permane sempre seppur ridimensionato. Un arresto, una perquisizione, un sequestro, una indagine e figuriamoci un periodo di carcere, anche in presenza di un’assoluzione finale non sono elementi neutri sia sul piano del danno personale che dell’effetto politico e sociale, nella fattispecie lo stigma gettato sulla sinistra e gli anarchici.
Lo Stato non è un corpo unico, ma un apparato complesso attraversato da forze, campi, culture e tensioni. All’epoca poi stava emergendo un rinnovamento sociologico all’interno della magistratura, grazie ai nuovi concorsi che avevano permesso l’ingresso di nuovi ceti sociali che avevano interrotto la continuità di ceto e cultura con l’epoca fascista, cosa che non era avvenuta ancora nella polizia e nei servizi. Questo spiega le ragioni della rottura di quella omogeneità d’ambiente che in precedenza compattava la sfera statale e la presenza di possibili divergenze finali sugli esiti processuali.
Per un democratico-liberale di scuola rosselliana come Satta, l’indagine, l’arresto e l’incarcerazione di una persona, peggio più persone, anche se alla fine si conclude con un’assoluzione dovrebbe apparire come un fattore patologico, non fisiologico del sistema giustizia e del funzionamento dello Stato.
Nella vicenda di cui trattiamo, oltre all’ufficio politico della questura di Milano a un certo punto interviene in massa l’Uaarr che nei giorni di piazza Fontana si sposta da Roma e occupa gli uffici della questura meneghina. Una circostanza tenuta riservata per quasi 30 anni e venuta alla luce solo dopo il ritrovamento dell’archivio Russomanno in Circonvallazione Appia. Cosa ci sarebbe di nornale – come sostiene Satta – in una presenza mantenuta segreta anche dopo le idangini sulle circostanze della morte del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli? Neppure Calabresi ne fece mai cenno, eppure rivelarla l’avrebbe sollevato dal sospetto di un ruolo diretto nella morte dell’anarchico. Il ferroviere fermato, anzi che aveva seguito col suo motorino il commissario Calabresi che conosceva e gli aveva chiesto di venirgli dietro in ufficio, dove rimase trattenuto illegalmente, cioè oltre i termini legali previsti dalla legge – per il codice penale si dice sequestrato – per poi volare da una finestra del quarto piano. Sappiamo che un confidente del Sid (i Servizi segreti dell’epoca) era infiltrato in una cellula ordinovista (gruppo neofascista). Elementi, circostanze, che mostrano in tutta questa vicenda una ingombrante e anomala presenza di corpi dello Stato: tutto regolare, tutto fisiologico?
Satta – semplifico per i lettori – suggerisce la tesi di un ufficio politico che ignaro delle malefatte e dei progetti delle cellule neofasciste, sia stato indotto nell’errore dal fatto che alcuni anarchici facevano esplodere piccoli ordigni e quindi trova normale che il sospetto degli inquirenti si rivolgesse all’inizio nella loro direzione. Sembra dire che il pregiudizio accusatorio fosse in qualche modo fondato: alcuni anarchici mettono le bombe, allora tutti gli anarchici e i loro amici – nella fattispecie Feltrinelli, stiamo parlando del 1969 non del 1972 – le mettono o comunque sono sospetti. Un dispositivo che abbiamo visto in azione con le numerose retate giudiziarie negli anni successivi.
Sappiamo che è questione storiografica aperta il problema del massacro di piazza Fontana: voluto solo dalla cellula padovana di Ordine nuovo, che frustrata dall’indecisione mostrata dalle autorità di governo democristiane nel varare un giro di vite autoritario, avrebbe innalzato il livello della violenza passando alla strage diretta, abbandonando la lunga e documentata serie di attentati con bombe a basso potenziale funzionale alla creazione di un clima di tensione e paura nel Paese? Oppure scelta anche degli apparati, i nostri o di alcuni settori operanti nelle basi Nato? Le domande restano, ci sono risposte diverse ma un fatto certo è il fetente puzzo di omertà, il silenzio, le omissioni, le compromissioni e i non detti che chiamano in causa pesantemente i contesti statali dell’epoca.
Questa è la posta in gioco storiografica che Satta contesta, commettendo anche errori in punto di fatto, poiché egli parte da un presupposto, un assioma da cui discendono le sue conclusioni: lo Stato, o meglio stando al titolo del suo libro «I nemici della Repubblica» (vista l’assenza di aggettivazione anche qui ci sarebbe da ridire, perché i «nemici» da sinistra non erano certo monarchici e dunque la loro ostilità si rivolgeva alla forma statale in sé e al sistema economico-sociale non certo al dispositivo politico repubblicano…), è sempre illibata, pulita, candida e proba. Le istituzioni sono sacre e i suoi uomini santi, guai a lanciare contro di loro qualsiasi accusa, questo a prescindere da qualunque prova. Non a caso Satta gira la testa dall’altra parte davanti alle torture praticate dalle forze di polizia durante le indagini, documentate e oggi anche confessate da uomini dello Stato, per stare ad un solo esempio.
Da qui nasce anche la sua critica alla «dietrologia» mossa unicamente dalla esigenza di tutelare solo la probità delle istituzioni e solo in un secondo momento la verità dei fatti, dei processi sociali, delle dinamiche storiche, sempre se queste non contrastano e mettono in discussione la limpidezza dello Stato. Altrimenti silenzio.
Lo dico con cognizione di causa e un certo dispiacere, essendo stato uno dei pochi, forse addirittura il primo ad aver recensito e valorizzato Satta – (dal carcere) sul quotidiano Liberazione, suscitando polemiche dentro Rifondazione comunista (dove allignavano vecchie posizioni del Pci) nel lontano settembre 2003, (Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico) e averlo continuato a fare negli anni a venire, apprezzando moltissimo i suoi due volumi sulla questione, scritti quando ancora – fresco del suo lavori di documentarista della commissione Stragi – si cimentava con la ricerca documentale. Ma criticare la dietrologia, sacrosanta attività, fondamentale impegno in questo Paese intossicato, non vuol dire rinunciare alla critica sempre e comunque.
Ps: qui sotto potete trovare in ordine cronologico gli interventi dei due studiosi.
Paolo Morando
*Post lungo, per fatto personale*
Nell’edizione aggiornata di “I nemici della Repubblica” (BUR La Storia Le Storie giugno 2024, prima edizione Rizzoli 2016), lo studioso Vladimiro Satta commette una notevole serie di errori fattuali. Sono errori che ingannano il lettore e che per me risultano ancora più gravi, poiché su di essi l’autore basa una serie di critiche al mio libro del 2019 Prima di Piazza Fontana. La prova generale.
A pagina 871, la prima della “Appendice 1 – Dal 2016 a oggi” in cui Satta si occupa delle novità storiografiche e giudiziarie intervenute dopo la prima edizione del proprio libro, l’autore cita l’inchiesta ripercorsa in “Prima di Piazza Fontana”, scrivendo così: «Essa verteva su una serie di attentati minori susseguitisi nel 1969 a Milano, prima del 12 dicembre. Furono arrestate persone quasi tutte appartenenti all’area anarchica, rinviate a giudizio il 24 luglio 1970 e il 28 maggio 1972 assolte in ordine a dodici dei diciotto episodi in questione e condannate per i restanti sei, mentre Feltrinelli, che nel corso dell’istruttoria era stato sospettato di falsa testimonianza in favore di una coppia di coniugi suoi amici, era stato prosciolto a conclusione dell’istruttoria stessa come pure i coniugi».
Al di là dell’errore sulla data dell’assoluzione in assise, che avvenne nel 1971 e non nel 1972, l’intera ricostruzione di Satta è gravemente imprecisa. Giangiacomo Feltrinelli non venne sospettato di falsa testimonianza “in favore di una coppia di coniugi suoi amici”, bensì a favore dei due giovani anarchici accusati degli attentati del 25 aprile 1969 alla Fiera campionaria e alla Stazione centrale (il primo provocò una ventina di feriti), e che quella sera erano invece a cena proprio a casa Feltrinelli. Ma soprattutto, l’editore non fu affatto prosciolto in istruttoria. Venne invece rinviato a giudizio e fu processato in contumacia assieme alla moglie Sibilla Melega, accusata dello stesso reato. Entrambi furono poi assolti con la formula più ampia, tanto che la Procura nemmeno ricorse in appello.
È quindi del tutto infondato, oltre che quanto meno pretestuoso, il ragionamento di Satta per cui «Non si può dire, quindi, che il procedimento giudiziario sia stato persecutorio, e ancor meno che fossero stati dolosamente colpevolizzati gli anarchici per arrivare a Feltrinelli e alla sinistra tutta». L’andamento dell’inchiesta e del processo dimostra invece quanto Satta nega. Il giudice istruttore Amati, infatti, si limitò a vidimare l’esito delle indagini dell’Ufficio politico della Questura di Milano, condotte dal commissario Calabresi, e a rinviare a giudizio tutti gli arrestati, con l’esclusione della coppia di amici di Feltrinelli (Giovanni Corradini ed Eliane Vincileoni), ma solo dopo sei mesi abbondanti di carcere e ripetuti no alle loro richieste di scarcerazione per totale assenza di indizi.
Sul tema peraltro Satta è pervicace nel commettere errori, visto che a pagina 872 scrive così: «Quanto al presunto tentativo di risalire dagli anarchici e da Feltrinelli fino al maggiore partito della sinistra, proprio dal libro di Morando si apprende che due di coloro che furono coinvolti nell’inchiesta ma prosciolti a fine istruttoria, Clara Mazzanti e Giuseppe Norscia, non erano anarchici bensì erano iscritti al Pci». Falso pure questo. Mazzanti e Norscia furono arrestati nell’autunno del 1969 e non vennero mai prosciolti, bensì rinviati a giudizio e processati: rimasero continuativamente in carcere fino all’assoluzione del maggio ’71, con formula dubitativa che pure per loro in appello diverrà ampia.
Circa l’iscrizione della coppia Norscia-Mazzanti al Pci, Satta ne trae lo spunto per sostenere che «Questo dato di fatto è incompatibile con l’idea che l’intenzione degli inquirenti o addirittura di manovratori politici alle spalle degli inquirenti fosse danneggiare il Pci; in quel caso, approfittando di Mazzanti e Norscia si sarebbe scatenata subito una pretestuosa campagna anticomunista, che invece non ci fu per niente». Ed è vero, non ci fu, ma proprio perché l’appartenenza della coppia al Pci fu del tutto marginale nelle loro vite, come scrivo ampiamente nel libro. Che Satta ha dunque letto quanto meno distrattamente.
L’esito complessivo di quella disastrosa inchiesta di Calabresi e dell’ancora più disastrosa istruttoria di Amati è attestato dalla sentenza finale: due prosciolti in istruttoria, cinque assolti con formula piena e tre condannati a pene fra i 3 anni e 4 mesi e 1 anno e 4 mesi, ma a fronte di accuse che, per i sei imputati dei diciotto attentati, prevedevano una dozzina di ergastoli. Che sia stata una macchinazione o che gli inquirenti fossero tutti dei gran cialtroni, giudichi il lettore.
Vladimiro Satta
REPLICA A PAOLO MORANDO
Paolo Morando, un anno e mezzo dopo l’uscita dell’edizione aggiornata del mio libro “I Nemici della Repubblica”, mi ha attaccato pesantemente con un post nella sua bacheca FB. Il tema è la valutazione storica degli attentati minori che nel 1969 precedettero la strage di Piazza Fontana a Milano, vicenda cui lui ha dedicato una monografia qualche anno fa. Qui di seguito, la mia risposta a Morando. Chi fosse interessato, potrà leggere cosa ha scritto Morando e commenti vari presso la bacheca sua. << L’indicazione del 1971 come data dell’assoluzione in Assise è stata un refuso, mentre è stato un errore scrivere che Feltrinelli, Mazzanti e Norscia furono prosciolti in istruttoria, poiché in realtà furono assolti in primo grado e, per Feltrinelli, la Procura non ricorse in appello. Prendo atto delle puntualizzazioni di Morando al riguardo e provvederò alle opportune correzioni nelle prossime edizioni de “I nemici della Repubblica”, se ce ne saranno. Detto ciò, la questione fondamentale è – come riconosce Morando stesso nel suo post su FB di sabato 6 settembre- stabilire se il procedimento giudiziario fu persecutorio e colpevolizzò dolosamente gli anarchici per arrivare a Feltrinelli e alla sinistra tutta, oppure no. Nel post, Morando dapprima afferma che <<l’andamento dell’inchiesta e del processo>> dimostrano il dolo a fini politici che io invece nego, ma poi conclude senza prendere posizione tra <<macchinazione>>, che è sinonimo di dolo, e cialtroneria, che è altra cosa dal dolo. Come si vede, l’unica certezza ravvisabile nella visione di Morando è l’avversione nei miei confronti. In attesa che in merito all’interpretazione della vicenda storica e processuale Morando si metta d’accordo con sé stesso, faccio notare innanzi tutto che la presunta dimostrazione del dolo addotta da lui non sta in piedi. Un esito assolutorio non dimostra affatto che ci sia stato dolo da parte degli inquirenti; diversamente, dovremmo immaginare che i complotti orditi quotidianamente in Italia con la complicità della magistratura siano innumerevoli. Neanche Berlusconi arrivava a tanto. Davvero Morando pensa invece che, pur in mancanza elementi quali intercettazioni, testimonianze inoppugnabili, confessioni da parte dei responsabili, documenti probanti eccetera, le assoluzioni siano segno di dolo e ragiona così anche per altri casi? Davvero, ad esempio, di fronte alla pioggia di assoluzioni del secondo processo contro Ordine Nuovo basato su indagini di Vittorio Occorsio (c.d. processo dei 119) Morando parlerebbe di persecuzione dolosa ai danni dei neofascisti? Ha mai sostenuto che i molteplici processi nei quali Paolo Signorelli venne assolto servivano a tentare di screditare il MSI? Se Morando facesse questo, io dissentirei ancora una volta ma, almeno, potrei riconoscergli un po’ di coerenza.
Sull’ipotesi della cialtroneria, piuttosto, in qualche misura potrei essere d’accordo con Morando, come lui ben sa, poiché ne abbiamo parlato più volte, anche pubblicamente. Ma nel post, egli se ne dimentica.
Purtroppo, i buchi nel post di Morando non si limitano a questo. Egli, citando la pag. 872 del mio libro “I nemici della Repubblica”, ha omesso una serie di brani significativi, che qui riporto:
<<la sentenza (…) recepì quasi interamente le richieste del pubblico ministero, Antonino Scopelliti, il quale tempo dopo, ospite di un programma televisivo, dichiarò che il dibattimento aveva “chiarito centomila cose che l’istruttoria non aveva chiarito né forse poteva chiarire. Ecco perché il dibattimento è la fase illuminante del processo” (…) Oltre tutto, all’epoca Feltrinelli aveva già dato prova di non essere un personaggio legalitario e innocuo e perciò, se si fosse voluto colpire lui, lo si sarebbe potuto fare senza bisogno di montature contro gli anarchici. Persino Feltrinelli stesso trovava logico che le inchieste per attentati andassero in direzione degli anarchici; in un’intervista rilasciata alla rivista “Compagni”, datata aprile 1970, egli pur dichiarandosi convinto che tra i “giovani più o meno anarchici” si fossero infiltrati “agenti provocatori e fascisti”, riconosceva che coloro i quali “amano con facilità parlare di bombe, che di tanto in tanto possono anche far esplodere (…) facendo più rumore che danni (…) prestano facilmente il fianco per essere indiziati di atti criminosi come gli attentati di Milano e di Roma” (…) >>.
E sì che Morando conosce l’autorevole parere di Feltrinelli stesso, in quanto -se stranamente gli era sfuggito il noto libro di Panvini “Ordine nero e guerriglia rossa” dove le parole di Feltrinelli sono citate- non può però avere dimenticato il prolungato scambio di commenti su FB tra noi due, con la partecipazione di altri, avvenuto ai primi di marzo del 2022.
A cosa alludeva nel 1970 Feltrinelli, che conosceva personalmente parecchi anarchici e tra questi i giovani Braschi e Della Savia accusati -e infine condannati- per attentati minori effettuati prima della strage di Piazza Fontana? Rispondo con estratti dal volume di Morando “Prima di Piazza Fontana”: l’anarchico Paolo Braschi rivelò all’A. che <<noi non lo abbiamo mai ammesso, ma in effetti c’era questo quantitativo di esplosivo, 40-50 chili, tanta roba (…) una piccola parte la presi io e l’altra la si andò a sotterrare (…) Di attentati ne ho fatti due, più uno che si fece insieme>> ad un <<anarchico di Canosa>> non nominato, poi ancora <<lui ha fatto quelli di Roma>>. Un altro anarchico, Angelo Della Savia, <<ammette gli attentati romani e quelli di Genova con Braschi, racconta anche la sua prima “bombarella” a Milano>>, peraltro stralciata dal processo. Sempre Della Savia a Morando: <<le bombe le abbiamo messe, per cui innocenti innocenti non è che eravamo>>.
Quanto all’appartenenza della coppia Mazzanti-Norscia al PCI, un briciolo di esperienza di vita e/o di conoscenza del passato permette a tutti (o quasi) di comprendere che, ai fini della montatura di una campagna pretestuosa, importa poco o nulla se la suddetta appartenenza utilizzabile come pretesto fosse marginale o centrale.
Per inciso, Feltrinelli non era anarchico, ed era uscito dal PCI circa dieci anni prima dei fatti in oggetto. I suoi rapporti con il partito erano tali da far pensare a molti che lo scopo dell’attentato ad un traliccio a Segrate che lui stava preparando, nel quale perse la vita, fosse provocare un blackout per disturbare il congresso nazionale comunista che si teneva nella vicina Milano. Pertanto, fare leva su Feltrinelli per colpire gli anarchici, o il PCI, o tutti e due, sarebbe stato vano. Infatti non accadde, cosa che Morando non contesta ma dalla quale è incapace di trarre le conseguenze.
In conclusione, ricordiamoci sempre che indagare non è sinonimo di “incastrare” né di dichiarare colpevolezze prima delle sentenze, evitiamo di anteporre sospetti meramente congetturali di macchinazioni alle evidenze e, per quanto possibile, sforziamoci di ricondurre i fatti storici e gli errori iniziali delle inchieste alle loro reali dimensioni e cause.
Paolo Morando
Tocca aggiungere che Satta anche nella risposta al mio post cita erroneamente il mio libro. Parla infatti di un “anarchico di Canosa” con cui Braschi avrebbe compiuto un attentato. Ma Braschi, intervistato (cfr. pagina 317), nel libro non dice affatto quanto Satta gli attribuisce, per giunta tra virgolette






