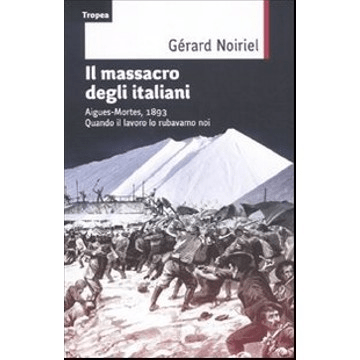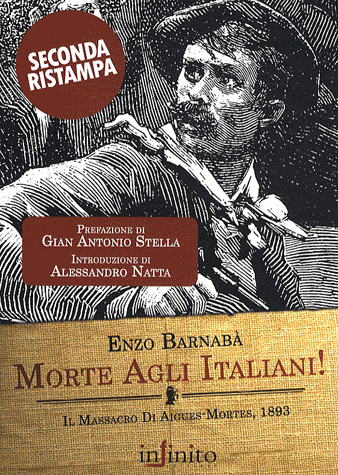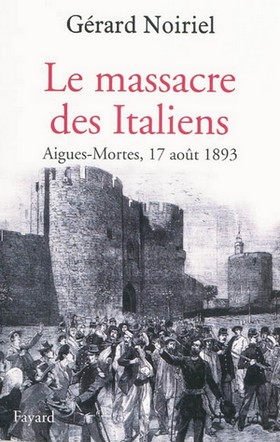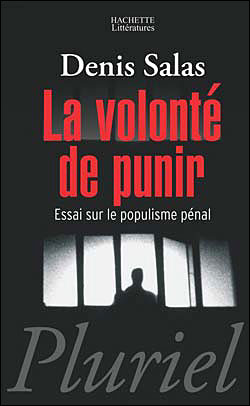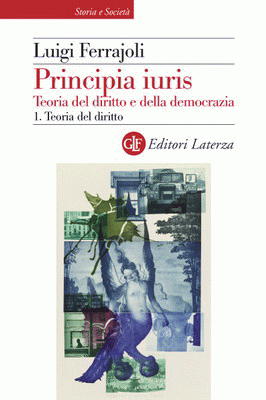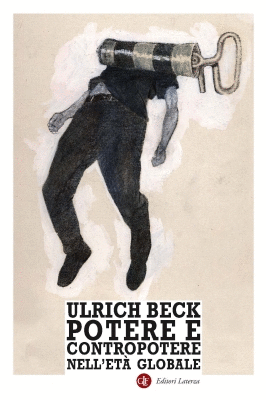La “manipolazione delle coscienze” non appartiene solo alla storia della destra
Stefano Tassinari
Liberazione 21 novembre 2010

In un’epoca storica così mortificante come quella che stiamo vivendo si ha l’impressione di essere dominati da una sorta di populismo diffuso, considerato – da chi lo insegue ideologicamente e cerca di metterlo in pratica quotidianamente – lo strumento più affinato per conquistare e/o mantenere il consenso, spesso coincidente con il potere, più o meno personale. Eppure, anche se oggi, nella nostra realtà italiana, ci viene naturale collegare questo concetto alle posizioni politiche espresse da personaggi quali Berlusconi e Bossi, va ricordato che il termine populismo non solo presenta diverse accezioni, ma non può essere ascritto soltanto al campo politico conservatore e reazionario, tant’è che per molti – sempre per restare nel nostro piccolo ambito nazionale – ad essere considerato un populista per eccellenza è il comico Beppe Grillo, nel suo ruolo di leader del Movimento 5 Stelle. Sotto il profilo storico, come è noto, il movimento populista non venne certo fondato da gruppi reazionari, bensì da rivoluzionari russi che si opponevano allo zarismo intorno alla metà dell’Ottocento; ciò nonostante, l’immagine prevalente che tutti conserviamo è molto più legata a figure della destra autoritaria, dal Benito Mussolini che invitava ad “andare incontro al popolo” (scegliendo volutamente il termine “popolo” per contrapporlo alla parola “classe”) alla coppia formata da Juan Domingo Peròn e da sua moglie Evita.
In sostanza, che l’intervento del popolo venga invocato per rovesciare i dittatori o per mantenerli al potere, alla base rimane un equivoco di fondo, basato sull’idea – molto discutibile – che il popolo detenga per principio i valori giusti e positivi, come se non fosse condizionabile e manipolabile. Ed è proprio l’aspetto della “manipolazione delle coscienze” a spingere la nostra riflessione sul terreno della cultura e della comunicazione, divenuti fondamentali, nello specifico, fin dalla prima metà del secolo scorso (e in tal senso basti pensare al ruolo della radio nella costruzione di un consenso di massa nei confronti del regime fascista). E se Mussolini, dal suo punto di vista, dimostrò di aver capito in fretta le potenzialità di un uso politico della letteratura e del cinema (e lo dimostrano i forti investimenti economici stanziati per costruire gli studi di Cinecittà, per lanciare la Mostra del Cinema di Venezia – nata nel 1932 con un altro nome – e per far stampare e circolare svariate riviste letterarie persino “frondiste”, ma utili a fornire un’immagine “aperta” del regime), anche a sinistra, purtroppo, ci fu chi non si fece scrupoli ad attaccare l’autonomia della cultura in nome e per conto dei bisogni di un generico popolo, i cui gusti mediani dovevano essere considerati come il limite invalicabile per le produzioni artistiche.
L’esempio più macroscopico ci porta all’Unione Sovietica dei primi anni Venti, dove un gruppetto di autori mediocri (ma ben inseriti nel Partito) provò prima a fare a pezzi tutta la letteratura russa considerata “alta” (e quindi inarrivabile, almeno per loro….), per poi cercare di imporre una standardizzazione dell’espressione letteraria sulla base di un vero e proprio canone, definito “letteratura proletaria” e figlio di un canone più ampio (e sciagurato), cioè quello della “cultura proletaria”. Questi signori, radunati attorno alla rivista Na Postu, combattevano il Futurismo russo perché “inaccessibile alle masse” (quindi al popolo), stroncavano, per la stessa ragione, ogni forma di simbolismo nella poesia (contribuendo, così, a svuotarla di senso e, in ultima analisi, ad ucciderla) e giudicavano un’opera letteraria non sulla base del suo valore, bensì del grado di fedeltà al Partito dimostrata dal suo autore, il quale, per altro, per rientrare nei criteri della correttezza artistica doveva scrivere testi caratterizzati da evidenti richiami alle tematiche ritenute importanti dal Partito stesso. Costoro arrivarono all’aberrazione di proporre che i criteri sulla base dei quali si sarebbe dovuta decidere la pubblicazione di questo o quel romanzo venissero sostanzialmente indicati dal Comitato Centrale del Partito Comunista, dato che questo stesso organismo dirigente avrebbe dovuto avere il compito di stabilire i confini generali dentro cui inserire (o meglio, rinchiudere) la produzione culturale.
Ci si dirà: ma questi sono problemi superati, quindi che senso ha riproporre un dibattito sull’incidenza negativa del populismo a livello artistico e culturale? Purtroppo un senso ce l’ha ancora, proprio perché da un lato quell’atteggiamento mentale portò all’uso “normale” di quella censura che ha segnato la vita del socialismo reale fino alla sua estinzione e continua a caratterizzare quella di alcuni Paesi nominalmente comunisti come la Cina e Cuba, mentre dall’altro lato la tendenza a stabilire dei criteri politici di selezione culturale e ad affidarne la gestione ad organismi definiti dal Partito/Stato è ancora ben radicata in certe realtà (a Cuba, ad esempio, la mancanza di carta dovuta all’embargo comporta una forte limitazione dei titoli stampati, basata anche – ma non solo – sulle indicazioni dell’Uneac, l’Unione degli artisti e degli scrittori cubani; una delle conseguenze immediate è che ci sono romanzi di autori cubani tradotti e pubblicati in più di dieci Paesi del mondo che a Cuba, semplicemente, non esistono, il che, con tutta la simpatia che si può nutrire per l’esperienza politica in corso nell’isola caraibica, lascia più di una perplessità e anche un po’ di sconcerto).
Ai tempi delle polemiche suscitate dai vincenti “napostovcy” (vincenti in quanto le loro teorie furono perfettamente recepite ed applicate da Stalin e Zdanov), l’unico dirigente bolscevico ad opporsi apertamente al concetto di “letteratura proletaria” fu Trotsky, ma evito di approfondire questo aspetto perché l’ho già fatto in un articolo specifico che uscirà sul prossimo numero della Nuova Rivista Letteraria, edita da Alegre e in libreria dal 2 dicembre. Lo spunto, però, resta importante, in quanto ha generato comportamenti e concezioni che hanno attraversato l’intero Novecento, arrivando fino ai tempi nostri. Anche nel primo dopoguerra, infatti, una certa letteratura uscita dalla Resistenza e/o comunque opera di scrittori impegnati politicamente a sinistra si basò sull’idealizzazione del mondo popolare come detentore dei valori positivi, malgrado la chiara presa di distanza di Marx nei riguardi del populismo, ben evidenziata da questa sua frase: «Quando si parla di popolo, mi domando che brutto colpo si stia giocando al proletariato». E se alla questione del rapporto tra populismo e letteratura è difficile aggiungere qualcosa di importante a quanto già espresso da Alberto Asor Rosa nel suo fondamentale Scrittori e popolo del 1965 (al di là delle ovvie revisioni fatte successivamente dall’autore stesso, in base alle enormi trasformazioni subite dal contesto sociale rispetto a quello preso in esame all’epoca), è possibile, però, riprenderne alcuni capisaldi per analizzare la situazione odierna. In quel libro, che aprì una discussione enorme e molto feconda, Asor Rosa contestava da sinistra il modello culturale populista proposto dal Pci, mettendo in evidenza la mancanza, in Italia, di una letteratura borghese capace di criticare duramente il mondo che l’aveva generata e mettendo in discussione proprio il populismo di tanti autori otto/novecenteschi, che allora erano dei punti di riferimento quasi intoccabili per i gruppi dirigenti, e non solo, della sinistra italiana (da Pascoli a De Amicis, da Bilenchi a Pratolini, fino a Vittorini, Cassola, Pasolini e persino al Gramsci che aveva sostenuto il “nazionalpopolare”).
A questo punto, a quarantacinque anni di distanza dall’uscita di quel libro straordinario, le domande sono: siamo sicuri che la tentazione populistica (spesso coincidente con la malsana idea di utilizzare la cultura in chiave propagandistica) non si nasconda ancora dietro il rapporto tra sinistra e cultura, e, soprattutto, quanto pesa, in tal senso, la subalternità – anche in campo culturale – alle leggi del mercato dimostrata da gran parte della sinistra italiana, fino a farne un nuovo dogma? Personalmente, temo che la prima risposta sia affermativa e la seconda sia “molto”, con qualche sovrapposizione possibile, nel senso che da una parte l’evidente abbassamento dei livelli culturali dei gruppi dirigenti della sinistra comporta anche l’accettazione di ciò che, culturalmente, non contrasta con il senso comune (con tutto il rispetto, ne è un esempio il “fabiofazismo” televisivo, basato sull’esaltazione e l’ulteriore diffusione dei libri che occupano i primi posti delle classifiche di vendita, quindi quelli più “popolari”), e dall’altra parte sia il mercato stesso, con i suoi meccanismi distributivi e promozionali tipicamente capitalistici, ad operare di per sé quella selezione “populistica” che, con qualche positiva eccezione, cancella in partenza le forme espressive e tematiche reputate “di ricerca”. In sintesi, mi sembra chiaro che del populismo non ci siamo assolutamente liberati e che, se vogliamo tentare di uscire dalle sabbie mobili della subalternità culturale della sinistra nei confronti del pensiero dominante, dobbiamo riproporre questa battaglia, comprendendone tutta la sua attualità.


 Dal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.
Dal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.