Quando in galera è il tuo corpo che diventa il luogo della rivolta
Paolo Persichetti
Liberazione 13 Agosto 2008 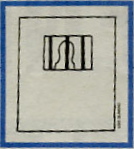
La vicenda di Alì Juburi, il detenuto iracheno quarantaduenne morto lunedì scorso a causa di uno sciopero della fame intrapreso per protesta contro una condanna che considerava ingiusta, è una di quelle notizie che troviamo confinate nelle brevi dei grandi quotidiani nazionali o che al massimo riempiono lo spazio di un articolo della stampa locale. Vite che scivolano via nell’indifferenza generale, sospiri persi nelle distrazioni di una estate afosa. Le cronache ci dicono che si trattava probabilmente di una persona sorpassata dagli eventi, triturata dai meccanismi di un dispositivo burocratico-punitivo che non riabilita ma macera le esistenze, soprattutto quando sono fragili.
Arrestato a Milano, rinchiuso a san Vittore, subito dopo la condanna di primo grado gli è toccato il destino dei tanti stranieri ospiti delle nostre carceri: lo sfollamento. Le grandi carceri giudiziarie funzionano così. I detenuti appena condannati vanno via per lasciare posto ai “nuovi giunti”. Qualcuno ce la fa a restare perché c’è sempre una piccola sezione penale pronta ad accogliere i raccomandati, quelli che hanno un mestiere utile al carcere (muratori, idraulici, elettricisti) e gli asserviti alla custodia. I residenti finiscono nei “penali” della città, se esistono, o nelle carceri della provincia. I più sfigati vengono distribuiti nella regione. Una norma del regolamento penitenziario salvaguarda il diritto di prossimità al luogo di residenza dei familiari, l’istituto di assegnazione non deve distare oltre i 300 chilometri. Così c’è scritto… Il criterio non vale per le categorie speciali, come i detenuti in 41 bis, gli Eiv.
Gli stranieri (una volta si diceva “forestieri”, parola migliore che indica soltanto la provenienza da fuori, non l’estraneità, la diversità), che nella stragrande maggioranza dei casi sono soli, vengono sbattuti, “tradotti” (altro termine della burocrazia penitenziaria) nei quattro angoli del paese. Da una città del Nord a causa di uno sfollamento si può arrivare anche in Sicilia. Juburi era finito a Vasto, sul litorale abbruzzese. Condannato ad appena un anno e tre mesi era rimasto in carcere. Non risulta che avesse recidive, non aveva altre condanne e si protestava innocente per quella che aveva subito. Secondo la legge avrebbe potuto essere fuori. Per gli incensurati che incorrono in pene inferiori ai due anni è prevista la condizionale. Il pacchetto sicurezza, che per alcuni reati detti di «particolare allarme sociale» modifica questa norma, è stato approvato solo più tardi. Juburi deve essere incappato in un giudice che ha anticipato i tempi, uno di quelli che annusano con particolare solerzia la direzione del vento. Sicuramente non aveva avvocato, non poteva permettersene uno bravo. Avrà avuto un legale assegnato d’ufficio che senza parcella non si è minimamente interressato al suo caso. Per lui nessuna misura alternativa.
Se sei straniero non vale. È più facile che ti condannino perché su di te pesa un pregiudizio sfavorevole. Magari ti manca il permesso di soggiorno e hai una residenza al nero che non puoi certificare. Allora non ti resta che accettare il carcere e aspettare che passi. Potresti fare una richiesta di rimessa in libertà, ma non lo sai, non parli bene la lingua, non conosci le leggi, ti chiedono solo di rispettarle. Hai solo doveri ma non diritti. Magari sei sfortunato e non incontri nessuno che vuole o può aiutarti. Nessuno che si sofferma a parlarti, che ti chiede da dove vieni, perché sei lì. Sei solo un paria, uno dei tanti buttati in fondo a una cella. Non capisci cosa succede e perché ce l’hanno tanto con te che volevi solamente vivere, mangiare, vestirti, avere una donna, dei figli. No, per te non vale. Allora ti monta la rabbia, una rabbia che ti torce le budella, ti prende lo stomaco, ti fa digrignare i denti. Vorresti urlare al mondo quell’assurda situazione, ma oltre le mura del carcere c’è solo campagna. Una bella campagna che ti ricorda la tua terra. Gli alberi da frutto, gli ulivi. Ricordi quando eri bambino e correvi tra i campi di grano. Invece ora apri gli occhi e vedi solo sbarre e cemento mentre la vita scorre ritmata dal rumore di grosse chiavi d’ottone. Fuori non c’è nessuno, solo il vento. La rabbia allora fa il cammino inverso, ritorna in te, s’impadronisce del tuo corpo, lo usa come un’arma. Diventi il luogo della lotta, lo strumento della protesta. Non hai altro. Hai solo quel corpo e lo usi.
Un filosofo che conosce quelle parole che tu non sai la chiama la «nuda vita». Tu fai della nuda vita il mezzo della rivolta. Non accetti quel che succede. Smetti di mangiare. I primi giorni senti freddo, tanto freddo. Brividi atroci lacerano le tue ossa, la notte il cuore batte fortissimo, ti prende l’affanno. Poi senti come una febbre che ti brucia la pelle. Il corpo divora se stesso. Il tuo peso precipita ma già non senti più il morso della fame. Lo stomaco si è chiuso, le forze mancano, ma basta stare fermi e coperti. Le ore passano nel dormiveglia. Ormai sei nella vertigine e non sai più tornare indietro.
Dicono che sia un mezzo di lotta nonviolenta. Che fesseria! Non c’è forma più violenta di uno sciopero della fame, di un corpo che divora se stesso. Autofagia. Altri si mutilano, si tagliano a fettine. Sfregiano la propria pelle con cicatrici idelebili. Rughe che parlano di dolore. Piaghe vive, zampilli di sangue che sporcano i muri tra urla eccitate e fuggi fuggi generale. Un modo di richiamare l’attenzione, segno di fragilità, di disperata voglia di comunicare senza avere gli strumenti giusti per farlo. Nel 2007 (fonte Antigone) gli atti di autolesionismo recensiti sono stati 3687. Circa duemila in meno del 2004, grazie agli effetti dell’indulto. Comunque l’8,14% della popolazione detenuta. La triste storia di Alì Jaburi insieme a queste cifre cifre ci dice che il carcere è il problema, non la soluzione.
Il detenuto Alì, lasciato morire di fame
di Piero Sansonetti, Liberazione 13 Agosto 2008 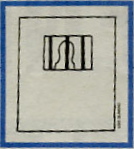
Alì Juguri era un cittadino iracheno, arrestato in Italia per il tentato furto – pare – di un telefonino. Detenuto da molti mesi aveva iniziato uno sciopero della fame durissimo. Carcere di Vasto, carcere dell’Aquila, poi in ospedale. Si dichiarava innocente. Il tribunale, in primo grado, lo aveva giudicato colpevole e lo aveva condannato a un anno e qualche mese. Non sappiamo perché Alì non avesse ottenuto la condizionale e la scarcerazione. Non sappiamo come fosse stata impostata la sua difesa.
La storia di Alì Juguri (la leggerete a pagina 2) è una storia semplice e come tutte le cose veramente semplici è importante. È una storia di carcere, di pena certa – come si dice oggi – di sistema giudiziario. E poi, soprattutto, come avete capito, è una storia di morte. Perché Alì è morto, due giorni fa, nell’ospedale de L’Aquila. Da tre mesi era ricoverato lì perché aveva deciso di non mangiare più dal momento che non trovava nessun altro modo per proclamare la sua innocenza, per protestare contro le istituzioni e cercare giustizia. Noi non sappiamo quasi niente della vita di questo iracheno di 42 anni. Sappiamo che è entrato in carcere a Milano una decina di mesi fa, che non ha avuto una buona tutela giudiziaria perché gli avvocati che lo hanno “assistito” non hanno provato nemmeno ad ottenere per lui la condizionale, e perché dopo la condanna di primo grado è stato “frullato” via come tanti suoi simili, stranieri, dal carcere milanese, per sovraffollamento, e mandato a Vasto. Da Vasto a l’Aquila.
C’è qualcosa, nella sua storia, che – come una lente di ingrandimento – ci permette di osservare questo sistema giudiziario elefantiaco, obeso, burocratico. E’ un sistema giudiziario che deve rispondere a tre «potenze», a tre «caste»: i giudici, la politica e l’opinione pubblica. Tre «caste» in lotta perenne tra loro e in grado di condizionarsi, danneggiarsi, aiutarsi. Il «patto» tra queste tre potenze è sempre in bilico, e tiene sempre in bilico gli equilibri della politica italiana. Ma sempre trova un suo equilibrio. Basato su che cosa? Sulla necessità dei giudici di mantenere il proprio potere, sulla necessità dei politici di proteggere se stessi e le classi dominanti, sulla necessità dell’opinione pubblica di ottenere promesse di giustizia, di punizione dei colpevoli o presunti, di vendetta.
La chiave che permette questo equilibrio è quella del garantismo temperato. In che modo? Impastandolo con il giustizialismo, sulla base di una netta distinzione di classe: garantismo discreto per i ceti più solidi, per i politici, per gli stessi giudici, per chi è in grado di pagare; severità e sospensione dei diritti per i più deboli. Specie per quelle fasce di popolazione universalmente riconosciute come «estranee»: per esempio gli stranieri, o i piccoli delinquenti, i tossicodipendenti, le prostitute.
Questo «patto» per la giustizia è quello che ha sempre impedito la riforma della giustizia. Ha permesso, con aggiustamenti successivi, di non toccare nessun privilegio e di scaricare sulla parte più debole della società il prezzo.
Alì ha pagato questo prezzo. Alì, che probabilmente era innocente – e certamente lo era fino al pronunciamento della Cassazione – ma è che è morto, non sappiamo per la responsabilità di chi, senza poter ottenere giustizia. E senza suscitare grande scandalo, visto che ieri era quasi impossibile trovare notizie su di lui: il mondo dell’informazione non è affatto interessato, e nel mondo politico gli unici a muoversi, al solito, sono stati i radicali (interrogazione Bernardini-Turco: grazie).
Oggi non si grida allo scandalo per uno che muore da detenuto. Si grida allo scandalo per l’indulto, perché ogni tanto c’è qualche disgraziato che torna sulla via del delitto (anche se le cifre ci dicono che statisticamente chi ha goduto dell’indulto torna a delinquere in misura tre volte inferiore rispetto a chi esce dopo aver scontato tutta la pena). Ma il vero scandalo dell’indulto è che non è servito a molto. Le carceri sono di nuovo piene, e sono piene di persone – moltissimi stranieri – accusate di reati per i quali la carcerazione potrebbe non essere necessaria. Lo scandalo è che l’indulto avrebbe dovuto essere un piccolo passo, e poi ci sarebbe dovuta essere l’amnistia e poi la riforma. E invece la finta guerra tra politica e magistratura rende impossibile tutto questo. Finché noi non riusciremo a indicare in questo patto tra i due “poteri” il colpevole per la mancata giustizia, continueremo ad essere vittime di un antipolitica che è il cemento dell’alleanza ipocrita e gaglioffa tra i poteri, e del loro dominio incontrastato.




 Gli spettri del 41 bis
Gli spettri del 41 bis L’unico svago concesso viene dall’agognato carrello dell’infermeria che scandisce la giornata distribuendo tre volte al giorno stupefacenti ricreazioni chimiche a base di benzodiazepine. Gli «invisibili», come fantasmi, ogni tanto battono un colpo, anzi dei colpi sui cancelli blindati. Quelle periodiche battiture ci ricordano che il loro è un mondo di vivi che non rinuncia a resistere.
L’unico svago concesso viene dall’agognato carrello dell’infermeria che scandisce la giornata distribuendo tre volte al giorno stupefacenti ricreazioni chimiche a base di benzodiazepine. Gli «invisibili», come fantasmi, ogni tanto battono un colpo, anzi dei colpi sui cancelli blindati. Quelle periodiche battiture ci ricordano che il loro è un mondo di vivi che non rinuncia a resistere. dispositivi giudiziari e penitenziari della emergenza, sempre più limitanti e costrittivi delle libertà individuali e collettive, restino radicati nel tempo, mentre le tipologie di applicazione hanno vocazione a variare. Ieri è toccato ai «terroristi», oggi ai mafiosi, persino ceto politico e imprenditori ne hanno saggiato gli effetti. E domani?
dispositivi giudiziari e penitenziari della emergenza, sempre più limitanti e costrittivi delle libertà individuali e collettive, restino radicati nel tempo, mentre le tipologie di applicazione hanno vocazione a variare. Ieri è toccato ai «terroristi», oggi ai mafiosi, persino ceto politico e imprenditori ne hanno saggiato gli effetti. E domani? volte. Ora che la destra ha in mano le briglie del governo e in parlamento è scomparsa ogni opposizione, il disegno restauratore sembra inarrestabile e si avvia a dare sostanza alla nuova costituzione materiale del Paese prima di portare l’attacco a quella legale. Dopo le leggi speciali per la Campania, li pacchetto sicurezza che prevede la moltiplicazione e la trasformazione dei cpt in carceri-lager, l’aggravante penale per gli immigrati irregolari, gli sgomberi, le schedature, le retate contro i nomadi e l’esercito nelle strade, il giro di vite sicuritario colpisce anche le carceri. In Senato è stato depositato il disegno di legge 623, riguardante le “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione”. Primo firmatario Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia del senato con un profilo sicuritario di prim’ordine: già deputato missino poi senatore di An e oggi esponente del Pdl. La proposta di legge prevede la soppressione della liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre concesso in caso di buona condotta e partecipazione positiva del detenuto al percorso rieducativo.
volte. Ora che la destra ha in mano le briglie del governo e in parlamento è scomparsa ogni opposizione, il disegno restauratore sembra inarrestabile e si avvia a dare sostanza alla nuova costituzione materiale del Paese prima di portare l’attacco a quella legale. Dopo le leggi speciali per la Campania, li pacchetto sicurezza che prevede la moltiplicazione e la trasformazione dei cpt in carceri-lager, l’aggravante penale per gli immigrati irregolari, gli sgomberi, le schedature, le retate contro i nomadi e l’esercito nelle strade, il giro di vite sicuritario colpisce anche le carceri. In Senato è stato depositato il disegno di legge 623, riguardante le “Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione”. Primo firmatario Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia del senato con un profilo sicuritario di prim’ordine: già deputato missino poi senatore di An e oggi esponente del Pdl. La proposta di legge prevede la soppressione della liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre concesso in caso di buona condotta e partecipazione positiva del detenuto al percorso rieducativo.  Intenzione che difficilmente troverà l’avallo della stessa polizia penitenziaria. Chi lavora quotidianamente nei penitenziari sa bene che questo è uno degli istituti che ha maggiormente contribuito a “pacificare” le prigioni, disinnescando rivolte, proteste e confronti violenti. Tra l’altro la riduzione della pena per buona condotta vede l’Italia in posizione di fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei dove questa misura può arrivare, con modalità diverse, fino alla metà della pena e non ad appena un quarto, come previsto dal testo di legge attualmente in vigore, approvato dal parlamento nel 1986. Le misure messe in cantiere colpiscono duramente gli ergastolani che vedono raddoppiati i tempi per ottenere i permessi: dagli attuali dieci anni di pena espiata ad un minimo di venti, «sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi». Per loro viene anche completamente abolita la possibilità di accedere alla semilibertà, oggi prevista dopo venti anni di reclusione. Per i detenuti con pene temporanee, invece, l’entrata in semilibertà (lavoro esterno diurno e pernottamento in cella) passa dall’attuale metà a due terzi della pena per i reati meno gravi e dai due terzi ai tre quarti per le categorie ritenute più pericolose. L’affidamento in prova ai servizi sociali non coprirà più gli ultimi tre anni di condanna ma soltanto l’ultimo, e chi è in libertà dovrà obbligatoriamente essere reincarcerato se vorrà ottenere il beneficio. Il che vuol dire che ne resterà automaticamente escluso visti i tempi di lavoro prolungati che contraddistinguono i tribunali di sorveglianza. È poi prevista una riduzione della metà della detenzione domiciliare speciale che passerà dagli attuali quattro anni a due, mentre, «in considerazione del lieto allungarsi della vita umana» questo beneficio non potrà più essere concesso agli ultra-settantenni ma sarà riservato unicamente agli ultra-settantacinquenni se riusciranno a sopravvivere cella. Dopo aver messo fuori Cesare Previti i suoi amici sono tornati a considerare il carcere per le persone anziane un fatto umanamente ammissibile. Le modifiche del codice di procedura che riguardano invece l’impossibilità di concordare la pena (art. 444) senza un previo accordo e adeguato risarcimento con la parte offesa. Mentre l’istituto della sospensione della pena (art. 666) viene ridotto da tre ad un anno, per renderlo compatibile con la contemporanea modifica dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Intenzione che difficilmente troverà l’avallo della stessa polizia penitenziaria. Chi lavora quotidianamente nei penitenziari sa bene che questo è uno degli istituti che ha maggiormente contribuito a “pacificare” le prigioni, disinnescando rivolte, proteste e confronti violenti. Tra l’altro la riduzione della pena per buona condotta vede l’Italia in posizione di fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei dove questa misura può arrivare, con modalità diverse, fino alla metà della pena e non ad appena un quarto, come previsto dal testo di legge attualmente in vigore, approvato dal parlamento nel 1986. Le misure messe in cantiere colpiscono duramente gli ergastolani che vedono raddoppiati i tempi per ottenere i permessi: dagli attuali dieci anni di pena espiata ad un minimo di venti, «sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi». Per loro viene anche completamente abolita la possibilità di accedere alla semilibertà, oggi prevista dopo venti anni di reclusione. Per i detenuti con pene temporanee, invece, l’entrata in semilibertà (lavoro esterno diurno e pernottamento in cella) passa dall’attuale metà a due terzi della pena per i reati meno gravi e dai due terzi ai tre quarti per le categorie ritenute più pericolose. L’affidamento in prova ai servizi sociali non coprirà più gli ultimi tre anni di condanna ma soltanto l’ultimo, e chi è in libertà dovrà obbligatoriamente essere reincarcerato se vorrà ottenere il beneficio. Il che vuol dire che ne resterà automaticamente escluso visti i tempi di lavoro prolungati che contraddistinguono i tribunali di sorveglianza. È poi prevista una riduzione della metà della detenzione domiciliare speciale che passerà dagli attuali quattro anni a due, mentre, «in considerazione del lieto allungarsi della vita umana» questo beneficio non potrà più essere concesso agli ultra-settantenni ma sarà riservato unicamente agli ultra-settantacinquenni se riusciranno a sopravvivere cella. Dopo aver messo fuori Cesare Previti i suoi amici sono tornati a considerare il carcere per le persone anziane un fatto umanamente ammissibile. Le modifiche del codice di procedura che riguardano invece l’impossibilità di concordare la pena (art. 444) senza un previo accordo e adeguato risarcimento con la parte offesa. Mentre l’istituto della sospensione della pena (art. 666) viene ridotto da tre ad un anno, per renderlo compatibile con la contemporanea modifica dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
