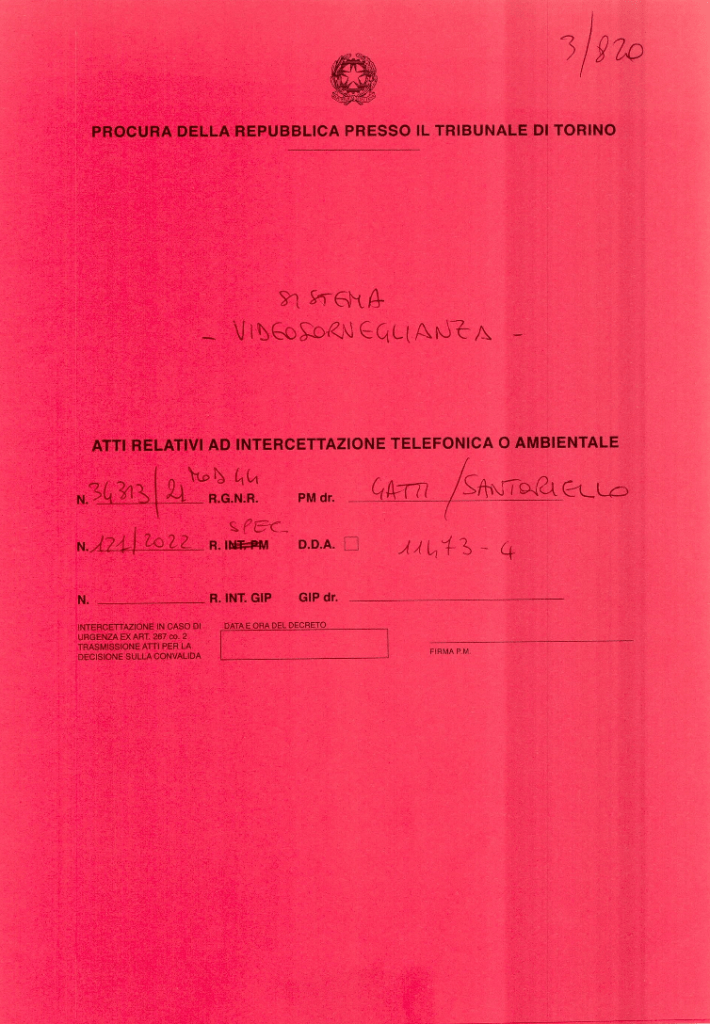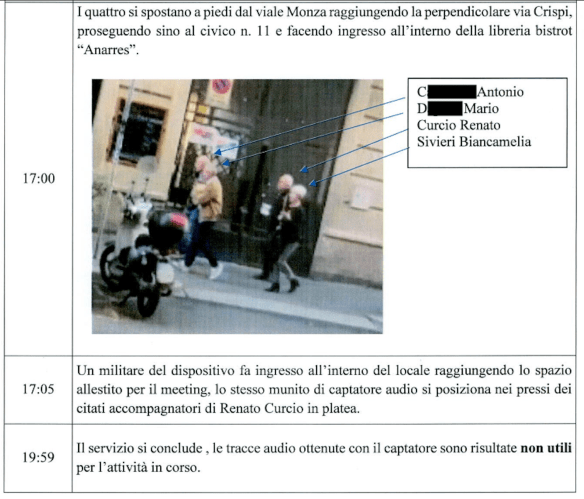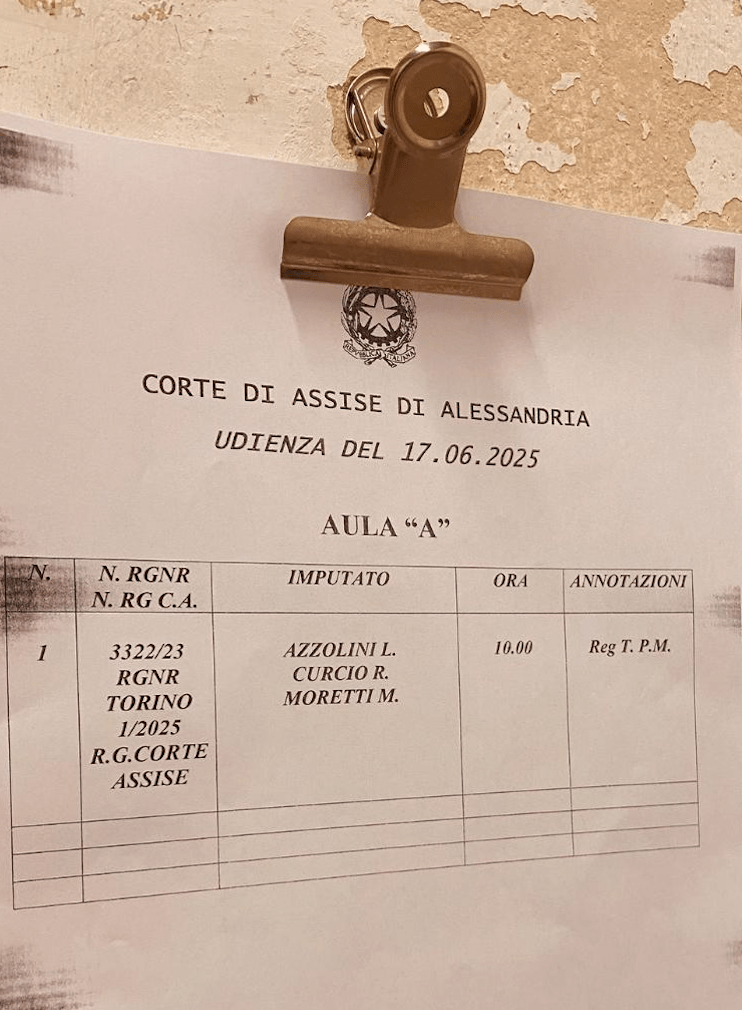Anteprima – E’ in uscita nelle librerie Tondini di ferro e bossoli di piombo. Una storia sociale delle Brigate rosse, di Matteo Antonio Albanese, Pacini editore. Il volume, che si ferma al 1974, propone alcune importanti scoperte documentali e delle nuove proposte interpretative che faranno discutere. Ne ho parlato con l’autore

Alcuni anni fa il sociologo Pio Marconi scrisse che le Brigate rosse, attraverso la categoria di Stato imperialista delle multinazionali, avevano individuato con largo anticipo la fase di internazionalizzazione del modo di produzione e del mercato capitalistico, successivamente definito “globalizzazione”. Nel tuo lavoro aggiungi un fatto nuovo: sostieni che le Brigate rosse furono in assoluto le prime ad introdurre e descrivere il fenomeno della globalizzazione del sistema capitalistico. Puoi spiegare come sei giunto a questa scoperta?
Lessi alcuni dei lavori di Pio Marconi mentre preparavo il mio progetto di ricerca per l’ammissione al dottorato. Mi ricordo che in quei mesi avevo cominciato a leggere con un poco di attenzione le varie pubblicazioni, scientifiche e non, sul fenomeno brigatista. Vivendo, allora, a Milano mi sembrò naturale cominciare un giro dei vari luoghi della città in cui quella memoria era stata in qualche modo conservata. La libreria Calusca e l’archivio Primo Moroni sono stati passaggi importanti per cominciare ad inquadrare il fenomeno. Nello specifico, però, fu una bancarella di libri alla festa dell’Unità il luogo dove trovai, ed acquistai, un paio di numeri di Sinistra Proletaria. Un articolo, in particolare, mi colpì molto: era intitolato la globalizzazione del capitale finanziario ed è contenuto nel numero luglio-settembre 1970. Nel corso degli anni ho poi avuto modo di scoprire, grazie ad Harold James professore di storia economica a Princeton che quella definizione elaborata in quella data anticipava di quasi un anno la prima categorizzazione conosciuta di questo fenomeno in questi termini (tutti i riferimenti sono presenti in un articolo scritto da me e Harold James ed uscito il 2 febbraio 2011 su Project Syndicate). Mi sembra, poi, interessante ricordare come tra le carte del fondo Pci all’Istituto Gramsci di Roma mi sono imbattuto nella stessa pubblicazione che, evidentemente, i militanti del Pci deputati allo studio dei gruppi della sinistra extraparlamentare avevano trovato, ritenuto degno di nota e catalogato. Era una prima ma fondamentale scoperta “archivistica” che ha cominciato a farmi riflettere sulla dimensione del dibattito in corso in quegli anni e che mi riportato alla memoria alcuni saggi sui Quaderni Piacentini e poi su Quaderni Rossi. Ecco, credo che lo sforzo più grande non sia solo confinato al mero dato cronologico dell’utilizzo della categoria, che pure rimane indicativo, ma che, invece, ci metta nella direzione per contestualizzare quell’utilizzo, per comprenderne i legami semantici e politici dentro un campo politico preciso.
Ancora oggi molti studiosi e osservatori che si occupano dell’esperienza brigatista si soffermano su una loro presunta inadeguatezza culturale, eppure queste scoperte storiografiche ci descrivono una situazione diversa. Alla luce di queste nuove evidenze, che giudizio suggerisce allo storico la distanza che emerge tra il respiro prospettico dell’analisi brigatista e il tatticismo nel quale era incagliato il Pci alla continua ricerca di formule e alleanze politiche che gli fornissero una legittimazione istituzionale?
La domanda è molto importante e la sua risposta per cercare di essere esaustiva necessita di una precisazione importante. Le Brigate rosse sono state un gruppo rivoluzionario, il partito comunista in quegli anni ha da tempo dismesso l’idea e ogni tipo di strategia rivoluzionaria. Non dico assolutamente che dentro quel partito non fossero rimaste culture e fascinazioni rivoluzionarie ma credo sia storicamente accurato dire che il Pci non fosse un’organizzazione che si poneva la rivoluzione come orizzonte strategico. Le Br invece sì. Le Br, al pari di molti altri soggetti rivoluzionari (o presunti tali) del tempo, nascono e crescono dentro un dibattito internazionale sulle forme di trasformazione. Fu un dibattito articolato e ricco che ebbe la fortuna di vivere anche grazie all’apporto di alcuni dei migliori intellettuali del momento. Le Br, poi, fanno un passo ulteriore e cioè quello dell’intuizione, più che di piena comprensione parlerei di intuizione, della globalizzazione. Sono convinto che l’internità ad alcune realtà di punta del capitalismo di quel periodo abbia fornito la “materia prima” per quell’analisi sviluppata dal gruppo di studio interno della Ibm; a questo aspetto si unisca la sensibilità di Curcio (e di altri tra cui Margherita Cagol il cui ruolo, forse, è troppo sottostimato) che aveva studiato intensamente la sociologia industriale americana. Se di inadeguatezza, invece, si può parlare questa, a mio modo di vedere, è sulla ricaduta politica di quella trasformazione. L’idea che la crisi del fordismo, ed in ultima analisi della sua scomparsa dal mondo occidentale, potesse essere l’occasione per una rivoluzione in senso socialista rimane il punto debole dell’analisi brigatista. Non è, questa, una critica che si possa muovere alle sole Br in quanto molti altri gruppi, da prospettive differenti, cadono nello stesso errore. L’errata valutazione del profondo cambio sociologico, financo antropologico, che stava avvenendo dentro la classe operaia e le sue strutture sfugge all’analisi della sinistra rivoluzionaria. Da questo punto di vista la lenta trasformazione del Pci in partito socialdemocratico, elemento colto pienamente da Moro, è irreversibile e profondamente innervato nel corpo vivo di quel partito e la sua ricerca di una diversa collocazione sia internazionale che istituzionale, già cominciata sul finire degli anni ’60, rimangono il nodo storiografico e politico ineludibile.
Eppure la scelta di portare l’iniziativa armata fuori dalle fabbriche mettendo radice nei territori ed in particolare nelle periferie di alcune grandi città, come Roma, poi Napoli (in quelle milanesi – come sottolinei nel tuo lavoro – erano presenti fin dalla nascita), sembra dimostrare che le Br fossero consapevoli di questa mutazione (sulla scia della riflessione che proveniva dell’esperienza operaista). Più che l’avvio di un processo rivoluzionario, la distanza storica ci permette forse di dire che esse agirono come una controtendenza che si oppose ai processi di ristrutturazione produttiva dell’economia e dello Stato? Si può dire che la presenza della lotta armata ha ritardato di almeno un decennio la rottura di quegli argini che hanno lasciato via libera agli spiriti animali del capitalismo ultraliberale più selvaggio? In fondo la Fiat riesce a realizzare la massiccia ondata di licenziamenti, i famosi 23 mila del settembre 1980, solo dopo lo smantellamento della colonna torinese e genovese provocata dalla delazione di Patrizio Peci.
Come cercavo di dire, ed è per questo che nel libro si può incontrare spesso la parola “cultura” e la categoria di habitus, le Br sentono questo cambiamento, lo avvertono e non sono sole. Tutta l’elaborazione negriana sull’operaio sociale che affonda le proprie radici nel pensiero di Tronti (anche in polemica con esso) è un processo di riflessione collettiva sulle trasformazioni in atto. Per intenderci non credo ai cattivi maestri; penso che da un punto di vista storico siano i processi, che sono plurali per loro natura e, molto raramente i singoli, a fare la differenza. Insomma, in Italia, e non solo, c’è un processo endogeno di lunga durata che investe centinaia di migliaia di persone (alle elezioni del 1972 le liste alla sinistra del Pci raccolgono mezzo milione di voti) e che per almeno un decennio ha un problema centrale: la presa del potere e la rivoluzione in un paese come l’Italia. Possiamo leggere le Br fuori da questo contesto? No, non scherziamo. Ora se il processo di cambiamento del modello produttivo (non del modo, chiaramente) è un accidente che dura da circa 4 decenni, le variabili da considerare sono molte. È stato Serge Mallet a scrivere di questa trasformazione già agli inizi degli anni ’60 soprattutto, come spesso avviene, nelle realtà più avanzate del capitalismo francese. La riproduzione sociale del capitale portava, quasi (il quasi è estremamente importante) forzosamente, le lotte fuori dalla fabbrica. Di nuovo non sono le sole Br a riflettere su temi quali la casa, i trasporti ed in generale alle condizioni extra-produttive della vita dei lavoratori ma stanno dentro un movimento ampio. Sicuramente furono un fenomeno di controtendenza e la loro presa dentro le fabbriche e nei quartieri popolari si può, ed a mio parere si deve, leggere dentro il contesto della crisi. Quanto, poi, quella crisi si sia dipanata anche a causa dell’azione dei soggetti e quanto, invece, abbia vissuto di tempistiche legate al progetto di ristrutturazione che investiva un ciclo produttivo sempre più globalizzato è, a mio parere, solo abbozzato nel libro e mi riprometto di studiarlo in maniera più approfondita.
Proponi una strumentazione concettuale ispirata alla lezione di Pierre Bourdieu, in particolare ti soffermi con molta efficacia sulla nozione di “habitus” e sul peso che ha avuto nel determinare la radicalità del movimento operaio e di altri segmenti sociali che si intrecciano e associano alle sue lotte fino alla crescita di una area politica rivoluzionaria alla sinistra del Pci.
Non posso assumermi meriti non miei; fu il mio allora relatore di dottorato Gerhard Haupt che è un profondo conoscitore del pensiero di Bourdieu ad indirizzarmi in questa direzione. Da parte mia ho cercato di calare quella teoria sia dentro le ricerche esistenti, da Marco Revelli a Giuseppe Berta ed altri, e alle carte degli archivi sindacali che ho visitato. In particolare, mi colpirono molto una serie di volantini di alcune fabbriche del milanese datati fine 1972 (Borletti ed altri) che cominciavano a parlare delle lotte contro la cassa integrazione e contro i primi processi di internazionalizzazione delle produzioni. Questi primi “sintomi” di globalizzazione si legavano a doppio filo non solo con l’articolo di Sinistra Proletaria che ho già citato ma anche con un volantino molto simile dei Comitati di Base Pirelli dell’ottobre 1969. Di fronte a queste testimonianze documentali ed a questa letteratura ho cominciato a pensare alla tuta blu non solo come abito ma come habitus, appunto, come conglomerato sociale e culturale e come narrazione salvifica che era stata “venduta” ai milioni di contadini che emigrarono al nord con il sogno del posto fisso in fabbrica. Una fabbrica che, invece di espandersi, come pensava un certo operaismo, stava cercando di fuggire verso altri lidi. Cosa succedeva a quella narrazione ed a quel sogno inseguito con tanta caparbietà da quella generazione? Come mutava non solo la condizione sociale e culturale di chi perdeva il lavoro ma anche quella dei figli di quel soggetto? Ecco credo che se la guardiamo attraverso questa lente e tenendo presente che per il filosofo francese la “costruzione” dell’habitus è un processo di violenza simbolica e qui di violenza si parla, le due cose non possano essere non messe in collegamento. Un collegamento non diretto e meccanicista ma culturale, sociale e di narrativa. Per quanto riguarda la nascita alla sinistra del Pci credo che il tutto vada messo nella giusta ottica; soggetti, pur piccoli, alla sinistra del Pci esistono dal 1960 con le varie scissioni di gruppuscoli maoisti che cominciano a portare una critica serrata a quel partito che si stava, inesorabilmente, trasformando. Semmai c’è da porsi la domanda di quanta compenetrazione ci fu tra gruppi della sinistra extraparlamentare e movimento operaio perché se è vero che gli studenti “andarono al popolo” non penso che questo dato vada sovrastimato senza sottolineare anche le diffidenze che pezzi di mondo del lavoro mantennero sempre nei confronti di quei giovani che, spesso, provenivano, comunque, da contesti sociali più agiati.
L’arco temporale che affronti nel volume va dal 1968 al 1974. Un periodo caratterizzato da mutamenti sociali ed economici rapidi, drastici passaggi di fase: in quegli anni si sviluppa fino al suo apice la spinta delle lotte operaie tra biennio 68-69 e fazzoletti rossi alla Fiat, ci sono eventi acuti come lo stragismo, lo choc petrolifero. Le Br non credono a svolte golpiste sono molto attente invece alle proposte avanzate dalla Trilateral, raccolte nel famoso rapporto preparato da Croizier e Huntigton sulla crisi della democrazia e la loro governabilità. Tuttavia nello loro prime azioni selezionano obiettivi che appartengono a quel personale fascista recuperato dagli apparati di comando delle imprese. Come spieghi questa dualità?
A questa domanda, in realtà, hanno risposto le Br nell’autointervista che è pubblica fin da subito, nel 1971: i fascisti, o meglio il neofascismo, rimane lo strumento del capitale ma il progetto non è più quello di una svolta dittatoriale ma la costruzione di una cultura autoritaria di massa. In questo sta la distanza con Feltrinelli che, invece, pensava ad una riedizione del fascismo tout-court. Questa linea che si intravede già nelle rivendicazioni delle prime azioni con la dicitura «fascisti in camicia bianca» porterà, come conseguenza logica, allo sviluppo della campagna di primavera del 1974 con il rapimento Sossi. Va da sé, però, che le Br hanno nei primi anni della loro vita politica due obiettivi: il primo è quello di accreditarsi presso il soggetto sociale di riferimento che era la classe operaia e, quindi, intervenire sulle contraddizioni quotidiane dei luoghi in cui militavano era quasi scontato. Le Br nascono in fabbrica, e molto meno nel movimento studentesco, e da lì “devono” partire. Hanno, però, sempre ribadito, fino a dire nel 1973 che i fascisti erano di per sé poco importanti, che il progetto delle classi dominanti era quello della costruzione di una democrazia autoritaria di stampo gaullista. C’è, poi, un altro elemento centrale: l’egemonia sulla classe operaia si svolge con e contro un avversario politico: il Pci ed è per questo che la relazione con quel partito e le sue strutture fu così importante.
Veniamo ad un’altra novità che si trova nel tuo libro: negli archivi del Pci hai trovato due documenti inediti che mettono in luce nuovi aspetti del rapporto conflittuale tra Pci e Br. Ce ne puoi parlare?
Sì, nell’archivio del Pci trovo documenti che, insieme alle interviste, mi aiutano a comprendere meglio la relazione tra Br e Partito: una relazione che, lo ripeto, è quanto meno duale. Quello che mi interessava sottolineare erano due punti e credo, anche grazie a questa documentazione di esserci riuscito: il Pci conosceva le Br e le conosceva bene. Sapeva non solo chi fossero, almeno a grandi linee, ma ne conoscevano la linea politica perché le Br erano soggetto interno alla classe ed alle sue organizzazioni. Su questo punto non si può più tornare indietro. Di conseguenza tutta la pubblicistica sulle “sedicenti” Br va letta ed interpretata come uno scontro, quasi una pedagogia nel paternalismo che caratterizzava quel partito, tutto interno alla sinistra italiana. Sono convinto che, anziché affidarsi a strambe teorie del complotto, vada letto lo scontro in atto tra un partito, enorme ed innervato nella società, contro un gruppo rivoluzionario. Almeno fino alla fine del 1973 questo scontro il Pci cercherà di regolarlo, appunto, come uno screzio di famiglia (altro che album!). Non le disconosce le Br, anzi, le riconosce pienamente come avversario e le tratta con condiscendenza nell’idea, assolutamente fondata, che fossero espressione del radicalismo espresso da pezzi di movimento ed ha l’obiettivo di far rientrare quel gruppo, o almeno una gran parte di esso, dentro l’alveo della sinistra istituzionale. A questo compromesso le Br non scendono e lì si apre tutta un’altra storia ed una diversa relazione politica tra i due soggetti.
In effetti c’è un’ammissione fatta da Enrico Berlinguer nel corso di una intervista a Repubblica del 22 aprile 1978 nella quale il segretario del Pci dichiara che le Br: «sono i nostri antagonisti diretti, sostenitori di un’opzione alternativa nella sinistra». Una frase pronunciata nei giorni del sequestro Moro, stranamente sfuggita al linguaggio sempre controllato di Berlinguer e che tuttavia non ha mai attirato l’attenzione degli storici. Tonino Paroli, uno degli esponenti del gruppo dell’appartamento che partecipò alla fondazione delle Br, da me interpellato sui documenti che hai scoperto, si è mostrato molto perplesso. Sostiene che nessuno dei Br che provenivano dall’esperienza dell’appartamento è poi rientrato nel Pci. A suo avviso, probabilmente, si tratta di alcuni esponenti dell’appartamento che hanno frequentato il Cpm, Sinistra proletaria, magari sono andati un pochino oltre, forse commettendo anche qualche piccola azione illegale, ma poi si sono fermati rientrando nel Pci.
Allora la domanda ha una sua complessità e devo dividere la risposta in due parti: in primo luogo è assolutamente possibile che l’interpretazione di Paroli sia esatta: quelli che si ritrovano a bussare alla porta del partito sono stati elementi “minori” che non hanno, poi, aderito integralmente al progetto politico brigatista. Questo, però, ci parla di nuovo della dimensione assunta, in un certo momento, dal fenomeno Br. Quanti sono stati le donne e gli uomini che hanno gravitato in quell’area in diversi momenti? A mio parere molti di più di quanto ancora oggi non si sappia o non si voglia sapere. Questo, in sé, non muta la natura di quel documento, non sposta di una virgola il nodo della relazione politica tra Br e Pci e non la sposta anche perché, almeno fino alla fine del ’73 le Br non sono, da un punto di vista strettamente penale che era quello che più preoccupava il Pci, accusate di grosse cose. A dirla così oggi, si può sorridere, ma il livello di illegalità sul quale si muovevano le Br non era affatto dissimile da quello di decine e decine di altre sigle più o meno estemporanee della sinistra italiana inclusi alcuni membri del Pci. Quello che è interessante in quel documento non è tanto che alcuni militanti, inseriti a pieno titolo o meno cambia poco in quella fase, vogliano ritornare nel Pci spaventati o perché, forse, fanno considerazioni politiche altre ma è la risposta del partito ad essere importante con tutto ciò che ne consegue. Il secondo punto, poi, che mi fa riflettere su quanto detto da Paroli afferisce alla seconda mandata di documenti, come sai sono 2 fascicoli diversi, in cui si parla apertamente di elementi a quell’epoca di punta delle Br conosciuti dal Pci e c’è la famosa proposta di collegio di difesa pagato dal Pci a membri delle Br. Questo accenno è importante non solo perché lo riporta anni prima Franceschini nel suo libro ma anche perché lo ribadisce Curcio nel corso della sua chiacchierata con me quando mi dice che vi fu una riunione tra Br ed alcuni esponenti del Pci; riunione nel corso della quale la proposta fu formalizzata e respinta dalle Br. Tre indizi, insomma mi sembrano sufficienti a fare non dico una prova ma almeno ad indicare una direzione di ricerca.
Nel corso delle tue ricerche sulle relazioni tra Pci e Br dai corpo al dubbio che l’operazione Girotto, che portò all’arresto di Curcio e Franceschini, non sia opera solo di Dalla Chiesa ma ci sia stato anche un intervento pesante del Pci.
Come giustamente dici, è un dubbio. La storia si fa solo con i dubbi i quali però devono essere supportati da qualche indizio documentale. Su questo punto, lo dichiaro nel libro non ho prove schiaccianti ma solo un’inferenza logica che non è sufficiente, non prova nulla ma apre, semmai, la strada per eventuali altre ricerche. La risposta sta nella domanda successiva. Se il Pci deve intervenire nel corso del processo Sossi per bloccare la disponibilità di Cuba ad ospitare i militanti della XXII ottobre in caso di scarcerazione com’è possibile che poche settimane dopo si presenti un ex prete guerrigliero chiedendo informazioni sulle Br portandosi dietro delle credenziali cubane? Non mi sembra né un caso né, in quel clima politico internazionale, una svista possibile. Girotto fa il nome di un uomo dei servizi cubani che gli firma una lettera con la quale si presenta a Lazagna, lo stesso Lazagna non si fida pienamente di lui. Ora è possibile che i cubani, ripeto poche settimane dopo il problema con Sossi ed i militanti della XXII ottobre, non si pongano il problema prima di firmare “patenti di comunismo” ad un italiano di avvisare il partito comunista italiano? A me, francamente pare inverosimile. Per di più, e questo ce lo dice Dalla Chiesa, sappiamo che dopo il rifiuto delle Br all’offerta del partito il Pci comincia un’opera di collaborazione con la polizia che diventerà sempre più stretta con il passare degli anni e con l’aumento della ferocia degli attacchi brigatisti. Di nuovo tre indizi non faranno una prova ma ci indicano una direzione fino ad oggi negletta.
Nel volume citi una significativa testimonianza di Sergio Flamigni che, a mio avviso, rende palese quanto sia falsa e dolosa la narrazione dietrologica avviata dal Pci negli anni 80. Se Berlinguer è costretto a chiamare Mosca per chiedere di fare pressione su Fidel Castro affinché ritiri la propria disponibilità ad offrire asilo ai militanti della XXII ottobre in cambio della liberazione di Sossi, cosa mai c’entrano la Cia, la Nato, gli americani, la P2? E’ una storia tutta interna alla terribile dialettica del movimento comunista. Dubito che Flamigni non abbia avuto mai conoscenza dei documenti della federazione di Reggio Emilia. Sulla storia delle Brigate rosse la sua posizione è dettata da una malafede totale.
La testimonianza di Flamigni sulla telefonata è stata molto importante: tu dici dolosa, posso concordare, io ti dico dolorosa. Intendiamoci non giustifico il complottismo, non mi piace e credo sia chiaro, penso anche, però, che per molti militanti e dirigenti del Pci di quella generazione e di quella successiva sia stata incomprensibile la rottura. Per quanto conoscessero, a fondo anche per via dell’infiltrazione che praticavano in molti gruppi, le tematiche che si agitavano dentro la sinistra rivoluzionaria non hanno mai compreso e non sono riusciti a processare quello che, ai loro occhi, era un tradimento. Di fronte a questo tradimento hanno reagito costruendosi una comoda realtà parallela nella quale chiunque rifiutasse la via Pci era, per forza, manipolato o peggio prezzolato. Lo dico nel libro, il livello di paranoia era altissimo ma, allo stesso tempo, sono gli anni delle stragi e delle trame neofasciste non possiamo non tenere conto di questo dato. Se mi chiedi cosa c’entrassero la Cia o la Nato con l’operazione Sossi ti dico: assolutamente nulla. Allo stesso tempo quei soggetti erano presenti in modo decisivo nel paese in quegli anni. Lo spettro dell’interferenza americana era una costante ad ogni livello. Ripeto il disastro creato dal complottismo è enorme e serviranno anni per uscirne ma allo stesso tempo non si deve ignorare che le trame per la destabilizzazione del paese c’erano ed erano reali. Sia chiaro il complottismo non fa bene alla ricostruzione storica di quegli come di altri eventi ma è altrettanto vero che per decenni si è chiesta una verità almeno storica sulle stragi e siamo ancora lontani dall’aver accesso a tutti i documenti che, probabilmente, farebbero chiarezza su molti aspetti.
Sulla questione delle stragi, della cosiddetta “strategia della tensione” che ritengo una categoria inadeguata, tendo a separare il dato storiografico assodato, gli attentati dinamitardi realizzati in grande quantità in quegli anni dall’estrema destra con la supervisione, il controllo a distanza, il lasciar fare, degli apparati, le connessioni con alcuni servizi militari esteri, dall’uso politico che di tutto ciò si è fatto. La denuncia di trame e complotti è diventato dentro la sinistra un alibi per giustificare i propri fallimenti politici, l’incapacità di leggere i mutamenti di fase, giustificare la continua ricerca di un capro espiatorio su cui riversare i propri insuccessi: da Portella delle Ginestre fino al ponte di Genova, la storia della Repubblica viene letta come un continuum criminale di trame animate da un disegno comune, una «scatola nera unica», come ha scritto tempo fa Travaglio (che di sinistra non è). De Lorenzo, le stragi, Moro, l’agenda rossa, Berlusconi, la trattativa Stato-Mafia. Penso ad un magistrato come Guido Salvini che tanto ha fatto per ricostruire le vicende di piazza Fontana e Brescia. Nominato consulente della commissione Moro 2, chiusasi senza risultati, si è mosso con lo stesso paradigma di pensiero. Convinto che la storia delle Br e del sequestro Moro non fosse diversa da quella delle stragi di Stato, ha fatto una pessima fugura.
Come sai mi sono occupato per parecchi anni, ed ancora lo faccio, di estremismo di destra e neofascismo, quindi, parlo con un poco di letture alle spalle e quel minimo di approfondimento della questione: sono d’accordo quando dici che “strategia della tensione” è una categoria inadeguata, tanto quanto lo è quella di guerra civile strisciante per intenderci. Ci siamo, forse, tutti me compreso adagiati su questa dicitura giornalistica che, però, ha il pregio dell’immediatezza. Di nuovo debbo spezzare la risposta in due punti: in primo luogo il disegno che vede insieme pezzi degli apparati di sicurezza dello Stato, non solo italiani, ed estremismo neofascista per quanto fosse gridata a gran voce da molti, penso al libro inchiesta su Piazza Fontana che pur contenendo alcuni errori si rivelò nel tempo piuttosto preciso, tu sai bene quanti anni ci sono voluti per appurare da un punto di vista penale e storico quei legami e quelle responsabilità. Questo ci rimanda direttamente alla costante e meticolosa opera di disinformazione posta in essere da quel grumo di poteri che comprendevano mass media, uomini d’affari, pezzi della maggioranza governativa, alte schiere militari, solo per citarne alcuni. Capisci che in quegli anni fu estremamente difficile per tutti riuscire ad intravedere la verità dietro quella cortina di fumo. Per quel che riguarda, invece, l’uso strumentale che una certa sinistra ha fatto nel corso degli anni dello stragismo, io credo che ci sia un’ulteriore precisazione importante: tu parli di incapacità di leggere i mutamenti e posso essere d’accordo, io, però, non sottovaluterei delle scelte che vengono fatte in maniera consequenziale. L’idea della trasformazione dell’Italia in una democrazia parlamentare maggioritaria all’interno della quale il Pci si trasformasse in un partito socialdemocratico era l’asse portante della strategia di Moro ma non è che a Botteghe Oscure non lo sapessero. L’idea che bisognasse uscire da una fase di contrapposizione sociale fino ad espellere qualsiasi forma di contrasto, Schmitt direbbe di politica, non è un’idea soltanto della Dc. Allora, io credo che i risultati di alcune inchieste saranno sempre poveri se non si fa lo sforzo di comprendere come sia cambiato il quadro di riferimento politico, e anche sociale, del paese tra la metà degli anni ’70 fino al 1992 con la scomparsa dei regimi sovietici.
Veniamo agli aspetti, a mio avviso, problematici della tua ricerca: introduci una periodizzazione innovativa che anticipa di due anni la svolta delle Br con l’assalto alla sezione missina di Padova, del 1974, anziché con l’azione Coco del 1976.
Le periodizzazioni in storia sono sempre difficilissime; quello che ho tentato di fare è di dare unitarietà alla storia brigatista di quei primi anni. L’omicidio Coco è la continuazione dell’operazione Sossi ma, nel frattempo, l’omicidio è già entrato nella storia delle Br. Inutile nasconderci dietro un dito il fatto che a morire siano stati due militanti missini per anni ha fatto sì che questo episodio venisse in qualche modo derubricato a momento secondario e minore. Le divisioni tra prima e dopo non mi fanno impazzire ed il tentativo di riportare la morte di Giralucci e Mazzola dentro l’alveo della storia brigatista, a mio parere, è una parte importante di un ragionamento: le Br erano un gruppo armato e la questione, almeno a livello teorico, era patrimonio culturale e politico condiviso. Su questo, infatti, c’è una distanza enorme con altre sigle che in quel periodo avevano le stesse pratiche ma non rivendicavano come la nascente Autonomia Operaia. Se assumiamo la rivendicazione, di cui parlerò dopo, come gesto politico allora gli va dato il giusto peso ed a quel momento che, ricordiamolo, avviene a ridosso della strage di Brescia, va attribuita una valenza che può fare da spartiacque anche se, ripeto, vedo una rottura nella storia brigatista almeno non fino al cambiamento sociologico portato dal movimento del ’77 che fu, effettivamente, peculiare.
E’ vero, la scelta di assumere politicamente quelle uccisioni ha una valenza particolare sempre sottovalutata dal punto di vista storiografico, vicenda che per altro provocò la rottura dell’asse con Negri e l’uscita dei suoi dalla rivista Controinformazione. E’ anche vero che questo episodio smonta l’artificiosa suddivisione tra prime Br, vere, integre e buone, e le successive: quelle morettiane, sanguinarie e “dubbie”. L’orizzonte dell’omicidio politico era già stato oltrepassato ben prima, quando a dirigere il gruppo c’erano ancora Curcio e Franceschini. Inoltre, pochi mesi dopo, a settembre, Carlo Picchiura, membro della nascente colonna veneta, in un conflitto a fuoco occasionale ad un posto di blocco uccise un agente di polizia. Tuttavia, la vicenda di Padova fu un incidente di percorso: un’azione pianificata male e realizzata peggio. L’azione Coco resta un punto di svolta perché dopo una fase di confronto nazionale, una sorta di tavolo comune che riuniva diversi gruppi e aree combattenti, le Br rompono gli indugi e tornano sulla scena concludendo l’azione Sossi, dopo aver avviato una importante riorganizzazione interna e logistica. Stavolta non vi è nulla di improvvisato ma l’intenzione di indicare a tutto il movimento rivoluzionario quale è la via da seguire se si vuole fare la lotta armata in Italia.
L’azione Coco è un’azione preparata e pensata come risposta diretta di tutta l’organizzazione alla campagna contro Sossi, su questo punto non ci piove. Ed il momento di confronto con le altre sigle rafforza la mia idea. Eravamo in una fase di stallo dal punto di vista di coloro i quali pensavano alla lotta armata. Rimane, a mio parere, importante l’azione padovana perché per chiunque, persino per le “cattivissime” Brigate rosse, uccidere un uomo (o due come nel caso specifico) è un passo gigantesco. Affermare i principi della lotta armata e praticarli sono cose diverse. L’azione padovana è pensata (non è per intenderci un brigatista che vistosi fermare ad un posto di blocco inatteso, spara) ed attuata male, lo dicono tutti. La mia domanda di ricerca, la cui risposta come capita a chiunque può anche non essere corretta, è stata: nella pianificazione di quell’azione pensata e svolta così male c’è la possibilità che alcuni membri delle Br abbiano visto un’opportunità? In realtà non ho fatto altro se non trattare le Br per quelle che furono, cioè un gruppo politico armato, e sgombrare il campo da un mostro mitologico che è stato rappresentato come un cubo unanime e non scalfibile.
Altra questione da te proposta è la presenza di una dialettica interna tra una presunta ala militare e un’ala politica, dovuta – secondo quanto sostieni – alla divisione che ci fu a conclusione del sequestro Sossi. Uno strascico che avrebbe provocato una forzatura dell’ala militare nell’azione di Padova.
Questo punto che è stato sviluppato dentro la trattazione del duplice omicidio padovano è, probabilmente, la parte più complessa del libro e mi preme fare due precisazioni anche se so che su questo punto specifico ci possono essere disaccordi. Prima precisazione: la retorica delle Br come cubo d’acciaio l’ho sempre trovata un’invenzione. Le Br furono un gruppo politico e come all’interno di ogni altro gruppo politico che vi fossero scontri sulla linea è un dato di fatto. Credo che sorvolare su questo aspetto alimenti l’idea di chi crede all’esistenza del cervello unico, cosa che nella storia dei gruppi politici non è mai esistita neppure nella destra neofascista. Il tentativo di articolare questa visione intorno al nodo del “passare all’azione” mi sembrava fosse quasi naturale visto le ricostruzioni fatte da molti dei protagonisti del tempo ed alla luce dell’esito finale dell’operazione Sossi che, anche se frutta al gruppo una visibilità politica enorme, non raggiunge l’obiettivo della scarcerazione dei militanti della XXII ottobre. Il secondo punto si annoda inevitabilmente al primo ed ha a che fare con il teorema 7 aprile. Ho già detto di non credere ai cattivi maestri e non credo nemmeno all’esistenza del partito armato. Credo, invece, nell’esistenza di una galassia armata all’interno della quale c’era un dibattito, a volte anche aspro, tra organizzazioni e dentro la stessa organizzazione. Credo che il passaggio di militanti da una sigla all’altra fosse nell’ordine delle cose. Non vedo, però, rapporto di subordinazione o capi né tra gruppi che internamente ai gruppi stessi. Se il capo delle Br non è mai esistito, potevano esserci, semmai, singoli che avevano più o meno influenza dentro un dibattito, la “leggerezza” con la quale viene preparata l’effrazione nella federazione del Msi la leggo, a pochi giorni dallo scontro su Sossi e a ridosso dalla strage neofascista di Brescia, come una parte di quel dibattito interno. Non penso, insomma, a due “ali” contrapposte che non condividevano l’idea di fondo della lotta armata ma ad un dibattito articolato che, in un gruppo armato, si materializza non soltanto nella rivendicazione ma nella prassi.
Che nelle Br si discutesse molto e ci fossero sensibilità, culture e nel tempo fossero emerse linee diverse, è un fatto storicamente accertato. Esiste una mole documentale importante, ci sono le molteplici scissioni, i distacchi, gli abbandoni. Le Brigate rosse sono state attraversate dagli anni 70, molti militanti vi hanno transitato – come tu stesso ricordi – per periodi più o meno brevi per poi uscirne per ragioni non sempre personali: basti anche solo pensare a Gianfranco Faina, comunista libertario, che contribuisce in modo decisivo alla nascita della colonna genovese e che presto si distaccherà per fondare un suo gruppo, o Corrado Alunni, Susanna Ronconi e Fabrizio Pelli che esce su posizioni libertarie. Il problema è definire in modo corretto i termini della dialettica interna: il dualismo che tu proponi subito dopo Sossi mi sembra errato anche nella scelta degli interpreti.
Di nuovo io credo che sia quello il nodo del dibattito; in un’organizzazione armata che le contraddizioni che emergono nel corso di un dibattito politico possano avere delle ripercussioni, dirette o indirette, nell’azione a me non sembra peregrino. Come dico nel libro non ho mai creduto alla divisione in “ala militare” ed “ala politica” perché la scelta della lotta armata era condivisa da tutti. La questione semmai si innesta sull’opportunità e mentre per Coco questa opportunità sarà largamente condivisa, l’azione padovana è confusa al punto che alcuni membri sicuramente carismatici come Curcio lamenteranno di non esserne stati informati in modo esaustivo. Allo stesso tempo mi sembrava interessante, non dico che sia la sola chiave di lettura, perché c’è l’elemento dell’inchiesta interna, doverosa visto il risultato tragico dell’azione, che le Br svolgono (anche questa era prassi normale) e che non divide l’organizzazione in ali; per intenderci lo stesso militante poteva essere in generale più cauto sulla questione Sossi ed avere, invece, l’idea che quell’incidente sul lavoro avesse, in realtà, “sbloccato”, il dibattito interno.