Autoassoluzione: reintegrati i medici indagati per la morte di Stefano Cucchi nonostante siano sotto inchiesta per omicidio colposo.
Per la Asl non ci sarebbe stato “abbandono terapeutico”. Il decesso sarebbe frutto di un evento imprevedibile
Paolo Persichetti
Liberazione 1 dicembre 2009
Sono stati reintegrati nel reparto penitenziario dell’ospedale Sandro Pertini i tre medici indagati per omicidio colposo dopo la morte di Stefano Cucchi. Eppure quanto è trapelato dagli accertamenti medico-legali sul corpo riesumato del giovane, deceduto il 22 ottobre scorso all’interno della struttura ospedaliera dopo una settimana di agonia seguita ad uno, o più, pestaggi e sevizie violentissime (sul numero esatto, e gli autori delle percosse subite, ancora oggi permane l’incertezza), confermerebbe le responsabilità dei sanitari nella sua morte. Il blocco della vescica riscontrato su Stefano Cucchi sarebbe, infatti, compatibile con la paralisi dell’ultimo tratto della colonna vertebrale. 
Mentre le lesioni alla schiena e alla testa, seppur serie, non sarebbero state letali se adeguatamente curate. Insomma tutto lascia seriamente supporre che nei confronti di Cucchi vi sia stato un «abbandono terapeutico», una situazione di lassismo e incuria, una sottovalutazione grave e colposa delle sue condizioni di salute e delle cause che le avevano originate. Nonostante ciò, l’indagine amministrativa interna condotta da una commissione, apparentemente composta da personale della medesima Asl, ha sbrigativamente liquidato l’accaduto come «un evento non prevedibile». Nella relazione depositata ieri, si può leggere che l’analisi dei fatti, a fronte del «carattere improvviso e inatteso del decesso, non ha messo in luce, sul piano organizzativo e procedurale, alcun particolare elemento relativo ad azioni e/o omissioni da parte del personale sanitario con nesso diretto causa-effetto con l’evento avverso in questione. Contestualizza e configura pertanto l’oggetto dell’indagine sotto il profilo di evento non prevenibile». Per questo motivo Il direttore generale dell’Asl RmB, Flori Degrassi, ha disposto la revoca dell’ordine di trasferimento, preso in via provvisoria il 18 novembre scorso, nei confronti di Aldo Fierro, Stefania Corbi e Rosita Caponetti. La diffusione della notizia ha subito suscitato sconcerto e raccolto i commenti negativi del legale della famiglia, Fabio Anselmo, di Patrizio Gonnella dell’associazione Antigone, e di Luigi Nieri, assessore al Bilancio della regione Lazio, che ha censurato una «decisione affrettata e profondamente sbagliata», rilevando come sia piuttosto inusuale «che la Asl concluda la propria inchiesta amministrativa prima di quella penale».
La decisione presa dalle strutture dirigenti dell’ospedale Pertini non si discosta molto da quello spirito corporativo che ha fino ad ora caratterizzato il comportamento di tutti gli altri attori coinvolti in questo terribile esempio di violenza istituzionale. Chiusura a riccio e omertà d’apparato in difesa di una impunità di principio che vorrebbe imporre l’idea della insindacabilità dell’operato di chi agisce in uniforme di Stato. Un atteggiamento viziato da una visione autoreferenziale della legalità e della morale. Alcuni apparati molto potenti non hanno mai accettato di essere messi sul banco dei sospetti e fin dall’inizio hanno operato nell’ombra, mettendo le briglie a un’inchiesta che altrimenti rischiava di mostrare il «re nudo». Mentre negli ultimi giorni nuove testimonianze di detenuti, presenti nell’infermeria di Regina Coeli con Stefano Cucchi, hanno riaperto scenari su violenze precedenti l’arrivo in tribunale, che la procura ha sempre evitato di approfondire ritenendoli privi di riscontri (ma l’inchiesta serve per trovare eventuali riscontri, non per escluderli a priori), da parte degli indagati emerge una nuova strategia. Non più scarica barile tra penitenziaria e carabinieri, ma fuoco concentrico sulla persona di Cucchi, dipinto come uno che entrava e usciva dal pronto soccorso degli ospedali. Un modo per dire che era già «rotto» prima di essere arrestato. E come se non bastasse, vengono diffuse minacce a mezzo stampa facendo circolare notizie sull’apertura di una inchiesta contro i legali della famiglia Cucchi per calunnia nei confronti dei carabinieri. Un modo per dire che gli apparati dello Stato sono santuari intoccabili.
Link
http://perstefanocucchi.blogspot.com/
Stefano Cucchi: le foto delle torture inferte
Caso Cucchi, scontro sulle parole del teste che avrebbe assistito al pestaggio. E’ guerra tra apparati dello Stato sulla dinamica dei fatti
Morte di Cucchi, c’e chi ha visto una parte del pestaggio nelle camere di sicurezza del tribunale
Erri De Luca risponde alle infami dichiarazioni di Carlo Giovanardi sulla morte di Stefano Cucchi
Stefano Cucchi, le ultime foto da vivo mostrano i segni del pestaggio. Le immaigini prese dalla matricola del carcere di Regina Coeli
Manconi: “sulla morte di Stefano Cucchi due zone d’ombra”
Cronache carcerarie
Stefano Cucchi, quella morte misteriosa di un detenuto in ospedale
Stefano Cucchi morto nel Padiglione penitenziario del Pertini, due vertebre rotte e il viso sfigurato
Caso Stefano Cucch, “il potere sui corpi è qualcosa di osceno”
Violenza di Stato non suona nuova
Ignorata la disponibilita offerta da un gruppo di detenute che si offrì di assistere la Blefari. I magistrati puntavano al pentimento
Induzione al pentimento
Suicidio Blefari Melazzi: l’uso della malattia come strumento di indagine

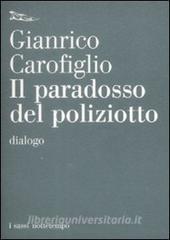 «Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».
«Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».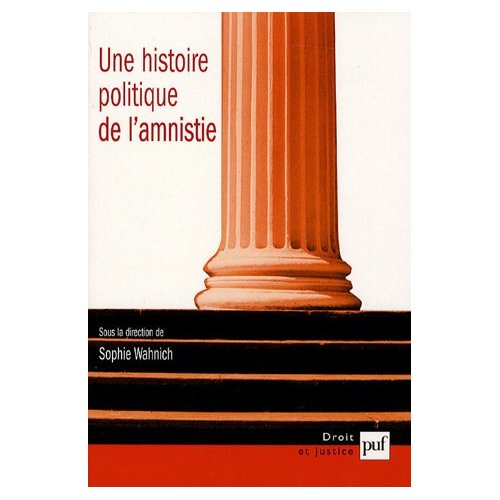 Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.
Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.