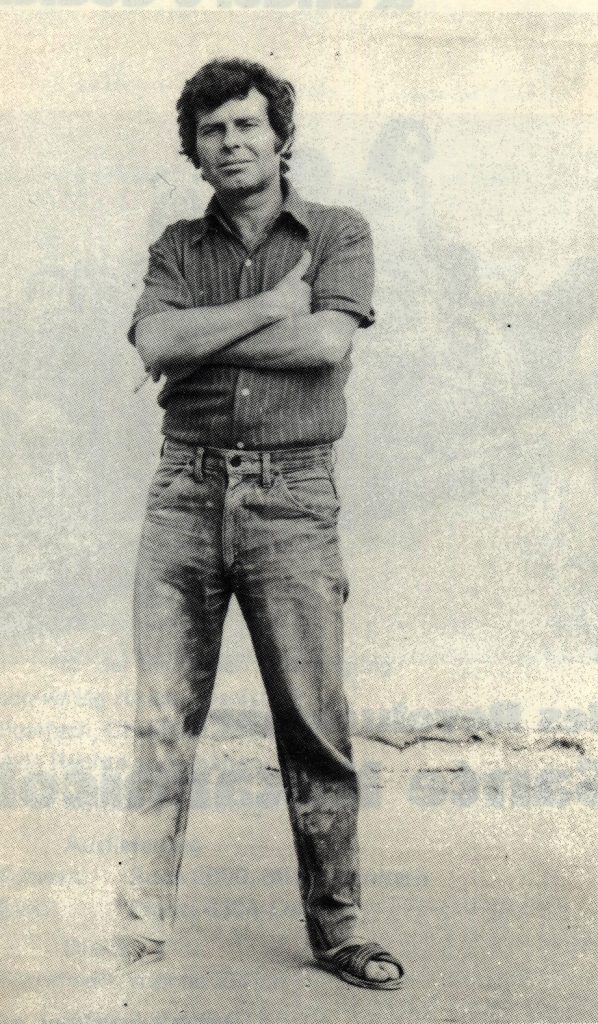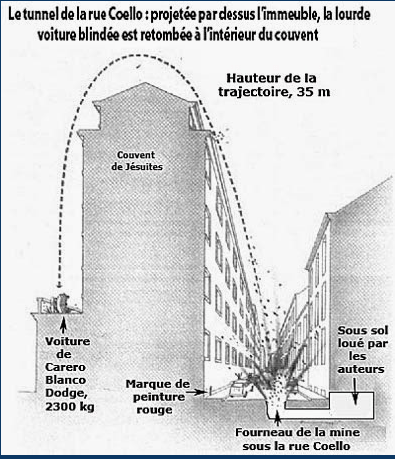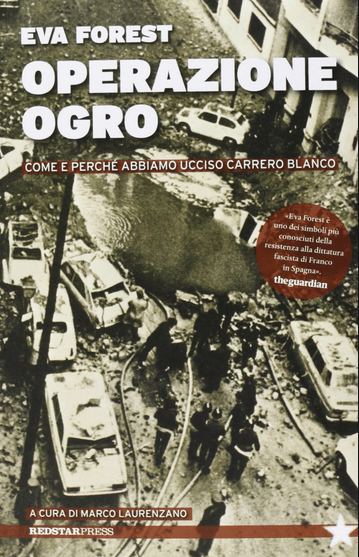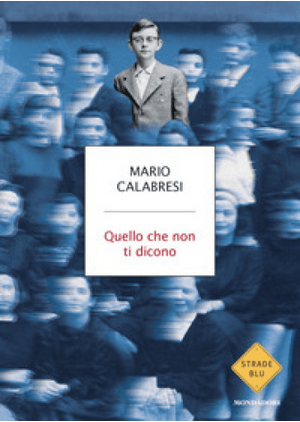Il ruolo politico, assolutamente centrale, avuto dai militanti prigionieri nella vicenda brigatista, una caratteristica che innova sulla consueta tradizione rivoluzionaria che vedeva invece i prigionieri esclusi dalla vita politica dell’organizzazione esterna; il peso da loro giocato in alcuni passaggi cruciali: dal rapimento Moro, alla successiva contestazione della Direzione esterna con rivendicazione non solo dell’elaborazione della linea politica ma anche della direzione dell’organizzazione, fino alle spinte scissioniste che portano le Br alla spaccatura in più tronconi. La difficoltà di far capire al collettivo dei prigionieri che l’alto livello delle lotte nelle carceri speciali non era riproducibile all’esterno, dove il riflusso aveva travolto i movimenti sociali e negli stabilimenti Fiat prendeva forma la sconfitta della classe operaia. L’incapacità di mettere in pratica una nuova strategia dopo il rapimento Moro, la fine di una elaborazione unitaria con la fuga in avanti di chi credeva fosse maturo il tempo della «guerra civile dispiegata» o riteneva una soluzione rinchiudersi nel recinto della fabbriche, già stravolte dalla ristrutturazione produttiva. Lo smantellamento di intere colonne causato dal fenomeno dei “pentiti”, le torture dispiegate contro gli arrestati e il rifiuto di riconoscerle di una parte importante dei prigionieri, la proposta di «ritirata strategica» che suscitò aspre reazioni e successive scissioni sul modo di interpretarla. Barbara Balzerani riflette sulla sua esperienza all’interno della Brigate rosse a partire dal bilancio elaborato a metà degli anni 80 da un gruppo di militanti, a loro volta confluiti nelle Br-pcc
Silvia De Bernardinis, Venerdì 19 marzo 2021
È uscito da poche settimane il libro che ho curato, Brigate rosse: un diario politico, per DeriveApprodi. Chi lo leggerà si troverà di fronte a un testo, se non distante, sicuramente differente dalle ricostruzioni storiche fatte dagli storici. È un’analisi densa, complessa e non facilmente sintetizzabile se non per linee generali, con una costruzione del testo metodologicamente molto chiara che analizza pezzo per pezzo la storia brigatista: parte dal contesto politico, prende in esame partiti politici, movimento di classe, sinistra rivoluzionaria, guerriglia e antiguerriglia, proposta politico-strategica delle Br e verifica alla prova dei fatti. Una ricostruzione a 360 gradi che è storia delle Br e storia dell’Italia degli anni 70, al di là delle intenzioni degli autori. Più che farti domande ti propongo alcuni temi di carattere generale che emergono dal testo su cui può essere utile spendere qualche parola. Diciamo prima di tutto che i compagni protagonisti del confronto, delle discussioni da cui ha origine il documento che DeriveApprodi ha deciso di pubblicare, sono stati tra quelli con cui hai condiviso sia la fase iniziale della tua esperienza nelle Br, nella colonna romana, sia il periodo successivo, quando ti sei ritrovata a gestire in un ruolo dirigente l’eredità brigatista e la parte finale della sua storia, per usare le tue parole, a cercare di «tradurre in pratica politica e organizzativa quel controverso bilancio». Fa eccezione Carlo Picchiura che hai conosciuto dopo il tuo arresto, nel 1985, durante i processi, uno dei pochi che dal carcere aveva aderito alle Br-Pcc dopo la spaccatura. Si tratta dei compagni politicamente più vicini e di discussioni che hai vissuto direttamente.
Si, ed è difficile parlarne ora che Piero, Gigi, Salvo e Picchio non ci sono più. Mancanze, tra le altre, che hanno reso ancora più vuoti questi anni così difficili da vivere. I legami nelle Br non sono mai stati familistici visto il prevalere su tutto della buona salute dell’Organizzazione e la precarietà della nostra vita a piede libero, ma è indubbio che il sentire i compagni un bene prezioso di cui godere e da preservare, dava forza anche nelle condizioni più dure e compensava la provvisorietà del domani di ciascuno di noi. La fiducia incondizionata è una reciprocità di sguardo che non sempre la politica concede ma che pareggia i conti con le proprie paure e incertezze quando si ha la fortuna di viverla. Cercare di essere all’altezza dell’altro insegna a superare la competizione e i protagonismi. Credo renda migliori.
Questa pubblicazione rende giustizia a una realtà misconosciuta che poco appare nella storia delle Br. Infatti nella vulgata con cui è raccontata emergono pochissimi nomi in confronto ai tanti militanti che l’hanno attraversata e alla loro qualità. Anche questo concorre alla distorsione del suo patrimonio politico e del senso stesso dell’agire in un’organizzazione di comunisti. Come se non fosse un prodotto collettivo in cui ciascuno, per come sa e può, è essenziale a comporre il tutto ma la raffigurazione elitaria di qualche testa pensante nell’insignificanza di tanti anonimi e invisibili, senza nome, faccia e identità. E questo riguarda anche i compagni che hanno lavorato a vario titolo a questo testo dal carcere e che sono stati tra i pochi che ho avuto accanto negli ultimi difficilissimi anni di militanza. La spaccatura di cui parli, quella col Partito della guerriglia, non è stata la sola ma certamente la più devastante sia per l’inconciliabilità dell’analisi, delle tesi politiche e delle pratiche, sia per l’adesione massiccia dei nostri compagni in carcere. Cosa di non poco conto in quel periodo di scarse certezze. Per questo il testo che hai curato è ancora più prezioso, spiragli di luce nella opacità del presente per chi era rimasto fuori a resistere che, purtroppo, sono caduti nel vuoto (forse per un malinteso rigetto di ogni contributo proveniente dal carcere?) e un rimedio di senso nel dilagare di follia che sembrava imperversare tra i seguaci del partito della guerra civile in atto. Una mano tesa nella navigazione rovinosa della nostra crisi politica e del perfezionamento scissionista dei prigionieri del «nucleo storico». Le riflessioni di cui tratta il testo sono quelle che hanno impegnato i compagni prigionieri rimasti nelle Br-Pcc che non potevano che andare all’origine di una storia per poterne valutare i punti di criticità, gli errori, la necessità di adeguare l’analisi e la pratica alle nuove condizioni. Fino all’interrogarsi sulla percorribilità stessa del terreno di lotta per come l’avevamo sempre inteso, in cui l’azione armata costituiva la esemplificazione, il condensato di un programma politico reso possibile dai contenuti presenti nelle punte più avanzate del movimento rivoluzionario di quegli anni e necessario per continuare ad avanzare.
Di quelle lotte interpretavamo l’insito contenuto rivoluzionario, di potere, traducendolo in una strategia politico-militare di guerra di lunga durata. Niente a che vedere con il sindacalismo o i bracci armati dei movimenti, niente con l’insurrezionalismo. Tutte concezioni queste che caratterizzavano molta parte delle altre organizzazioni rivoluzionarie e che verranno riproposte dai diversi spezzoni in cui si è frantumata l’Organizzazione. Si è trattato di uno scontro di idee portato avanti attraverso un intenso lavoro politico all’interno dei movimenti. Questo può spiegare anche la adesione alle Br di molti compagni che avevano animato il movimento del ’77 con la sua radicalità di contenuti, disperso dai carrarmati di Cossiga e la sua impossibilità di tenuta attraverso scontri armati di piazza.
Alcune considerazioni sul testo: il contesto, il fine per cui è stato scritto e il metodo con cui è stato scritto questo documento gli danno alcune qualità: prima di tutto non è un documento ideologico ma politico, il fatto di non dover sostenere una tesi lo mette al riparo dal pericolo di forzare la realtà alla propria tesi. Un’analisi concreta su fatti concreti, marxista. Considerando il momento in cui viene proposto, dominato da un dibattito pressoché ideologico, riflesso della crisi delle Br, mi sembra un dato significativo. Inoltre, sia il fatto che nasce per cercare di risolvere i punti critici e i limiti nella condotta della guerriglia e per capire se e quali fossero gli scenari possibili per la lotta armata, sia il fatto di essere scritto a partita non ancora formalmente conclusa, fa sì che non cada in autogiustificazioni, rischio sempre presente nelle ricostruzioni ex post.
Si, la metodologia adottata dagli estensori è propria di un contributo di analisi politica e non ideologica, né tantomeno programmatica. Non è un caso che quei compagni sostenessero la battaglia politica in corso a fianco delle Br-Pcc anche a partire dal ruolo che i prigionieri avrebbero dovuto assumere nel dibattito interno. Questo è un capitolo importante nella nostra storia e ne riflette luci e ombre. I nostri prigionieri avevano sempre avuto una grande importanza nelle dinamiche interne dell’Organizzazione. Erano la nostra faccia pubblica, erano tra i fondatori dell’Organizzazione, avevano grandi capacità politiche, erano i magnifici protagonisti del processo guerriglia e delle lotte in carcere. Ma, forse anche a causa della contraddittorietà dei nostri dispositivi interni, bisogna concludere che hanno negativamente condizionato le nostre scelte e, da un certo punto in poi, esasperato i nostri problemi politici. Soprattutto quando si è evidenziata la crisi di superamento della fase della propaganda armata e l’impasse della nostra capacità di elaborazione programmatica, le forzature da parte loro non hanno certo contribuito a dipanare la nostra inadeguatezza. In questa strettoia si è materializzato l’intervento a gamba tesa della maggior parte dei prigionieri coagulati intorno alle tesi del «nucleo storico». Non si è trattato di un contributo politico teso ad affrontare le nuove condizioni dello scontro a cavallo degli anni ’80 tutto da verificare nella pratica ma dell’elaborazione di un dettagliato programma valido per tutta l’organizzazione. Nonostante i tentativi di mediazione e di limatura degli eccessi di un’analisi completamente sballata circa le condizioni dello scontro, le tesi di una rivoluzione alle porte, mutuata dalle condizioni delle lotte in carcere, hanno cortocircuitato il già squilibrato rapporto dentro-fuori facendolo deragliare su un capovolgimento delle cause-effetto. Secondo quei compagni le difficoltà dell’Organizzazione non erano di carattere politico a fronte di una difficile transizione in una fase di offensiva del nemico e di deciso rallentamento di passo della conflittualità di classe, ma derivavano da una cattiva conduzione da parte della sua direzione. Fino al precipitare di questa bufera intestina in mozioni formali di sfiducia nei confronti dell’esecutivo e operazioni scissioniste di pezzi dell’organizzazione. Va sottolineata la varietà di tesi politiche delle varie fazioni in cui s’è frantumata la compagine Br, dal sindacalismo armato, allo scioglimento nel movimento, alla centralità dei settori emarginati e del carcere, tutte però confluenti nel chiedere legittimità ai prigionieri. Su tutto è emersa la velleità di superamento della crisi attraverso la decapitazione della direzione nazionale ritenuta un freno alle potenzialità rivoluzionarie delle masse nel presente. Sta di fatto che la debolezza dell’organizzazione ha reso possibile l’impensabile, ossia la pretesa di una sua direzione dall’interno del carcere. E se questo, nei fatti, ha dimostrato tutta la sua non praticabilità ha anche avuto tutto l’agio di aumentarne le difficoltà. In tutta evidenza la qualità e le finalità del contributo del testo in esame è di tutt’altra natura e rispondeva al compito da parte dei prigionieri di dare un supporto all’organizzazione nella lettura della fase più difficile della sua storia, senza interloquire nella linea politica. Contributo politico senza sconti e reticenze che quei compagni assolvevano nella consapevolezza di avere come compiti fondamentali non essere di intralcio all’Organizzazione esterna, di tenere conto dei rapporti di forza per non creare condizioni di detenzione invivibili e, all’occasione, segare le sbarre e raggiungerci. Nella consapevolezza di essere ostaggi del nemico, sottoposti a un incessante controllo e impossibilitati a verificare nella pratica le loro tesi. Nella assunzione di una responsabilità collettiva e non personalistica di cui rendere conto. E nonostante il minoritarismo, il ritardo e la scarsa efficacia nel riuscire a contenere la frana sotto cui è rimasta seppellita persino la memoria del nostro tentativo di «assalto al cielo», resta un documento decisivo per chiunque voglia comprenderne la complessità, al di là delle celebrazioni o della svendita. Soprattutto perché quei nodi politici su cui anche le Br si sono incagliate sono rimasti irrisolti. In primis dai fuoriusciti che, va sottolineato, a decenni di distanza non si sono curati di fare un bilancio delle loro scelte e renderne conto, come le Br hanno sempre fatto.
Il testo, proprio per come è costruito, fa emergere con grande chiarezza il significato di lotta armata come strategia politica, un concetto molto ben definito nella storia delle Br, come hai appena chiarito sopra, e che anche all’interno delle Br nel periodo della crisi è stato confuso con altro, e di cui oggi ancor di più, per il modo in cui è stata divulgata nel senso comune non solo la storia delle Br ma tutto il contesto degli anni ’70, si è persa traccia. Le Br nascono dalle lotte del 1968-69 e attraversano tutto il ciclo di lotte degli anni 70, e anzi si spingono anche oltre. Si trovano ad agire in due contesti diversi, e in condizioni diverse, e cioè, in un lasso di tempo brevissimo, tra il 1974 e il 1978-79, passano dall’esercitare un certo peso all’interno delle fabbriche, a esercitare un peso politico a livello nazionale. Un passaggio che avviene in un contesto diverso da quello che ne ha segnato la nascita e coincide con un processo di ristrutturazione mondiale in corso, da una situazione che vede la classe operaia all’offensiva ad un quadro che si fa sempre più resistenziale. Vi trovate in un groviglio di contraddizioni.
Il progetto politico delle Br nasce sulla concezione guerrigliera di dimostrare la fattibilità oltre che la necessità di assunzione di una mentalità e una strategia offensive. Nelle migliori tradizioni del movimento rivoluzionario non si trattava di concepire la legittimità della lotta armata come reazione difensiva alla violenza dello Stato in una dinamica a perdere di rincorsa della repressione né tantomeno giustizialista. Era il livello e la qualità dello scontro di classe che la motivavano. Credo che le lotte operaie che avevano conquistato l’autonomia di classe ne fornissero un inequivocabile esempio nella prassi di guadagnare terreno e strappare conquiste sul campo stando sempre un passo avanti alla mediazione contrattuale. Nei graduali aggiustamenti della linea politica nel vivo dello scontro, attenzione massima era rivolta a una analisi in grado di esaminare i piani strategici del capitalismo per poterne anticipare le mosse. Questo in un quadro di belligeranza di una parte significativa del movimento operaio e rivoluzionario e di rafforzamento del campo rivoluzionario internazionale. La focalizzazione del processo di perdita dell’autonomia nazionale dei paesi capitalistici (nascita dello Sim) ne è una esemplificazione a fronte di una progettualità del nemico di governo della crisi del modello fordista, globalizzando i mercati e accentrando il capitale finanziario, delocalizzando le fabbriche, ristrutturando la produzione, precarizzando il lavoro e le condizioni di vita di vasti settori proletari. E, su tutto, dichiarando guerra alla conflittualità, condizione sine qua non per garantire i profitti delle aziende multinazionali. Al grande capitale occorreva stabilire nuovi margini della democrazia parlamentare che potevano contenere sia colpi di stato e dittature (come in Cile e in Argentina) sia l’autoritarismo «ferreo» di governi alla Thatcher. Da questo punto di vista si rende comprensibile il salto all’attacco al cuore dello Stato come scelta strategica delle Br per rinsaldare e dare prospettiva ai rapporti di forza favorevoli conquistati nelle fabbriche e nei territori. Questo il quadro ed è indubbio che, almeno in Italia, i progetti della ristrutturazione liberista della produzione e dei rapporti sociali non hanno avuto vita facile grazie al movimento rivoluzionario e alla lotta armata. Quadro che cambia con l’arretramento di quel movimento e le modificazioni a livello internazionale a favore del fronte imperialista.
Che la tendenza dei programmi del grande capitale fossero quelli analizzati è da tempo sotto gli occhi di tutti nella loro piena realizzazione. Negli anni in cui le Br l’hanno teorizzata erano appunto una tendenza, un processo e non un dato di fatto, soprattutto nell’«anello debole della catena» come l’Italia. Dentro questo quadro contraddittorio abbiamo oscillato tra una visione materialistica dello stato delle cose presenti e la sballata convinzione di un precipitare all’ordine del giorno delle dinamiche di rinnovamento/riorganizzazione della politica e dell’economia. Per questo nella testa di qualcuno si era formata la convinzione che non rimanesse che armare le masse essendosi esaurito ogni spazio di tutela dei loro interessi materiali immediati. Ammesso che le condizioni di una rottura rivoluzionaria ci fossero, i tempi in politica non sono un accidente che si possono dilatare o accorciare a proprio piacimento e i nostri sono stati decisamente sfasati mancando la periodizzazione della «lunga durata» e il suo andamento affatto lineare. Fino a che tutto è diventato una rincorsa a fiato corto nel tentativo di rimediare agli errori. Fuori tempo massimo.
C’è un dato che sembra essere costante nella storia delle Br, contraddittorio perché al tempo stesso ne costituisce la forza e l’originalità ma anche uno dei punti deboli e dei limiti, e cioè il carattere sperimentale, che discende dalla loro eterodossia. Il non avere modelli di riferimento gli dà la libertà e le mette in condizione di dover sperimentare. Come si dice nel testo, si parte «da una base progettuale che tende a precisare, per approssimazioni successive, la propria proposta politico-strategica, come anche le soluzioni tattiche».
Ma la sperimentazione non è sempre stata la caratteristica dei processi rivoluzionari? A quale modello si è ispirata la Cina di Mao, la Cuba di Castro o le guerriglie dell’America latina? A quale la rivoluzione dei curdi del PKK, dei greci del «17 novembre», dei compagni dell’Eta, degli zapatisti e quella guidata da Sankara? È certo esistito un paradigma rivoluzionario novecentesco che ne ha dettato i caratteri generali ma sul terreno della pratica ciascuno ha dovuto fare i conti con la propria composizione di classe, con la storia e le tradizioni sociali del proprio paese, con la propria collocazione in ambito internazionale, con il grado di consenso/controllo del potere e, soprattutto, con il livello dello scontro di classe. Se il Partito comunista cinese avesse dovuto considerare la classe operaia il soggetto centrale del processo rivoluzionario, avrebbe dovuto inventarsela. E non è forse vero che certe direttive da Mosca abbiano «ingessato» l’andamento delle rivoluzioni specie nei paesi in via di decolonizzazione? Noi siamo stati il frutto di una fuoriuscita dal modello insurrezionale, partito-esercito, ormai impraticabile nelle situazioni metropolitane al livello di maturazione del conflitto rivoluzione/controrivoluzione. Troppi i dispositivi di controllo, non ultimi quelli di partiti e sindacati. Troppi i livelli di differenziazione e relativa mediazione. Al contrario la guerriglia offriva un modello di possibilità di attacco anche ad alto livello con una forza militare ridotta. Quello che conferiva incisività non era la sua endemicità. Ossia non era decisiva la quantità e il livello delle azioni messe in campo quanto la capacità di cogliere il maturare delle contraddizioni di classe, i piani del nemico, i punti deboli del suo schieramento, il livello del peso politico della guerriglia nel movimento rivoluzionario. Questo ha comportato la necessità di affinare le armi dell’analisi di contesto e compiere i salti necessari per non perdere la capacità offensiva e disperdere i rapporti di forza conquistati. Ossia sperimentare sul campo la validità delle proprie analisi.
Diversamente da altre organizzazioni combattenti le Br hanno sempre identificato nella Dc il nemico principale. Ma il ciclo di lotte di quegli anni vede anche lo scontro tra due vie e due concezioni presenti all’interno del movimento operaio: da una parte la tradizione terzinternazionalista e il progetto di integrazione della classe operaia nello Stato e dall’altra la centralità del conflitto capitale/lavoro, la guerra di classe, la distruzione dello Stato. Compromesso storico e attacco al cuore dello Stato.
Si, nonostante il peso dell’azione controrivoluzionaria del partito e del sindacato comunisti le Br hanno condotto una battaglia politica nel movimento per affermare la centralità della Democrazia cristiana nel campo nemico. Tra noi e i comunisti c’era una contrapposizione di altra natura. Proprio perché si trattava del conflitto tra due anime interne alla classe, per dirla alla cinese, si trattava di una «contraddizione in seno al popolo» e come tale andava trattata. La presenza negativa del più grande partito comunista d’occidente in questo paese non è certo stata secondaria nel procedere dello scontro, ma questo nulla toglie al fatto che si trattasse di contraddizioni reali che vivevano all’interno della classe operaia. La Dc deteneva il potere e non lo avrebbe mai ceduto ai comunisti, nonostante la loro forza elettorale e la loro fattiva collaborazione. Proprio le vicende legate alla «campagna di primavera» ne sono una dimostrazione: il governo sarebbe rimasto ed è sempre rimasto saldamente in mano alla Dc mentre i loro «alleati» perfezionavano la loro deriva socialdemocratica. Ai comunisti sono andati incarichi di «lavori sporchi» di contenimento e repressione e per questo sono stati particolarmente invisi nell’ambito dei movimenti. Non senza qualche ragione. Ma per arrivare al governo hanno dovuto cancellare il peccato della loro origine nel campo comunista, mai del tutto amnistiato nell’occidente capitalistico, sconfessare ideologia e alleanze, cambiare nome e cognome. Nel conflitto degli anni ’70, secondo la nostra visione, erano sì lo Stato ma quello interno alla classe operaia. Nei loro confronti andava usato il bisturi più affilato. La gestione autocritica dell’azione contro Guido Rossa ne è l’esempio più appropriato, come anche la fotografia di quanto lo scontro fosse interno alla classe operaia.
Stando ad una verifica dei fatti, la presenza della guerriglia non ha rappresentato un ostacolo né allo sviluppo del movimento, né alle conquiste del movimento operaio degli anni 70, al contrario, ha contribuito a spostare i rapporti di forza e ha rallentato il processo di ristrutturazione.
Su questo non ci dovrebbero essere dubbi. La forza dei movimenti in quegli anni era un concerto polifonico che andava ben oltre le differenze. E il travaso reciproco di forza funzionava almeno quanto era in grado di ottenere conquiste che mai sono state tanto rilevanti. Come è evidente, soprattutto oggi, quella sul piano sanitario. E questo al di là della autorappresentazione dei diversi soggetti in campo che, nella sconfitta, è diventata uno scarico di responsabilità da imputare alle Br. Persino le battaglie per i diritti civili non subivano danni nonostante le tesi cospirazioniste dei pacifisti impegnati nella battaglia per il divorzio mentre le Br sferravano il primo «attacco al cuore dello stato» con il processo al giudice Sossi. Ma, aspetto ancora più importante, basterebbe analizzare le vicende legate allo scontro che ha riguardato la Fiat per rendersi pienamente conto di quanto sia stata determinante la crisi della guerriglia nell’accelerazione della ristrutturazione e nell’attacco alle avanguardie interne alla fabbrica.
Ritorniamo su un punto cui accennavi sopra, e cioè il peso del «nucleo storico» in carcere. Se è vero che dal carcere non si può dirigere la guerriglia, la si condiziona, o almeno nel vostro caso sembra averla condizionata. Ribaltando il principio guida delle Br dove la pratica ha sempre preceduto la teoria, finite – parlo delle Br fuori dal carcere – per cercare di adattare la realtà alla teoria. Il documento restituisce questo processo in termini politici e in termini politici dà anche una spiegazione che ha portato alla centralità del «nucleo storico». Sintetizzando, dopo la «campagna di primavera» la fase della propaganda armata si esaurisce e le Br cercano, senza trovarlo, il passaggio alla fase successiva che il nucleo storico identifica, teorizzandolo sull’esperienza concreta delle lotte in carcere, nel passaggio alla guerra civile. Siamo nel 1979 e la Direzione Br si scontra con una realtà che al contrario non è in alcun modo assimilabile o generalizzabile con il contesto carcerario. Basti solo pensare alla vicenda Fiat. Il nodo della crisi, che non si risolverà, è che dopo la propaganda armata e in un contesto di lotte resistenziali la guerriglia – o almeno l’esperienza delle Brigate rosse – non trova soluzioni. Su questo nodo politico avviene la spaccatura all’interno delle Br.
n verità questo precipitato ha una lunga incubazione e attraversa le tappe che hanno portato a maturità la crescita politica e organizzativa delle Br. A un’analisi a posteriori si possono rilevare i chiaroscuri di un rapporto dentro/fuori che non necessariamente doveva avere un epilogo tanto negativo. E questo ha messo in evidenza errori, malintesi, incertezze progettuali e inadeguato governo delle contraddizioni interne. Esemplificativo è il passaggio del processo di Torino. Alla sbarra praticamente l’interezza del quadro dirigente originario. Si trattava del primo processo in cui lo Stato intendeva dimostrare la forza di seppellire i comunisti armati sotto secoli di galera e celebrare la sua vittoria sull’eversione. Non è andata così. La stretta dialettica tra i compagni prigionieri e l’Organizzazione all’esterno rendeva possibile dimostrare nella pratica che «la rivoluzione non si processa». Di più, che a essere processato era lo Stato. Quel processo ha visto rimandi successivi a causa della difficoltà di costituzione della giuria popolare, proprio per la politicità che aveva conquistato grazie alla conduzione in aula dei compagni e l’attacco esterno dell’organizzazione.
L’esemplificazione di «chi processa chi» con un iter giudiziario bloccato (fino all’intervento persuasivo extragiudiziale del Pci a sanare la riluttanza dei giurati) e il sequestro di Aldo Moro rendeva palese la forza dell’attacco al cuore dello stato nella disarticolazione degli assetti di potere. Fuor di polemica, non capire e rifiutare questo passaggio non spiega come si potesse sviluppare un processo rivoluzionario endemicizzando lo scontro senza tentare di individuare e anticipare il progetto controrivoluzionario della borghesia. Organizzarsi sul terreno della lotta armata per agire sul piano dei bisogni credo sia una partita persa in partenza.
Il processo di Torino ha contribuito enormemente ad aumentare la visibilità dei prigionieri all’esterno e il loro prestigio nell’Organizzazione, anche per il livello del loro contributo teorico. Col senno di poi si può dire che tutto questo avesse già in nuce l’esito negativo che ha avuto? Certo è che, come sostengono i compagni del testo in esame, l’Organizzazione, sia pur recalcitrante, ha scelto di adottare in toto la produzione programmatica proveniente dal carcere in una vistosa virata economicista del suo progetto. E la contraddittorietà con cui è stata agita non è stata sufficiente a evitare il capovolgimento di un caposaldo dei suoi fondamenti nel tentativo di adattamento della realtà alla teoria. Nonostante il suo avanzare incerto il «dopo Moro» ha significato una stagione di crescita e grande vitalità dell’Organizzazione in un contesto nazionale che ha toccato il massimo dello sviluppo dei gruppi armati. L’interpretazione che i prigionieri hanno dato di questa situazione è stato il precipitare qui e ora della «conquista delle masse sul terreno della lotta armata». I programmi «immediati» dovevano costituirne il viatico, traducendo meccanicamente la capacità di organizzare delle rivolte in carcere con il precipitato in termini di condizioni sociali talmente contrapposte al sistema vigente da poter essere soddisfatte solo armi alla mano a livello di massa. Naturalmente la pratica dell’Organizzazione non poteva essere all’altezza di tale aspettativa e il dissenso è andato crescendo fino a sfociare nella rottura. La spinta decisiva è stata un progetto di evasione dall’Asinara che ovviamente aveva come condizione imprescindibile il supporto dell’Organizzazione. Per noi si trattava di un attacco dal mare con un allestimento logistico del tutto diverso da quello metropolitano a cui eravamo abituati. Le forze impegnate erano notevoli e anche di più le difficoltà di portare a termine l’operazione senza danni. Ma non ci siamo tirati indietro. La preparazione è durata tanto da consumare tutti i mesi estivi. Basti pensare alla difficoltà di una via di fuga fino all’entroterra o alla scarsa propensione del luogo al furto di veicoli tanto che le macchine necessarie le abbiamo dovute portare dal “continente”. Alla fine dell’estate abbiamo dovuto desistere data la rarefazione della popolazione locale con la partenza dei turisti. Per noi si trattava di un rinvio, per i compagni in carcere di un tradimento. Secondo loro non è che non avevamo potuto ma non avevamo voluto. Questa la sostanza della loro accusa. Lo sviluppo dello scontro è andato verso la deriva scissionista dopo la richiesta di dimissioni dell’esecutivo, in seguito reiterata dai separatisti della colonna milanese. Finalmente dall’interno del carcere era stato costruito un gruppo all’esterno che rispondeva pienamente alle aspettative dei teorici della guerra sociale totale. In tutta evidenza, in questo bilancio, le responsabilità personali non sono state secondarie.
Un altro aspetto portato in luce dal documento è questo: benché le Br ponessero sin dal 1975 come obiettivo strategico quello di staccare l’Italia “anello debole della catena imperialista” per una collocazione nell’area dei paesi non allineati, nella visione strategica brigatista, secondo quanto è scritto nel documento, si sottolinea l’assenza di un collegamento della guerriglia all’interno di un fronte antimperialista, in una strategia globale antimperialista, che era al contrario una questione importante e molto presente nel contesto che aveva determinato l’origine stessa della guerriglia. Si tratta di una linea di combattimento che le Br-Pcc tentano di riprendere negli anni ’80 con la costruzione del Fronte combattente antimperialista. Per la prima volta le Br escono dall’ambito nazionale e attaccano direttamente la Nato con l’azione Dozier e in seguito con l’azione che colpisce Leamon Hunt. L’appunto critico che viene mosso, in particolare su Dozier, è che si tratta di un mutamento importante all’interno delle Br che non viene compreso fino in fondo teoricamente, manca di un impianto strategico.
Tutto vero. Nei nostri documenti il riferimento strategico alla questione internazionale è ricorrente, anche perché lo scenario che si era aperto con le rotture rivoluzionarie delle «zone di influenza» dopo la Seconda guerra mondiale sono state uno degli elementi che hanno favorito anche l’insorgenza degli anni ’70. Ma è come se il sottinteso fosse internazionalisti sì ma «ognuno a casa sua». La nostra storia è strettamente legata a quella del soggetto rivoluzionario da cui le Br sono nate, ossia gli operai del polo industriale del nord di cui hanno seguito anche la sorte. Certo «provincialismo» brigatista è andato in parallelo con la particolare forza della guerriglia e del movimento rivoluzionario nel nostro paese che, paradossalmente, non ha facilitato la costruzione di battaglie comuni con altre forze antimperialiste di diversa cultura politica. Al di là di relazioni di scambio e sostegno il capitolo «internazionale» è rimasto vacante nella nostra agenda. Ci sentivamo nello stesso flusso rivoluzionario ma, come anche altre forze combattenti, in un contesto internazionale caratterizzato dalla autodeterminazione delle singole esperienze. La vicinanza con le altre forze guerrigliere in Europa si è limitata alle analogie riscontrabili in alcune battaglie (vedi sequestro di Martin Schleyer), ma gli obiettivi comuni delle organizzazioni combattenti, come la liberazione dei prigionieri, non sono stati sufficienti a colmare le distanze strategiche. A dispetto di quanto andavamo teorizzando circa la necessità di un fronte comune delle forze guerrigliere e con il campo dei paesi non allineati nei fatti ha prevalso la nostra specificità alla «fatica» di individuare e percorrere i terreni propri di un fronte antimperialista. Alla fine degli anni ’70 e anche in coincidenza con la sconfitta del soggetto politico che avevamo messo al centro del nostro progetto, diventava non più rinviabile colmare il vistoso vuoto di progetto, anche in presenza della ripresa di movimenti contro le basi Nato e contro la guerra. In extremis abbiamo cercato di recuperare il terreno perduto su un programma di «guerra alla guerra» che andasse a rafforzare l’attacco alla tecnocrazia neoliberista. Veramente troppo tardi per elaborare una strategia all’altezza del compito anche alla luce della crisi di credibilità che aveva scavato a fondo al nostro interno e non solo.
La ritirata strategica: riprendendo quanto dicevo sopra, anche in questo caso il dato sperimentale mi sembra quello più evidente, con un concetto tra l’altro estraneo alla tradizione Br.
Beh, fare come se nulla fosse stato dopo il fallimento dell’operazione Dozier e la costatazione di quanto fosse profonda la crisi interna non espressa prima, sarebbe stato il massimo. Certo è che abbiamo dovuto cercare una via d’uscita sotto i colpi del contrattacco nemico e quella di ricorrere a ripieghi buoni solo in termini ideali (ritirarsi nelle masse) e per altri lidi e condizioni ha prevalso. Abbiamo cercato di capire come organizzare la resistenza per contenere le perdite, analizzare le cause del tracollo e verificare la possibilità di riprendere a combattere. Non ultima la verifica dello stato di salute della nostra credibilità e della rete di sostegno.
A differenza delle altre «ritirate» compiute dall’Organizzazione l’ultima avveniva alla fine della lunga stagione di offensiva dei movimenti e nel pieno delle nostre lacerazioni. Occorreva perciò addestrarsi per capire quale fosse un difficile «che fare» non escludendo la verifica che ce ne fosse ancora uno praticabile. Nella consapevolezza che una guerriglia urbana non può ritirarsi per un tempo indefinito senza perdere fisionomia, riferimenti di classe e affidabilità. In quella situazione il dato sperimentale è stato fortemente condizionato dal contrastare un nemico che, grazie alle informazioni dei «pentiti», aveva deciso in tutta evidenza di sferrare il suo attacco finale. Mentre i nostri compagni continuavano a cadere, mentre i conflitti a fuoco per strada si moltiplicavano, i buontemponi della «rivoluzione alle porte» completavano la loro operazione denigratoria alimentando il coretto che ci voleva arresi a un passo dalla rivoluzione e trascinandoci in uno scontro frontale contro la follia della loro guerra ai compagni che avevano dato informazioni sotto tortura. Solo dopo l’esaurirsi dell’effetto e della disponibilità alla collaborazione di quanti si andavano «pentendo» abbiamo potuto riprendere l’attività, a fiato corto per risorse e lucidità. C’erano ancora compagni che si univano a noi per percorrere una strada mai tanto incerta. Nella scomparsa di tutte le altre ipotesi di lotta armata praticate.
Negli ultimi tempi ha preso forma un corpus storiografico, prodotto soprattutto da chi non ha avuto esperienza diretta degli anni ’70, che riporta alla luce produzione teorica ed esperienze pratiche di quegli anni e che ragiona, questa dovrebbe essere la regola ma sappiamo che così non è, sulle fonti nel loro contesto. Per quanto riguarda le Br, il dato che emerge è che, diversamente da ciò che per decenni si è affermato, la produzione teorica delle Br esisteva, e che rispetto ai temi in discussione a livello internazionale non era affatto marginale (il concetto di globalizzazione nel 1970, lo stato imperialista delle multinazionali). Questa produzione teorica ha una caratteristica fondamentale: nasce nella fabbrica, è tutta interna alla dinamica di classe e capisce perfettamente, proprio perché lo vive nella praxis della fabbrica, come si muove il capitale. Comparandola con quel che viene prodotto negli stessi anni dai centri di studio dei partiti della sinistra o anche in ambito accademico, che avevano ben più potenti mezzi a disposizione, il dato è di grande interesse. E apre a una riflessione sul fatto che l’esistenza di un «sapere di classe» è sistematicamente rimosso – e qui non parlo esclusivamente di Br ovviamente.
Ormai questo dovrebbe essere acclarato. E non tanto per spirito autocelebrativo ma perché il «sapere di classe», contrapposto alla presunta neutralità della tecnica produttivistica, costituisce l’impalcatura che ha sostenuto e continua a sostenere la possibilità di liberazione dal capitalismo. E questo è un dato che non è cambiato per quanti tentativi di sua applicazione possano essere stati fallimentari anche perché il conflitto di classe non si è certo esaurito nel ‘900.
Chi leggerà non avendo familiarità con il linguaggio brigatista noterà che ci si riferisce alle Br come «Organizzazione», un concetto e un principio che mi pare colgano essenza e sostanza di ciò che sono state le Br.
Si, non ci siamo mai sentiti né definiti «partito». Abbiamo sempre pensato di essere un’avanguardia in stretta dialettica con altre avanguardie armate e non. Non eravamo la guida di grandi masse all’assalto di un palazzo, ma una forza politico/militare che sul lungo periodo sperimentava la capacità di disarticolazione dei progetti nemici con l’obiettivo di impedirne la realizzazione e favorire e riempire di prospettiva rivoluzionaria l’opposizione di classe. L’unità del politico/militare si rifletteva nel singolo militante che incarnava un principio fondante dell’Organizzazione, la caratteristica della sua formazione politica e la ricomposizione tra lavoro manuale e intellettuale. Non è un caso che le biografie dei militanti fossero tanto simili per estrazione sociale e cattivi maestri di se stessi.
Un tuo compagno ha detto che avete fatto una straordinaria apologia del potere, cioè gli avete attribuito una «lucidità strategica» che non aveva. In Compagna Luna e Perché io perché non tu mi sembra che anche tu faccia, con un linguaggio diverso, la stessa considerazione.
Alla luce dei fatti è così. Nello sforzo di comprenderne la natura abbiamo confuso le linee di elaborazione strategica del potere, per esempio le direttive della scuola di Chicago, con la capacità politica di traduzione da parte dei soggetti preposti. (Ma ex post a capire sono buoni tutti!). Se si pensa al tempo che si è reso necessario perché la gestione tecnocratica in campo economico prevalesse e trasformasse la stessa natura della politica istituzionale; se si pensa a quanto sia comunque contraddittoria questa realtà, si può capire quanto poca cosa fosse quella «lucidità». Le mie considerazioni a cui fai riferimento sono state in relazione a come sono andate le cose soprattutto durante il sequestro Moro. L’insensatezza della «fermezza» mentre la casa bruciava, la svalutazione dell’ostaggio («non è lui»!), l’immobilismo dei veti incrociati tra Dc e Pci, i controlli di polizia in sostituzione di qualsiasi iniziativa del governo, non erano una risposta ma la fotografia di una classe dirigente alla «Todo modo». Quelle mie riflessioni hanno trovato in seguito qualche oggettiva conferma. Infatti di recente sono stati resi noti i verbali delle riunioni dei democristiani e dei comunisti durante i 55 giorni del sequestro. Altro che statisti. Da una parte una congerie di gruppi di potere e feudi elettorali ognuno per sé e dall’altra un grande partito operaio ridotto a garante dello status quo del potere altrui. Nero su bianco si possono trovare nel volume Brigate Rosse. Dalle fabbriche alla campagna di primavera. Una lettura veramente molto istruttiva.