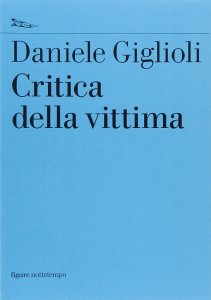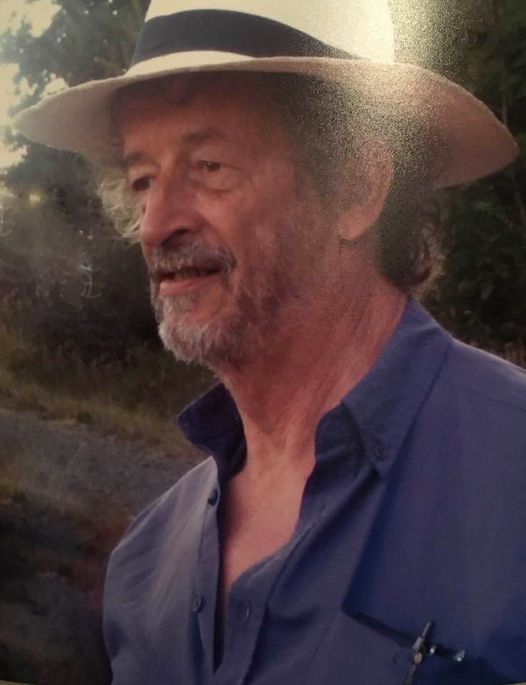Il primo aprile 2020 è scomparso Luigi Novelli, «fabbro e comunista di Villa Gordiani, brigatista e dotato di ironia sottile, protagonista di poche parole nella Roma della Rivoluzione che non c’è stata». Nato il 12 febbraio 1953, proveniente dal “Viva il comunismo” insieme ad altri militanti di quel gruppo nel 1976 entrò a far parte della nascente colonna romana col nome di battaglia «Romolo». Approdo raggiunto dopo un periodo di incubazione aviato tra il 1974-75. Figura importante della struttura logistica della colonna, nella sua officina in via dei Pini passavano le armi da riparare o modificare, venivano preparate targhe false, si predisponevano altoparlanti e altro materiale per le azioni di propaganda, si falsificavano documenti. Arrestato una prima volta il 4 gennaio 1979 insieme Marina Petrella, poi sposata in carcere dove vide luce anche la loro bambina concepita poco prima dell’arresto, venne rimesso in libertà per decorrenza dei termini cautelari l’8 maggio del 1980, nello stesso periodo in cui una importante operazione dei carabinieri smantellava la quasi totalità della direzione romana delle Brigate rosse. Sottoposto con Marina e Stefano Petrella all’obbligo di residenza nel comune di Montereale (L’Aquila), il 12 agosto successivo fuggì con gli altri due per rientrare nei ranghi delle Br. Dopo una profonda riorganizzazione della colonna che ne rilanciò l’azione nella Capitale, entrò nel settembre 1980 in Direzione di colonna e successivamente, nell’aprile 1981, quando era già avviato il processo scissionistico che portò al frazionamento delle Brigate rosse in tre tronconi, venne chiamato nell’Esecutivo nazionale. Preso atto del distacco delle altre fazioni brigatiste (colonna milanese Walter Alasia e Partito guerriglia), partecipo’ alla nascita delle Brigate rosse Partito comunista combattente. A seguito dell’attività investigativa svolta con l’ausilio dei “pentiti”, impiegati direttamente sul territorio, fu arrestato con la compagna Marina Petrella il 7 dicembre del 1982, mentre insieme scendevano da un’autobus nel quartiere romano di Monteverde. Condannato all’ergastolo nel processo Moro ter, uscì in liberazione condizionale nel 2005 per terminare la pena nel 2009.
Di seguito pubblichiamo un ricordo scritto da Francesco Piccioni, suo compagno di militanza in “Viva il comunismo” e poi nelle Brigate rosse
di “Rocco” (Francesco Piccioni) Contropiano
 Non ricordo il giorno esatto in cui ho conosciuto Gigi. Erano gli anni che ci si incontrava a centinaia, per qualsiasi motivo. Assemblee di ogni ordine e grado: cittadine, nazionali, di quartiere, di più quartieri, di scuola o gruppi di scuole, occupanti di case e disoccupati organizzati.
Ricordo invece quando abbiamo iniziato a riunirci, in uno scantinato di via dei Marrucini, a San Lorenzo. Eravamo uno strano miscuglio di studenti rivoluzionari e operai, con i primi ferrati nelle parole e i secondi nel capire chi faceva chiacchiere e chi no. Ma stavamo crescendo, di numero e di organizzazioni, dopo il ‘68. E quindi c’era spazio e modo per sperimentare, provare, eventualmente fallire e riprovarci cento volte.
Decidemmo quindi insieme a tanti altri di programmare un intervento a Villa Gordiani, “quartiere proletario”, allora, con ancora i testimoni viventi di quando il fascismo aveva deportato laggiù (come al Quarticciolo, Villagio Breda, Tufello, ecc) centinaia di famiglie operaie, sgombrando il centro di Roma da “personaggi pericolosi”.
Non ricordo il giorno esatto in cui ho conosciuto Gigi. Erano gli anni che ci si incontrava a centinaia, per qualsiasi motivo. Assemblee di ogni ordine e grado: cittadine, nazionali, di quartiere, di più quartieri, di scuola o gruppi di scuole, occupanti di case e disoccupati organizzati.
Ricordo invece quando abbiamo iniziato a riunirci, in uno scantinato di via dei Marrucini, a San Lorenzo. Eravamo uno strano miscuglio di studenti rivoluzionari e operai, con i primi ferrati nelle parole e i secondi nel capire chi faceva chiacchiere e chi no. Ma stavamo crescendo, di numero e di organizzazioni, dopo il ‘68. E quindi c’era spazio e modo per sperimentare, provare, eventualmente fallire e riprovarci cento volte.
Decidemmo quindi insieme a tanti altri di programmare un intervento a Villa Gordiani, “quartiere proletario”, allora, con ancora i testimoni viventi di quando il fascismo aveva deportato laggiù (come al Quarticciolo, Villagio Breda, Tufello, ecc) centinaia di famiglie operaie, sgombrando il centro di Roma da “personaggi pericolosi”.
Gigi aveva dato vita a un collettivo davvero insolito, anche per quei tempi. Tutti operai, di quelli che popolavano le piccole officine di Roma Sud, tra il Pigneto, Tor Pignattara, Centocelle, e poi via verso la Tiburtina da un lato, Quadraro e Tuscolana dall’altro, fin sotto i Castelli, oltre il Raccordo, senza soluzione di continuità.
Niente a che vedere con le grandi fabbriche del Nord, dove si concentravano decine di migliaia di operai in tuta blu, quasi anonimi per il padrone, conosciuti al massimo dai capi officina. Solo la stessa testa, il modo di intendere la vita e la lotta per la vita.
Qui a Roma erano al massimo cinque, dieci per stabilimento, con macchine e materiali distribuiti un po’ così, dove ti prendevano, sperimentavano, spesso mandavano via se non eri capace di “fare”. Era “apprendistato” sul serio, non per finta, e magari scoprivi che non era quello il tuo mestiere…
Gigi era fabbro, come Er Peone – uno dei fratelli -, Il Capitano (ogni quartiere ne aveva uno…), Er Bove, Er Killer (uno dei soprannomi per contrasto, come si fa a Roma: non sapeva far male a una mosca), altri di cui gli anni e l’hard disk limitato mi hanno tolto il nome dalla testa. Un fabbro di quelli che saldano, con una schermatura in una mano e il cannello nell’altra. Tra schizzi di metallo che gli arrivavano sulle mani, sulla tuta, sui piedi, qualche volta in faccia.
Ma sapeva anche andare col tornio, e questo lo rese una star segreta, negli anni successivi. Quando si era passati a cose più serie, e la professionalità dell’artigiano “metallaro” si poteva applicare a fare piccole opere d’ingegno militare: filettature e silenziatori, per dirne una. O più grossolani chiodi a quattro punte, che possono sempre tornare utili…
All’inizio, però, “il fabbro” faceva da perno di quell’intervento abborracciato, perché era del quartiere, uno della case di via Pisino; lo conoscevano tutti per serietà, determinazione, disinteresse personale. E quindi pure qualche studente che si portava dietro acquistava man mano affidabilità, se sapeva stare al suo passo e al suo fianco.
Lavorava di giorno, volantinava e discuteva nel tardo pomeriggio, leggeva – anzi: studiava – di notte. Sempre con la sigaretta in mano. Sempre col sorriso ironico di chi sa da sempre che sotto le parole spesso non c’è qualcosa di altrettanto gonfio e tronfio.
Eravamo tutti così, chi più chi meno. Come nelle cucciolate di cani, con quello/a più deciso, quello più timido/a, senza invidia se uno era più bravo in qualche cosa, tutti insieme verso la Rivoluzione.
Ma sul serio.
Gli “studenti dei quartieri alti” si selezionavano abbastanza presto, in quegli anni. Nel giro largo ce n’erano molti, venivano dai licei classici del centro (Mamiani, Virgilio, Tasso, ecc), si conoscevano tra loro per motivi di classe. Nel doppio senso: stavano nella stessa aula di scuola alla mattina, e per le loro famiglie “locupletate”.
Molti di quelli, crescendo, hanno fatto le carriere dei padri, o anche migliori. Qualcuno ha fatto la stessa vita di Gigi, ma non tanti. Eravamo seduti in riunione, in stanze puzzolenti di fumo appestante, col ciclostile che andava, dietro la schiena, con a fianco futuri notai, avvocati, presidenti di questo e di quello, sottosegretari e ministri. E molti più ragazzi “normali”.
Fianco a fianco con noi che saremmo poi stati ergastolani o morti ammazzati per strada, e tanti che non avrebbero retto consegnandosi all’eroina. Un orgoglio vero: non ci sono stati “pentiti” né “dissociati”, tra noi… Nix infami.
Ma in quei primi anni, con Gigi e tutti gli altri si “lottava così come si gioca”, con la serietà e la gioia, la leggerezza di chi si sente immortale e vive come se lo fosse. Sapendo di non esserlo…
Riunioni assurde e discussioni infinite, citazioni sconosciute e spesso storpiate, oppure lette come salmi di chiesa fino a che non significavano un cazzo come quelli di chiesa. E in mezzo le pizze e le bicchierate “da Barba”, in via Lussimpiccolo, rifugio di qualche sera passata a discutere se i Cream fossero all’altezza di Hendrix, se considerare o no “rock” Procol Harum e Emerson, Lake & Palmer, a storcere il naso su Bowie e benedire Frank Zappa.
L’antifascismo era una roba seria, non una frase da buttare in mezzo a un discorso ufficiale. Tra di noi c’era chi si districava per le vie tra le sezioni di via Noto, piazza Tuscolo e Acca Larenzia, il “triangolo nero” dove sguazzavano i Delle Chiaie, i fratelli Di Luia, ideologi e picchiatori di Avanguardia Nazionale. Non sempre finiva solo a sprangate e bisognava farsi rispettare.
Idem per quelli del Prenestino, meno di due chilometri da Villa Gordiani, verso il centro. Fascisti cattivi, ma non brillanti per ingegno. Il 25 aprile del ‘74, per esempio, accolsero la nostra manifestazione antifascista scambiandoci per il Pci, la cui sezione avevano attaccato due giorni prima. Gigi, come tutti, portava il passamontagna; non per posa, non per “sentire il calore della comunità operaia”, ma perché lavorava a trenta metri da lì e ci passava ogni volta che entrava e usciva dall’officina. E ci sarebbe ripassato il giorno dopo, sogghignando tra sé…
Ci attaccarono lungo via Roberto Malatesta, verso il Pigneto. Eravamo appena 300, ma “solo servizio d’ordine”, come si diceva allora. Gente sveglia di Villa Gordiani, Centocelle, Torre Spaccata.
Finirono inseguiti fin per le scale di casa loro, mentre gridavano “mamma! mamma apri, presto!”.
Con Gigi e tutti gli altri, eravamo quelli lì, molti di noi finirono in carcere o c’erano già passati; certo solo per qualche giorno fin lì…
Ma quelle erano occasioni particolari, serie ma in fondo rare. In genere giravamo per le strade del quartiere, bussando alle porte delle case popolari, per organizzare l’autoriduzione delle bollette (durò qualche anno), per vedere quali erano “i bisogni” che attendevano risposta. Rispetto a oggi, devo dire, “i proletari” stavano meglio. Un operaio poteva mantenere la famiglia anche con un solo stipendio, stando ben attento. Oggi non ne bastano due…
Giravamo e incontravamo chiunque, parlavamo con chiunque. Poteva capitare di trovarsi sul campo di calcio del “Grancio”, che faceva da custode (e ci abitava), la sera tardi, a incrociare i dribbling con Pasolini e Ninetto Davoli. E non sembrava strano, né si chiedeva un selfie o un autografo. Tra persone.
Quei ragazzi di Roma, del resto, spesso si aiutavano con qualche giornata da comparsa “al cinema”, quando ancora i film italiani parlavano della e alla società reale. E quindi c’erano “scene di massa”, con decine o centinaia di comparse, oltre ad attori di prima e seconda fascia. Non solo “scene di un interno”, per pochi intimi…
E si poteva parlare con Comencini o Magni, nelle pause. Mentre magari Gassman tuonava a qualche metro…
Gigi “il fabbro” era di poche parole, ma ben selezionate. Le sue mani animate. con dita fratturate e riaggiustate alla bell’e meglio, accompagnavano quell’ombra di sorriso che gli faceva quasi chiudere gli occhi. E per un attimo eri indeciso tra se fosse serio e “ma che me stai a coglionà?”.
Gli riuscivano bene entrambe lo cose. La seconda quando ti voleva far capire che ti stavi arrampicando su uno specchio di parole, mentre la realtà era più semplice. E tosta. Ed era meglio guardarla in faccia.
Finimmo a fare sul serio la lotta armata – ci avevamo provato per qualche tempo da soli, senza “grandi imprese” – quando gran parte del “movimento” entrava nell’eroina e nel riflusso. E spesso erano fasci gli spacciatori più organizzati (se qualcuno vuol rivedersi “l’operazione Blue Moon”).
Entrammo nelle Br uno alla volta, com’era giusto. Perché tra comunisti che devono far sul serio non avevano, non hanno, non avranno mai senso le “correnti organizzate”. Magari su base amicale, com’era in fondo il nostro gruppo.
Si era nel frattempo sposato con Marina, in una felice combinazione “operai-studenti”, e lavorammo duro per anni. Molti pensano che la guerriglia sia sparare agli angoli delle strade. Il grosso è tutt’altro, e non vale neanche la pena di scriverlo. Fanno ridere i romantici, fanno incazzare i “dietrologi”… tutta gente che neanche immagina quanta intelligenza, costanza, fantasia, dedizione ci vuole.
Molti di quelli che sono finiti in galera in pratica non avevano mai esploso un colpo.
Capitò anche a loro due, arrestati una notte in casa. “Uscirono presto”, come dicevamo quando qualcuno si faceva “solo” diciotto mesi di carcerazione preventiva…
Fuggirono dal confino e ripresero a lavorare. Poi l’arresto “definitivo”, con Marina che scopre solo qualche giorno dopo, in carcere, di attendere una figlia. E tutti a festeggiarli nell’aula bunker del primo “processo Moro”, all’ex sala scherma del Foro Italico.
Ci presero per matti. Mai stati più sani…
Nel corso degli anni, poi, ci siamo persi. Carceri diversi, altre riflessioni sul com’era andata e perché. Ma non contava poi molto, anche se avevamo vissuto per quello. Non poteva esserci la necessaria distanza.
Ci siamo incontrati l’ultima volta pochissimi anni fa, nel sacrario della merce che tutti dobbiamo attraversare più volte alla settimana. Al supermercato, per caso, come tanti altri che non vedi da anni.
Mi chiede “ti posso salutare?”. Con la solita aria a metà strada tra il dico sul serio e “te sto a coglionà”. Eravamo gente tosta, che aveva fatto ogni passo con convinzione. Entrambi “irriducibili”, con una differenza che in un certo momento era apparsa importante e qualche anno dopo non lo era più tanto.
Ci siamo seduti a parlare, come due vecchi compagni di lotta e amici (non tutti sono stati la seconda cosa, ed è normale). Ma questo rimarrà tra noi.
Ciao, Gigi.

 «Dinanzi all’omicidio del vicedirettore de “La Stampa” Carlo Casalegno nel novembre 1977 e, soprattutto, al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse pochi mesi dopo, le reazioni fra i lavoratori Fiat apparvero deboli sino a sconfinare nell’indifferenza. A qualche delegato dell’ala dura del movimento sembrarono sprecate quelle ore di sciopero contro il terrorismo che il sindacato si era affrettato a dichiarare. Lamentava per esempio un delegato che partecipava a un gruppo di discussione guidato da Giulio Girardi, teologo e sociologo dedito a un lavoro che a quel tempo si diceva di “autoricerca” militante: “[…] mi fanno perdere decine di ore contro il terrorismo. Quale terrorismo? Guardiamo dov’è il terrorismo: è solo quello delle Brigate Rosse? Si devono condannare le Br perché hanno rapito Moro e hanno fatto fuori quegli altri? Va bene: stanno facendo il processo alle BR. Però a quelli che stanno al governo chi è che gli fa il processo? Nessuno! Chi è che fa il processo ai padroni che ci fanno diventare, noi operai, brigatisti…». Era questa la situazione descritta da Giuseppe Berta nel saggio, Mobilitazione operaia e politiche manageriali alla Fiat, 1969-1979(
«Dinanzi all’omicidio del vicedirettore de “La Stampa” Carlo Casalegno nel novembre 1977 e, soprattutto, al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate rosse pochi mesi dopo, le reazioni fra i lavoratori Fiat apparvero deboli sino a sconfinare nell’indifferenza. A qualche delegato dell’ala dura del movimento sembrarono sprecate quelle ore di sciopero contro il terrorismo che il sindacato si era affrettato a dichiarare. Lamentava per esempio un delegato che partecipava a un gruppo di discussione guidato da Giulio Girardi, teologo e sociologo dedito a un lavoro che a quel tempo si diceva di “autoricerca” militante: “[…] mi fanno perdere decine di ore contro il terrorismo. Quale terrorismo? Guardiamo dov’è il terrorismo: è solo quello delle Brigate Rosse? Si devono condannare le Br perché hanno rapito Moro e hanno fatto fuori quegli altri? Va bene: stanno facendo il processo alle BR. Però a quelli che stanno al governo chi è che gli fa il processo? Nessuno! Chi è che fa il processo ai padroni che ci fanno diventare, noi operai, brigatisti…». Era questa la situazione descritta da Giuseppe Berta nel saggio, Mobilitazione operaia e politiche manageriali alla Fiat, 1969-1979(
 Gli operai mostrano molta diffidenza davanti al microfono, se stanno discutendo animatamente all’improvviso fanno silenzio, cercano di sviare le domande, rinviano ai delegati, dichiarano di non occuparsi di politica, altri più sibillini affermano: «Io non penso! A me non mi è dato di pensare. Mi è dato solo di produrre e basta. Se scoprono che penso, mi fanno fuori!», oppure «Spegni quell’affare! Se vuoi che ti risponda spegni quell’affare! (Lo spegniamo. Ci chiede per chi facciamo l’intervista. Rispondiamo per una rivista. Fa un sorrisetto e se ne va)», atteggiamento che spinge gli autori ad domandarsi se quel giovane operaio che si era avvicinato «a testa bassa» fosse addirittura un «Fiancheggiatore?» (16). Le tante reticenze e silenzi nelle risposte raccolte spingono gli autori a segnalare una mutazione della composizione del ceto operaio che – ai loro occhi – sembra aver smarrito i propri codici linguistici, i propri riferimenti culturali e politici, evidenziando lo sfarinamento di quella che un tempo era stata la centralità operaia. Analisi – va detto – che per un verso sottovaluta troppo frettolosamente «l’opacità operaia», quello schermo di riservatezza dietro al quale gli operai tutelavano la loro libertà di giudizio per non incorrere nei rigori del regime disciplinare della fabbrica, della legge e nel caso di specie del sindacato e del Pci, per l’altro sembra addossare agli operai gli effetti di quella «solitudine» che le scelte politiche sindacali e i processi di ristrutturazione del ciclo produttivo avevano avviato da tempo. Nonostante l’atteggiamento prudente gli operai intervistati fanno fatica a celare la loro indifferenza verso la sorte di Moro, mentre parole di empatia vengono spesso dedicate agli uomini della scorta caduti nell’agguato: «Penso che quando perde la vita altra gente nessuno fa niente. E’ capitato uno che è un pezzo grosso e si fanno tutte queste cose. Per me tutto questo proprio non bisognava farlo. Si doveva continuare normalmente», ed ancora, «Quello che io penso è tutta un’altra cosa, è una cosa mia che può anche non andare d’accordo con quello che decidono loro»(
Gli operai mostrano molta diffidenza davanti al microfono, se stanno discutendo animatamente all’improvviso fanno silenzio, cercano di sviare le domande, rinviano ai delegati, dichiarano di non occuparsi di politica, altri più sibillini affermano: «Io non penso! A me non mi è dato di pensare. Mi è dato solo di produrre e basta. Se scoprono che penso, mi fanno fuori!», oppure «Spegni quell’affare! Se vuoi che ti risponda spegni quell’affare! (Lo spegniamo. Ci chiede per chi facciamo l’intervista. Rispondiamo per una rivista. Fa un sorrisetto e se ne va)», atteggiamento che spinge gli autori ad domandarsi se quel giovane operaio che si era avvicinato «a testa bassa» fosse addirittura un «Fiancheggiatore?» (16). Le tante reticenze e silenzi nelle risposte raccolte spingono gli autori a segnalare una mutazione della composizione del ceto operaio che – ai loro occhi – sembra aver smarrito i propri codici linguistici, i propri riferimenti culturali e politici, evidenziando lo sfarinamento di quella che un tempo era stata la centralità operaia. Analisi – va detto – che per un verso sottovaluta troppo frettolosamente «l’opacità operaia», quello schermo di riservatezza dietro al quale gli operai tutelavano la loro libertà di giudizio per non incorrere nei rigori del regime disciplinare della fabbrica, della legge e nel caso di specie del sindacato e del Pci, per l’altro sembra addossare agli operai gli effetti di quella «solitudine» che le scelte politiche sindacali e i processi di ristrutturazione del ciclo produttivo avevano avviato da tempo. Nonostante l’atteggiamento prudente gli operai intervistati fanno fatica a celare la loro indifferenza verso la sorte di Moro, mentre parole di empatia vengono spesso dedicate agli uomini della scorta caduti nell’agguato: «Penso che quando perde la vita altra gente nessuno fa niente. E’ capitato uno che è un pezzo grosso e si fanno tutte queste cose. Per me tutto questo proprio non bisognava farlo. Si doveva continuare normalmente», ed ancora, «Quello che io penso è tutta un’altra cosa, è una cosa mia che può anche non andare d’accordo con quello che decidono loro»(
 Per capire il comportamento politico tenuto dalle maggiori forze politiche nei giorni del sequestro Moro bisogna osservare con attenzione quel che avvenne la settimana precedente, quando la lunga trattativa condotta da Moro per il varo dell’ennesimo governo Andreotti giunse a termine. Con una maestria incredibile, dopo aver estenuato gli emissari del Pci, Moro con colpo di mano finale cambiò la carte in tavola a tempo ormai scaduto cancellando dalla lista dei nuovi membri del governo i tre ministri indipendenti di sinistra che il segretario della Dc Zaccagnini e il primo ministro incaricato Andreotti avevano negoziato con il Pci. Tempo prima, all’ambasciatore americano Richard Gardner, il leader Dc aveva spiegato di ritenere «necessario guadagnare altro tempo. Ci sarebbe voluto almeno un anno per creare un clima elettorale in cui il Pci avrebbe subito una pesante sconfitta e la Dc una netta vittoria. Il trucco stava nel trovare un modo per tenere il Pci in una maggioranza parlamentare senza farlo entrare nel Consiglio dei ministri». Nei tre precedenti incontri che si erano tenuti lungo tutto il 1977, Moro aveva spiegato al diplomatico Usa che da parte democristiana non c’era mai sta la volontà di condividere il potere con i comunisti, ma che la situazione economico-sociale e la forza elettorale che avevano raggiunto imponevano delle concessioni. Non potendo andare ad elezioni anticipate, che avrebbero rischiato di rafforzare ulteriormente il Pci, bisognava mantenere le redini del governo, aprendo ai comunisti l’ingresso nella maggioranza e coinvolgendoli nella elaborazione di un programma di governo senza concedere loro alcun ministero. Una strategia rivolta ad impegnare il Pci nella difesa dello Stato avvalendosi della sua capacità di fare argine contro la protesta sociale
Per capire il comportamento politico tenuto dalle maggiori forze politiche nei giorni del sequestro Moro bisogna osservare con attenzione quel che avvenne la settimana precedente, quando la lunga trattativa condotta da Moro per il varo dell’ennesimo governo Andreotti giunse a termine. Con una maestria incredibile, dopo aver estenuato gli emissari del Pci, Moro con colpo di mano finale cambiò la carte in tavola a tempo ormai scaduto cancellando dalla lista dei nuovi membri del governo i tre ministri indipendenti di sinistra che il segretario della Dc Zaccagnini e il primo ministro incaricato Andreotti avevano negoziato con il Pci. Tempo prima, all’ambasciatore americano Richard Gardner, il leader Dc aveva spiegato di ritenere «necessario guadagnare altro tempo. Ci sarebbe voluto almeno un anno per creare un clima elettorale in cui il Pci avrebbe subito una pesante sconfitta e la Dc una netta vittoria. Il trucco stava nel trovare un modo per tenere il Pci in una maggioranza parlamentare senza farlo entrare nel Consiglio dei ministri». Nei tre precedenti incontri che si erano tenuti lungo tutto il 1977, Moro aveva spiegato al diplomatico Usa che da parte democristiana non c’era mai sta la volontà di condividere il potere con i comunisti, ma che la situazione economico-sociale e la forza elettorale che avevano raggiunto imponevano delle concessioni. Non potendo andare ad elezioni anticipate, che avrebbero rischiato di rafforzare ulteriormente il Pci, bisognava mantenere le redini del governo, aprendo ai comunisti l’ingresso nella maggioranza e coinvolgendoli nella elaborazione di un programma di governo senza concedere loro alcun ministero. Una strategia rivolta ad impegnare il Pci nella difesa dello Stato avvalendosi della sua capacità di fare argine contro la protesta sociale «Quel mercoledì ero stato quasi tutta la serata col presidente. I comunisti contestavano che il governo era stato fatto col bilancino, assecondando le pretese di tutte le correnti Dc. Moro era convinto che non si potesse fare altrimenti, che solo a quelle condizioni la Dc poteva accettare che i comunisti entrassero nella maggioranza. A un certo punto mi disse: “Il Pci deve sapere che può essere solo così”». Tullio Ancora, consigliere di Aldo Moro, incaricato di tenere i rapporti con Botteghe oscure
«Quel mercoledì ero stato quasi tutta la serata col presidente. I comunisti contestavano che il governo era stato fatto col bilancino, assecondando le pretese di tutte le correnti Dc. Moro era convinto che non si potesse fare altrimenti, che solo a quelle condizioni la Dc poteva accettare che i comunisti entrassero nella maggioranza. A un certo punto mi disse: “Il Pci deve sapere che può essere solo così”». Tullio Ancora, consigliere di Aldo Moro, incaricato di tenere i rapporti con Botteghe oscure Via Angelo Brunetti – Nella notte tra il 15 e il 16 marzo due brigatisti bucano le gomme del furgone da lavoro di Antonio Spiriticchio, che tutte le mattine vende fiori all’angolo tra via Stresa e via Mario Fani e che rischierebbe così di trovarsi sulla linea di tiro e di intralciare l’azione
Via Angelo Brunetti – Nella notte tra il 15 e il 16 marzo due brigatisti bucano le gomme del furgone da lavoro di Antonio Spiriticchio, che tutte le mattine vende fiori all’angolo tra via Stresa e via Mario Fani e che rischierebbe così di trovarsi sulla linea di tiro e di intralciare l’azione






























 «Ricordo bene quella mattina. Vivevo a Roma, a Villa Bonelli, e non lontano da me abitava mio padre che, in quel momento, rivestiva la carica di presidente della commissione Finanze della Camera dei Deputati. All’inizio della legislatura, infatti, i comunisti assunsero alcuni importanti ruoli istituzionali, in quanto erano diventati una forza nell’ambito della maggioranza, sia pure nella forma dell’astensione. La sede della Fgci era in via della Vite, a due passi dal Parlamento, e tutte le mattine mio padre ed io andavamo a lavorare insieme, con una sola automobile. Uscivo presto, mi incamminavo verso la casa dei miei genitori e con mio padre ci vedevamo all’angolo di via Camillo Montalcini. E’ un fatto che mi è rimasto in mente tutta la vita: ogni mattina ci incontravamo davanti al garage dove poi Moro sarebbe stato tenuto prigioniero dalle Brigate Rosse. E quel giorno, mentre ci stavamo recando a lavoro, arrivò la notizia del suo rapimento e del massacro della scorta».
«Ricordo bene quella mattina. Vivevo a Roma, a Villa Bonelli, e non lontano da me abitava mio padre che, in quel momento, rivestiva la carica di presidente della commissione Finanze della Camera dei Deputati. All’inizio della legislatura, infatti, i comunisti assunsero alcuni importanti ruoli istituzionali, in quanto erano diventati una forza nell’ambito della maggioranza, sia pure nella forma dell’astensione. La sede della Fgci era in via della Vite, a due passi dal Parlamento, e tutte le mattine mio padre ed io andavamo a lavorare insieme, con una sola automobile. Uscivo presto, mi incamminavo verso la casa dei miei genitori e con mio padre ci vedevamo all’angolo di via Camillo Montalcini. E’ un fatto che mi è rimasto in mente tutta la vita: ogni mattina ci incontravamo davanti al garage dove poi Moro sarebbe stato tenuto prigioniero dalle Brigate Rosse. E quel giorno, mentre ci stavamo recando a lavoro, arrivò la notizia del suo rapimento e del massacro della scorta».