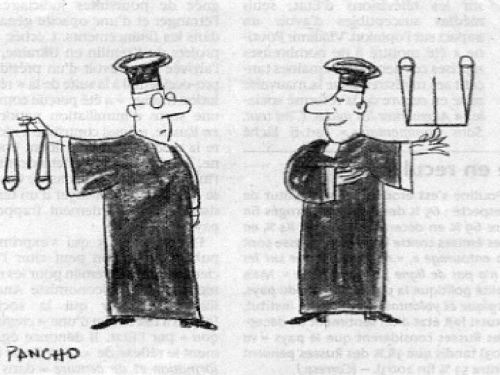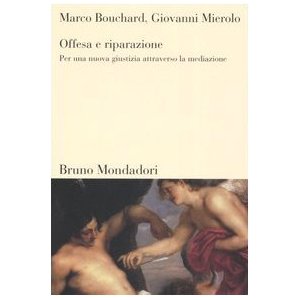Escogitata dal democratico Trasibulo nel lontano 403 avanti cristo, a conclusione della guerra civile vinta contro gli oligarchi, l’amnistia per Luciano Violante è – al contrario – un istituto giuridico tipico dei regimi autoritari, come quello fascista, o ancora non pienamente democratici, come l’Italia post-unitaria.
Tesi che non trova fondamento storico: dopo i massacri e la repressione seguita ai moti del 1848 in Europa, ed ancora di più sulle ceneri della Comune parigina, radicali, socialisti e blanquisti, cioè l’ala più progressista della borghesia e le prime organizzazioni politiche del movimento operaio, si riorganizzarono attorno alla parola d’ordine dell’amnistia, sulla quale fondarono o rifondarono la propria esistenza fino a farne una leva di liberazione più generale negli anni della Terza Repubblica francese. La sinistra politica e sociale ricostruì la propria legittimità grazie alla battaglia per l’amnistia che diverrà per buona parte del Novecento uno dei repertori più utilizzati, un vero e proprio segno identitario anteposto alle politiche repressive dello Stato, all’azione dei suoi bracci secolari: magistratura e forze di polizia. Gli Stati uniti d’America, fedeli allo loro costituzione, misero fine alla guerra civile tra unionisti del Nord e confederali del Sud con un’amnistia. Più recentemente, in Gran Bretagna, il moderatissimo Tony Blair nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati
di Paolo Persichetti
«Come molte categorie e istituzioni delle democrazie moderne, anche l’amnistia risale alla democrazia ateniese. Nel 403 avanti Cristo, dopo aver abbattuto la sanguinosa oligarchia dei Trenta, il partito democratico vincitore prestò un giuramento in cui si impegnava a «deporre il risentimento» (me mnesikakein, letteralmente «non ricordare i mali, non avere cattivi ricordi») nei confronti dei suoi avversari. Malgrado l’opposizione dei più faziosi, che, come Lisia, esigevano la punizione dei Trenta, il giuramento fu efficace e gli ateniesi non dimenticarono l’accaduto, ma sospesero i loro “cattivi ricordi”, lasciarono cadere il risentimento. Non si trattava tanto, a ben guardare, di memoria e di dimenticanza, quanto di saper distinguere i momenti del loro esercizio».
Giorgio Agamben, il manifesto 23 dicembre 1997
«Il maggior numero di amnistie si è registrato durante il regime fascista: in 22 anni di dittatura ce ne sono state 51». Per Luciano Violante l’amnistia sarebbe dunque un’istituzione giuridica predemocratica. Lo ha detto con una bella faccia tosta durante il meeting di Comunione e Liberazione tenutosi a Rimini come ogni anno in pieno agosto. Erano i giorni in cui imperversava la polemica tra Scalfari e Zagrebelsky, innescata dallo scontro tra Quirinale e procura di Palermo attorno alla vicenda della trattativa tra Stato e Mafia e alle intercettazioni telefoniche nelle quali sono finite le voci del capo dello Stato e di un suo importante collaboratore.
Si rompe il fronte giustizialista
Sceso in difesa di Napolitano, Violante ha denunciato la pericolosità di un blocco politico-editoriale che farebbe capo «al Fatto quotidiano, Grillo e Di Pietro», e che starebbe «reindirizzando il populismo italiano verso un populismo giuridico», intenzionato – sempre secondo le sue parole – a «sostituire la democrazia con il processo penale per questo incita le procure a farsi levatrici di un nuovo ordine».
Populismo giuridico è un termine impreciso e fuorviante rispetto alle definizioni impiegate sull’argomento dalla letteratura scientifica negli ultimi venti anni, dalla pubblicazione nel 1997 del testo di Torbjorn Vallinder e Neal Tate, The Global Expansion of Judicial Power, nel quale si adoperava il termine “giudizializzazione”, ai testi francesi di Antoine Garapon e Dénis Salas che parlavano di “giudiziarizzazione”, paventando un governo dei giudici e una Repubblica penale; lavori ripresi in Italia da Carlo Guarneri sulla democrazia giudiziaria.
Al di là del neologismo imperfetto, la denuncia di Violante è apparsa molto forte e soprattutto sorprendente nella bocca di un esponente politico da sempre ritenuto il maggiore rappresentante del partito dei giudici, l’anello di congiunzione con le procure d’assalto insieme al blocco editorial-finanziario capeggiato da Carlo De Benedetti, il teorico di un sostanzialismo giuridico che vede nell’azione penale, nel protagonismo giudiziario, lo strumento principe dell’azione politica.
La rottura è forte anche perché ha messo fine a sodalizi antichi come il legame storico intrecciato con Giancarlo Caselli (oggi firma di punta del Fatto quotidiano) negli anni della guerra giudiziaria alla sovversione sociale e alla lotta armata per il comunismo nelle fabbriche, rinsaldata negli anni dell’antimafia quando Violante divenne presidente della commissione parlamentare (1992-1994) e Caselli procuratore della repubblica di Palermo (1993-1999) ed insieme condussero una manovra a tenaglia contro Andreotti e i suoi legami mafiosi, sponsorizzando la “banda del bacio” con i fedeli fgliocci Ingroia e Scarpinato a tentare in tutti i modi di provare la veridicità delle parole del pentito Di Maggio sul bacio d’iniziazione mafiosa che Riina avrebbe dato ad Andreotti. Anche questa finita in un plateale fallimento.
A questo punto è normale chiedersi se questa sortita sia la prova che qualcosa è veramente cambiato nella cultura politico-giuridica di Violante, ora che anche egli grida alle malefatte del giustizialismo. La risposta fornita contro l’amnistia, e soprattutto l’argomento prescelto, sembrano dirci di no anche se è vero che da circa un decennio il vecchio responsabile della sezione problemi dello Stato del Pci ha gradualmente elaborato una presa di distanze dalla stagione dell’interventismo giudiziario più sfrenato, priva tuttavia di qualsiasi accenno autocritico.
Il Frankenstein giustizialista non da più retta al suo inventore
Più che una rottura con la filosofia giustizial-emergenzialista, costruita attorno al mito della forza emancipatrice dell’intervento penale, quella di Violante appare solo un’azione di contrasto, un’opposizione tattica verso un fenomeno, il populismo giustizialista – di cui lui e il suo partito hanno perso da diverso tempo il controllo, dopo averlo lungamente accarezzato e sospinto negli anni in cui serviva a fare campagna contro Berlusconi.
Violante è consapevole che la dinamica politica avviata da Tangentopoli si è rivelata nel tempo un disastro per le sorti del suo schieramento politico, non solo perché ha favorito il fronte avverso consentendo il lungo regno berlusconiano ma soprattutto perché ha traghettato la società verso i lidi di un qualunquismo forcaiolo che come una valanga si abbatte ormai senza più alcuna distinzione sul ceto politico, fino a travolgere il deus ex machina del governo Monti.
Le amnistie del perido post-unitario e del Fascismo
Che il periodo repubblicano abbia dato luogo, come dice Violante, ad un minor numero di atti di clemenza è vero solo in parte. Una più durevole stabilità politica interna e internazionale (non ci sono state guerre, solo guerriglie, in Europa) e l’introduzione del voto parlamentare (per giunta divenuto ancora più restrittivo negli ultimi 20 anni, grazie proprio ad una sua iniziativa parlamentare), al posto della semplice volontà del monarca o del governo, hanno reso più laborioso il varo delle clemenze. Almeno 230 sono state quelle censite tra il 1861 e il 1943. Varate per fare fronte ad una lunga fase storica caratterizzata da periodi controversi: prima le violente repressioni post-unitarie, il brigantaggio, le rivolte agrarie, i moti popolari, le persecuzioni di anarchici e socialisti in un Paese dove la rappresentanza parlamentare restava censitaria. Successivamente due conflitti mondiali, il ciclo rivoluzionario degli anni 20 e l’avvento violento del Fascismo, che una volta stabilizzato ha fatto ricorso a numerose amnistie autolegittimanti contro gli oppositori politici, mantenendoli tuttavia sotto un rigido controllo poliziesco in luoghi di confino, spesso isole lontane.
Le amnistie nei due momenti della fase repubblicana
Dopo il 1944 i provvedimenti di clemenza sono stati in tutto 34: solo due negli ultimi 22 anni, ben 32 nel primo quarantennio della Repubblica. 18, tra il 1944 e il 1953, hanno sanato i postumi penali del conflitto bellico e della guerra civile; 3 amnistie-indulto sono intervenute negli anni 60 per chiudere l’epoca bellica e riequilibrare la repressione contro moti cittadini e lotte agrarie. Ancora 3 amnistie hanno affrontato il Sessanttotto e il successivo “Autunno caldo”. Altre 5 piccole amnistie, di cui 2 per reati tributari, sono state varate tra il ‘78 e l’86, poi c’è stato il provvedimento del 1990 concepito per compensare le disparità di trattamento tra vecchio e nuovo regime processuale provocate dal nuovo codice di procedura penale. Infine più nulla fino all’indultino del 2003 e all’indulto del 2006, varati per affrontare il sovraffollamento carcerario.
Non è vero dunque che il periodo repubblicano abbia fatto a meno della clemenza che la dottrina giuridica concepisce come uno strumento della politica penale in grado di calmierare gli eccessi repressivi o il perdurare oltre ogni ragione della punizione.
I provvedimenti di amnistia e indulto concessi dopo il 1943
|
| Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari |
| Decreto Luogotenente 26 ottobre 1944, n. 17. Concessione di amnistia e indulto per reati in materia finanziaria |
| Decreto Lgt. 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944 |
| Decreto Lgt. 17 novembre 1945, n. 719. Amnistia per reati politici antifascisti. |
| Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 132. Amnistia e condono per reati militari |
| Decreto Lgt. 29 marzo 1946, n. 133. Indulto per alcuni reati di mancato conferimento degli ammassi |
| Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4. Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari |
| Decreto Presidenziale 27 giugno 1946, n. 25. Amnistia per reati finanziari |
| Decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 244. Estensione dell’amnistia, dell’indulto e della grazia ai condannati in territori attualmente sottratti all’Amministrazione italiana |
| Decreto C.P.S. 1 marzo 1947, n. 92. Amnistia e indulto per reati militari in occasione del giuramento alla Repubblica delle Forze Armate |
| Decreto C.P.S. 8 maggio 1947, n. 460. Amnistia e indulto per reati riguardo ai quali vi è stata una sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra |
| Decreto C.P.S. 25 giugno 1947, n. 513. Amnistia e indulto per reati commessi in relazione con vertenze agrarie |
| Decreto Presidente della Repubblica 9 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari |
| D.P.R. 28 febbraio 1948, n. 138. Amnistia per reati finanziari |
| D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464. Concessione di amnistia e indulto in materia di detenzione abusiva di armi |
| D.P.R. 26 agosto 1949, n. 602. Concessione di amnistia e indulto per reati elettorali |
| D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 929. Concessione di amnistia e condono in materia annonaria |
| D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 930. Concessione di indulto |
| D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834. Concessione di amnistia in materia di reati finanziari |
| D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525. Concessione di amnistia per reati tributari |
| D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43. Concessione di amnistia per reati tributari |
| D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. Concessione di amnistia e indulto |
| D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia |
| D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessione di indulto |
| Legge n. 207, 3 agosto 2003. Concessione del cosiddetto “indultino” |
| Legge n. 241, 31 luglio 2006. Concessione di indulto. |
Un’invenzione della democrazia ateniese
D’altronde la prima amnistia di cui si ha notizia è concessa dal democratico ateniese Trasibulo nel 403 avanti cristo. Dopo aver abbattuto la sanguinosa oligarchia dei Trenta, il partito democratico vincitore prestò un giuramento in cui si impegnava a «deporre il risentimento» (me mnesikakein, letteralmente «non ricordare i mali, non avere cattivi ricordi») nei confronti dei suoi avversari.
«Secondo me, amnistia è la parola più bella del linguaggio umano», faceva dire Victor Hugo a Gauvin, il personaggio che in Quattre-vingt-treize si oppone al giacobino Cimourdain e al vandeano Lantenac.
Solo pochi decenni fa l’amnistia era considerata una parola di sinistra. Nata con la democrazia ateniese era parte del repertorio delle forze che si dicevano democratiche. Fin dalle origini aveva animato le battaglie di libertà del movimento operaio. Convogliava un’idea di società tollerante e progressiva, conteneva una domanda di giustizia moderatrice consapevole dell’importanza che il ricorso a strumenti di correzione politica della fermezza penale, ispirati a quella mitezza tratta dalle vecchie massime latine che richiamano prudenza ed equità nell’applicazione della legge, svolgeva una funzione riparatrice delle ingiustizie.
Cosa è accaduto nel frattempo?
La finzione che presuppone il gioco democratico moderno, ovvero quel volersi proporre come il compimento stesso della politica, il grado più elevato della sua capacità inclusiva, si è trasformato in una gabbia totalitaria incapace di concepire l’altro da sè. Evocare l’amnistia equivarrebbe a voler riconoscere la persistenza di conflitti di fondo, la presenza di una disarmonia politica, ma la democrazia concepita come stadio finale della storia non lo accetta e così depolicizza il conflitto e criminalizza il nemico interno.
La soluzione starebbe nell’abbandono di quest’ipocrisia accettando l’idea del conflitto, unica residua possibilità di calare di nuovo l’idea di democrazia tra le rughe della storia, consentendo di recuperare quei necessari strumenti di ripoliticizzazione delle controversie, dopo aver affrontato fasi traumatiche di scontro. Una bestemmia per gli attuali regimi che si vogliono democratici inchiodati ad un insanabile paradosso: ribadire la figura del nemico irriconciliabile nel momento in cui vorrebbero affermarsi come un modello di superamento dell’inimicizia politica.
Bibliografia utile
Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986, pp. 278
Stéphan Gacon, L’Amnistie, Seuil, Paris 2002, pp. 424
L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392
Une histoire politique de l’amnistie, a cura di Sophie Wahnich Puf, Parigi, aprile 2007, pp. 263
Altri interventi sullo stesso argomento
Agamben, Europe des libertés ou europe des polices
Agamben, Lo stato d’eccezione
Il caso italiano, lo stato di eccezione giudiziario
La fine dell’asilo politico
La giudiziarizzazione dell’eccezione/2
La giudiziarizzazione dell’eccezione/1
Garapon, l’lutopia moralizzatrice della giustizia internazionale
Arriva il partito della legalità
La logica premiale e logica vittimaria ispirano la nuova filosofia penale
Giustizia o giustizialismo? Dilemma nella sinistra
Processo breve, amnistia per soli ricchi
Recidiva: l’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza
Niente amnistia perché ci vogliono i 2/3 del parlamento? Allora abolite le ostative del 4-bis e allungate la liberazione anticipata: basta la maggioranza semplice