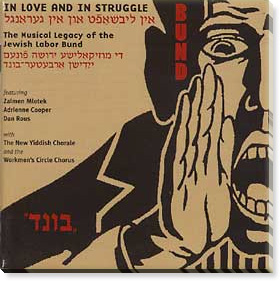Scheda – Il ruolo delle corti costituzionali tra costituzioni rigide e costituzioni aperte
«Kant introduce il concetto di repubblica, invitando a non confonderla con la democrazia» da lui intesa come «la democrazia diretta teorizzata da Rousseau». Qui è in gioco un nodo teorico fondamentale di cui oggi si è persa la pregnanza. Nel corso della storia successiva, infatti, si è operato un lento slittamento semantico e concettuale che ha attribuito alla democrazia i requisiti della repubblica kantiana. Il contrasto tra Rousseau e Kant ruota attorno al fondamento della sovranità e alla nozione di rappresentanza. Per Rousseau la sovranità si fonda sulla volontà generale mentre per Kant il suo fondamento deriva dal possesso della competenza. Per il primo, tutto ciò che allontana l’esercizio della volontà generale (ometto, per semplicità, di ricordare che, secondo Rousseau, la volontà generale non coincide con la volontà di tutti), attraverso il meccanismo della delega, della rappresentanza, introduce un elemento d’alienazione politica, una espropriazione della volontà operata attraverso la costruzione di una separatezza decisiva tra governanti e governati. Lo scrutinio in una tale logica non è più il momento in cui si manifesta la volontà, ma il luogo in cui si realizza il furto della volontà. Non ho a memoria la definizione che Schumpeter offre della democrazia, ma più o meno ricalca il concetto roussoinano della designazione di coloro che più tardi sceglieranno per noi. Secondo Kant, una tale democrazia è inevitabilmente dispotica poiché introduce il rischio della dittatura delle maggioranze. La critica kantiana, però, non va nel senso di una correzione della concezione roussoiana, ma introduce un paradosso che fa della separatezza, della selezione di pochi, gli ottimi, i saggi, coloro capaci d’interpretare l’apriori del diritto naturale e dunque di esercitare secondo misura il governo, il requisito della repubblica. Il modello kantiano avvia il paradigma che ispirerà i regimi liberali, ovvero una rappresentanza di governo affidata a pochi, coloro che sono degni sulla base del censo e della proprietà. I “livellatori” inglesi avevano già teorizzato (contro gli “zappatori”) il nesso libertà-capacità autonoma di sostentamento. L’autonomia, e dunque la capacità di decidere politicamente fuori da possibili ricatti, è data – dicevano – dalla possibilità di provvedere autonomamente alla propria riproduzione sociale. Solo la piccola e la grande proprietà potevano dunque essere parte della polis. E la guerra con gli Ironsides di Cromwell avviene proprio sulla porzione di proprietà che doveva dare accesso alla rappresentanza politica. Chi dipendeva, per servitù o contratto, da un datore di lavoro, un padrone, non essendo emancipato socialmente dalla condizione di schiavitù economica restava indegno della cittadinanza politica perché ricattabile. La repubblica kantiana ricicla elementi della tradizione oligarchica antica. La capacità di distinzione è il suo filo conduttore: dare il governo ai migliori, ai competenti, a coloro che posseggono sapere e proprietà, inscindibile nelle epoche passate. Solo quando il movimento operaio acquisterà forza vi sarà una progressiva correzione con l’introduzione del suffragio universale, fermo restando che l’esercizio della delega resta monopolio dell’élite. Ricordo che gli attuali regimi di governo rappresentativo (che comunemente vengono definiti democrazia) sono il risultato di un compromesso tra tradizione roussoiana, riveduta e corretta, e modello kantiano. La sovranità popolare, mediata dalle rappresentanze parlamentari, è corretta dall’istituto delle corti costituzionali che fondano la loro sovranità non sulla volontà ma sulla competenza. Il dibattito che attraversa la nascita della nazione americana e del suo sistema istituzionale, riportato in quell’eccellente documento che è il Federalist, è interamente traversato dal configgere tra le due anime sociali, la radicalità dell’individualismo proprietario della piccola proprietà coloniale che vede nella tradizione roussoiana un’ispirazione e gli interessi della grande proprietà che guardano a Kant. Per dimostrare, però, quanto la questione sia complessa occorre ricordare che questo schema ottocentesco verrà capovolto a metà del Novecento, quando proprio il ruolo della corte costituzionale americana, ovvero l’istituto figlio della tradizione politica più moderata e aristocratica diventa il grimaldello utilizzato dal movimento dei diritti civili per imporre alla social majority wasp i diritti delle minoranze etniche, sessuali eccetera. Insomma l’esercizio dei saggi, i magistrati dell’alta corte capaci di interpretare la costituzione (rigida) facendovi rientrare i principi del diritto naturale, consente di sancire conquiste progressiste a discapito della volontà discriminatrice della maggioranza. Kant si vendica contro Rousseau ma anche contro coloro che lo avevano interpretato come un avamposto del privilegio. Ovviamente quanto più la costituzione è rigida, tanto più centrale è il ruolo politico della Corte costituzionale chiamata per il mezzo dell’interpretazione ad aggiornarne il senso. Con modelli di costituzione (di tipo giacobino) aperti all’aggiornamento-adeguamento con la costituzione materiale, il ruolo della Corte dovrebbe essere meno centrale e soprattutto meno politico.
Tutti i modelli d’autority, o di expertises politiques (l’attribuzione a esperti di rapporti e studi che contribuiscano a produrre la scelta politica finale) frequenti nella tradizione anglosassone, e ripresi anche da noi, appartengono alla visione kantiana della res pubblica, ovvero all’idea di una competenza legittimata a governare, vigilare e garantire, meglio degli istituti che traggono sovranità dalla volontà, come il parlamento.
Link
Dal vertice della consulta una replica alle critiche sul ruolo della corte costituzionale
Il nuovo odio della democrazia
Cronache carcerarie
Populismo penale