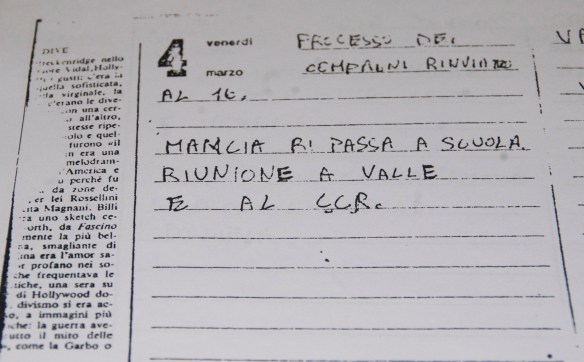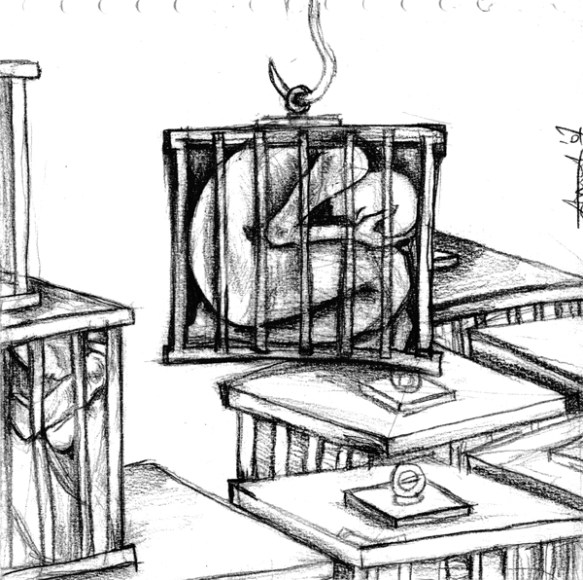Caro Saviano, ti scrivo…
di Oliviero Beha
il Fatto Quotidiano 20 aprile 2011
Caro Roberto, non ti conosco personalmente ma come tutt’Italia e credo in parecchi all’estero so chi sei da quello che prima scrivevi soltanto e oggi dici. In tv. Davanti a milioni di spettatori. Non so oggi, dopo il bagno oceanico di notorietà, ma qualcosa mi dice che ieri, prima della tua crocifissione camorrosa e della tua resurrezione mediatica, anche tu come me e qualche drammaturgo famoso del passato avresti dubitato di un Paese che ha bisogno di eroi. Per questo ti scrivo ora, che si sono accumulati progressivamente e velenosamente degli episodi che ti riguardano. Dalla minuzia dell’appoggio pubblico a Gianni Riotta, evidente vittima sacrificale di un potere che dopo essere stato servito da lui in maniche di camicia intende rigettarlo indietro come fosse un lift d’ascensore, sia pure debordante di milioni (ci sono a destra, ci sono a sinistra, fanno spesso la differenza più dell’appartenenza…). Alla querela a “Liberazione” per il “caso Impastato”, che suona già male a raccontarla, figurati a sporgerla. Al video riemerso dopo la tragica morte di Vittorio Arrigoni, video senza risposta in cui lui ti accusava nell’ottobre scorso di – uso un eufemismo colloquiale – “leggerezza e superficialità parziali” nel raccontare la vita a Tel Aviv. Detto da uno che rischiava la morte nell’embargo di Gaza tutti i giorni, fino all’epilogo funesto in cui un presidente ha usato finalmente un termine giusto, “barbarie”, e una madre ha dato lezioni di fermezza e nobiltà come raramente m’era capitato di vedere. Ma questo sommario serve solo per cercare di mettere in chiaro una cosa: Roberto, la tua credibilità passa per l’essere messa continuamente in discussione, criticato (come vox media, cioè etimologicamente prima “separato” dagli altri e poi “giudicato”) per quello che dici, scrivi, fai, rappresenti. L’essere invece uno spartiacque per cui da sinistra va tutto bene e da destra tutto male, cfr. gli attacchi dei giornali di Berlusconi quasi quotidiani, non può tradursi in allori, mostrine, coccarde. Non vieni promosso per le botte di Sallusti, Feltri o Ferrara, così come pure non puoi lasciare loro il monopolio quasi assoluto del diritto e a volte dovere di critica. Tu ti sei trovato per il cumulo di circostanze che sappiamo a esemplificare il diritto/dovere di parlare contro le mafie, contro l’Italia che affonda sotto il pelo d’acqua di una legalità il cui livello scende di continuo. E il mare rischia di farci affogare tutti, non soltanto i “cattivi” a volte fortunatamente riconoscibili almeno attraverso le sentenze dei Tribunali. L’idea di un totem di nome Saviano corre i rischi del grottesco, anche per i mille rivoli che poi prende. Qualcuno, infatti, dice che sei diventato un milionario in qualità di professionista dell’anti-camorra, qualcun altro che se la camorra ti voleva far fuori l’avrebbe già fatto, chiunque ti critichi rischia di essere un infame, un invidioso che vorrebbe stare al posto tuo (nei guadagni, non nelle rogne) o se gli va bene “uno di destra”, un berlusconiano di complemento. Questo in un’Italia in cui i giudici integerrimi per essere tali devono venir ammazzati e i giornalisti censurati… Chiediti se tutto ciò, oltre a dipendere sicuramente dalla malafede di qualcuno, non dipenda da una tua trasformazione in corso d’opera. Se la mediaticità non abbia creato o rischi di creare un “nuovo mostro” sia pure dalla parte giusta, se tu non venga usato ma in primis da te, con finalità diverse da quelle con cui sei partito, se tu non sia diventato il Saviano di te stesso, da quando la tv ti ha reso una figura molto incisiva per quell’aria omeopatica da “camorrista buono” (prova a immaginare – che so – fisicamente un Oscar Giannino nella tua parte…), se non siano ormai in molti a travisare il senso e il significato della tua connotazione pubblica consumandoti come un prodotto, sia pure “genuino” in opposizione agli Ogm di controparte. Insomma, Roberto, è vero che ci capita ciò che ci somiglia, ma forse ci sono momenti in cui bisognerebbe evitare di somigliare a ciò che ci capita. Con stima.
Fonte: http://www.behablog.it/dett.php?id=1463
Link
Saviano e il brigatista
Ma dove vuole portarci Saviano
Il ruolo di Saviano. Considerazioni dopo la partecipazione a “Vieni via con me”
Pg Battista: “Come ragalare un eroe agli avversari. Gli errori della destra nel caso Saviano”
Non c’è verità storica: il Centro Peppino Impastato diffida l’ultimo libro di Roberto Saviano
Diffida e atto di messa in mora. Rettifica libro “La parola contro la camorra” di Roberto Saviano
Castelvolturno, posata una stele per ricordare la strage di camorra ma Saviano non c’era e il sindaco era contro
Alla destra postfascista Saviano piace da morire
Populismo penale
Il diritto di criticare l’icona Saviano
La libertà negata di criticare Saviano
Saviano, l’idolo infranto
Pagliuzze, travi ed eroi
Attenti, Saviano è di destra, criticarlo serve alla sinistra
Buttafuoco, “Saviano agita valori e codici di destra, non regaliamo alla sinistra”