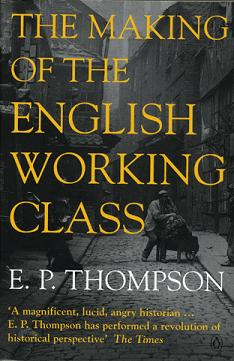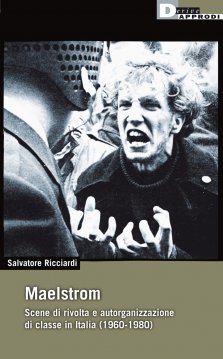Non esiste una finanza buona e una cattiva. Anche i fondi sovrani e i fondi pensione ricorrono alla speculazione per avere profitti immediati
Paolo Persichetti
Liberazione 22 luglio 2011
 Di fronte all’ennesima tempesta che si è abbattuta sui mercati finanziari sono state riproposte grosso modo due chiavi di lettura. La prima, sostanzialmente assolutoria nei confronti dei circuiti borsistici, si ispira alla teoria liberista che postula la piena efficienza dei mercati finanziari. La ricerca sfrenata di ricchezza privata che muove le speculazioni borsistiche – sostengono i paladini di questa posizione – non entrerebbe in contrasto con l’interesse generale delle economie dei vari Paesi, perché il principio di concorrenza sarebbe in grado di generare delle mediazioni finanziarie efficaci. Insomma il giudizio dei mercati non si discute poiché sarebbe il solo in grado di produrre soluzioni razionali e performanti capaci di offrire quella liquidità monetaria indispensabile agli Stati per finanziare il debito pubblico interno. Più che una filosofia siamo di fronte ad una teologia che introduce nei fatti un nuovo fondamento della sovranità. Le implicazioni collegate a questo assunto sono gravide di conseguenze importanti. Esse fuoriescono dalla semplice sfera economica per investire dimensioni politico-filosofiche che modificano il funzionamento, oltre che il significato, dei modelli politici pluralisti che per comodità passano sotto il nome di democrazie. In Italia il Pd ha sposato integralmente questa lettura dei fatti cercando nella sanzione espressa dai gruppi speculativi che hanno attaccato i bond governativi una legittimità alla propria candidatura alla guida del Paese. Perplessità sull’operato dei mercati borsistici sono venute, invece, da settori della destra di governo fornendo l’ennesima prova di quel paradossale capovolgimento di senso dei punti cardinali della politica.
Di fronte all’ennesima tempesta che si è abbattuta sui mercati finanziari sono state riproposte grosso modo due chiavi di lettura. La prima, sostanzialmente assolutoria nei confronti dei circuiti borsistici, si ispira alla teoria liberista che postula la piena efficienza dei mercati finanziari. La ricerca sfrenata di ricchezza privata che muove le speculazioni borsistiche – sostengono i paladini di questa posizione – non entrerebbe in contrasto con l’interesse generale delle economie dei vari Paesi, perché il principio di concorrenza sarebbe in grado di generare delle mediazioni finanziarie efficaci. Insomma il giudizio dei mercati non si discute poiché sarebbe il solo in grado di produrre soluzioni razionali e performanti capaci di offrire quella liquidità monetaria indispensabile agli Stati per finanziare il debito pubblico interno. Più che una filosofia siamo di fronte ad una teologia che introduce nei fatti un nuovo fondamento della sovranità. Le implicazioni collegate a questo assunto sono gravide di conseguenze importanti. Esse fuoriescono dalla semplice sfera economica per investire dimensioni politico-filosofiche che modificano il funzionamento, oltre che il significato, dei modelli politici pluralisti che per comodità passano sotto il nome di democrazie. In Italia il Pd ha sposato integralmente questa lettura dei fatti cercando nella sanzione espressa dai gruppi speculativi che hanno attaccato i bond governativi una legittimità alla propria candidatura alla guida del Paese. Perplessità sull’operato dei mercati borsistici sono venute, invece, da settori della destra di governo fornendo l’ennesima prova di quel paradossale capovolgimento di senso dei punti cardinali della politica.
L’altra chiave di lettura ricorre, al contrario, alla tesi dell’anomalia dei comportamenti tenuti in Borsa, al mancato rispetto delle regole finanziarie. E’ grosso modo la strada perseguita dalle associazioni che hanno denunciato azioni di manipolazione del mercato, depositando degli esposti presso la magistratura nei quali additano il ruolo ambiguo delle agenzie di rating, ritenute le capofila della filiera speculativa. In questo caso il profitto speculativo, oltre ad essere ritenuto un vettore che provoca danni per la comunità, bruciando risorse, impedendo investimenti keynesianamente virtuosi nel ciclo produttivo, è percepito come immorale. Posizione ideologica che trae legittimità dalla vecchia etica calvinista del capitale e rispecchia gli interessi dei ceti medi, dei piccoli azionisti e risparmiatori vittime delle bufere che traversano i mercati finanziari. Un atteggiamento ammantato d’ipocrisia morale poiché trova al contrario accettabile l’estrazione di plusvalore, la spremitura della forza lavoro umana.
Esiste tuttavia una terza interpretazione che non considera le ricorrenti crisi dei mercati finanziari degli ultimi 30 anni l’effetto di errori, incidenti o comportamenti irrazionali ma il risultato del pieno rispetto del libero gioco borsistico. E’ la tesi sostenuta in particolare da André Orléan, studioso francese di scuola regolazionista, che in un volume apparso nel 2010 (Dall’euforia al panico. Pensare la crisi finanziaria, Ombre corte) ritiene le crisi conseguenza «non del fatto che le regole del gioco finanziario siano state aggirate ma del fatto che sono state seguite». A differenza di quel che accade nell’economia reale, sui mercati finanziari domanda e offerta agiscono in modo diverso, nota l’autore. L’aumento della domanda di un bene non ne fa aumentare solo il prezzo ma anche la richiesta, a causa dei rendimenti accresciuti che lo rendono ancora più attraente. Le crisi, in sostanza, sarebbero il fondamento stesso del funzionamento del sistema borsistico che agisce in modo autoreferenziale, investendo su prodotti finanziari “derivati” alla ricerca di rendimenti decorrelati, cioè sempre più scollegati dall’economia reale. Orléan ne indaga in modo accurato la dimensione ideologica ed emotiva, la rincorsa mimetica dei diversi operatori che suscitano momenti di euforia (da cui fuoriescono la cosiddette “bolle”) e le fasi di panico che caratterizzano la sua strutturale volatilità. La finanziarizzazione dell’economia capitalistica agisce come un continuo processo d’inclusione-esclusione che per certi versi sembra una riedizione continua dell’accumulazione primitiva con i suoi caratteri brutali.
Esistono delle soluzioni? A parte l’oltrepassamento del capitalismo, utili ma non risolutivi sarebbero certamente degli interventi in favore della tassazione delle operazioni borsistiche, la messa al bando di alcuni prodotti finanziari e tecniche speculative. Gran parte del problema tuttavia riguarda il nodo del debito pubblico e del suo finanziamento, attorno al quale ruota – come abbiamo visto – il problema della sovranità. La globalizzazione finanziaria ha tolto agli Stati la capacità di controllo sull’andamento dei titoli un tempo confinati in prevalenza nel mercato nazionale. Le proposte fioccano: separare i circuiti bancari da quelli finanziari, ristabilire in controllo politico sulle banche centrali, favorire un fondo comune europeo per il finanziamento del debito pubblico, liberarsi dalla dittatura delle agenzie di rating, tornare all’economia reale.
2/fine
Link
Mercati borsistici, dietro l’attacco ai titoli di Stato l’intreccio tra fondi speculativi e agenzie di rating 1/continua
Il sesso lo decideranno i padroni: piccolo elogio del film Louise-michel
Cometa, il fondo pensioni dei metalmeccanici coinvolto nel crack dei mercati finanziari
Parla Bernard Madoff: «Le banche e la Sec sapevano tutto»
Le disavventure girotondine nel mondo della finanza