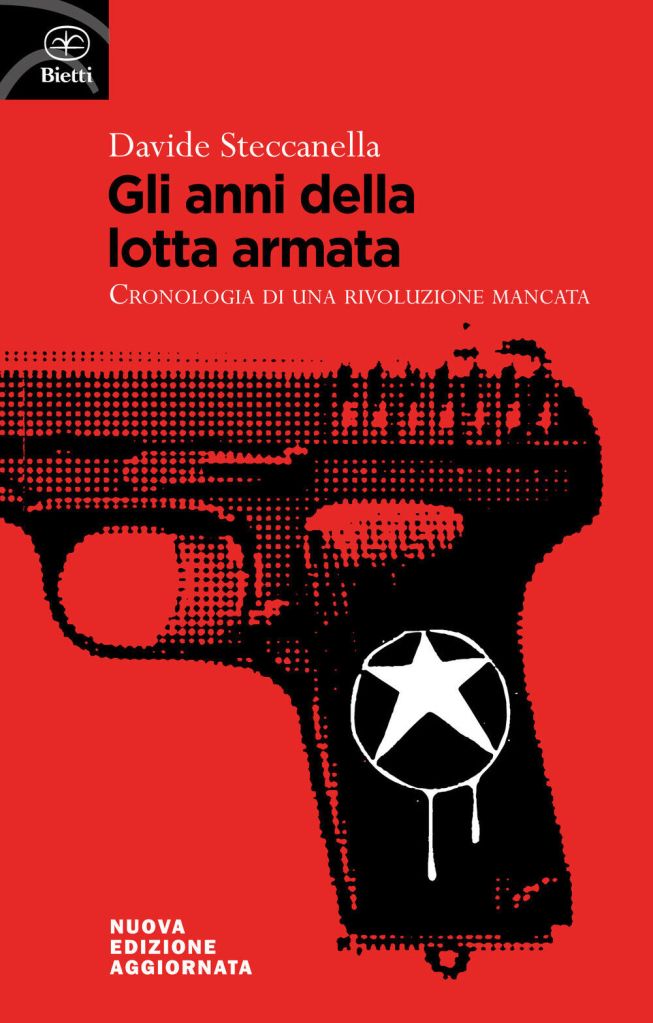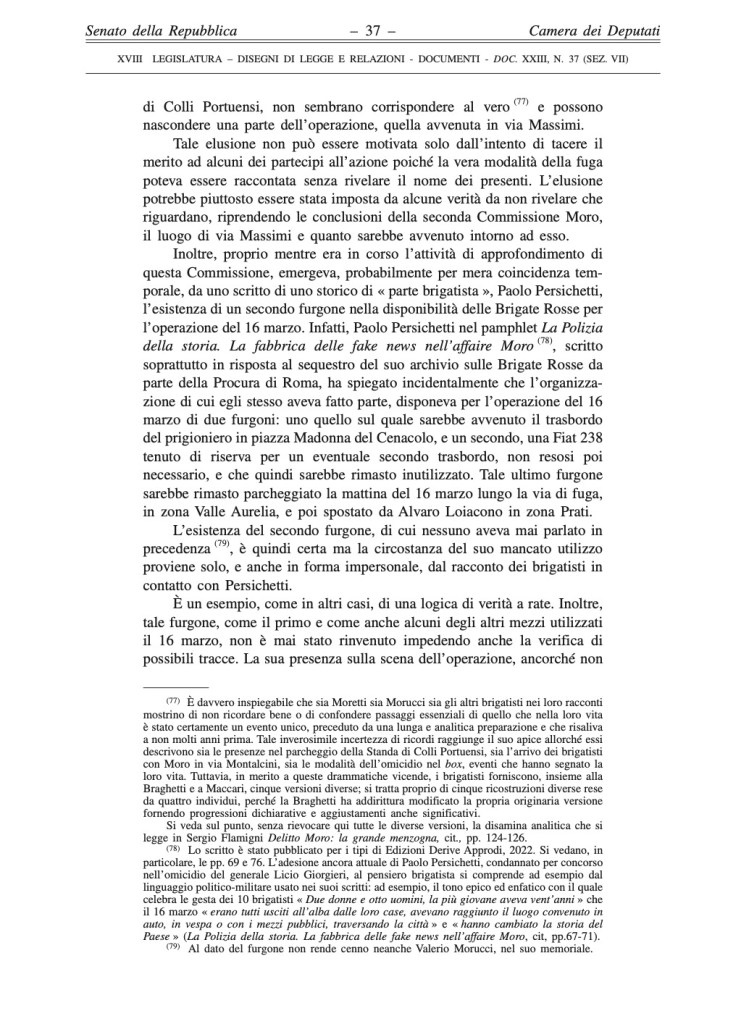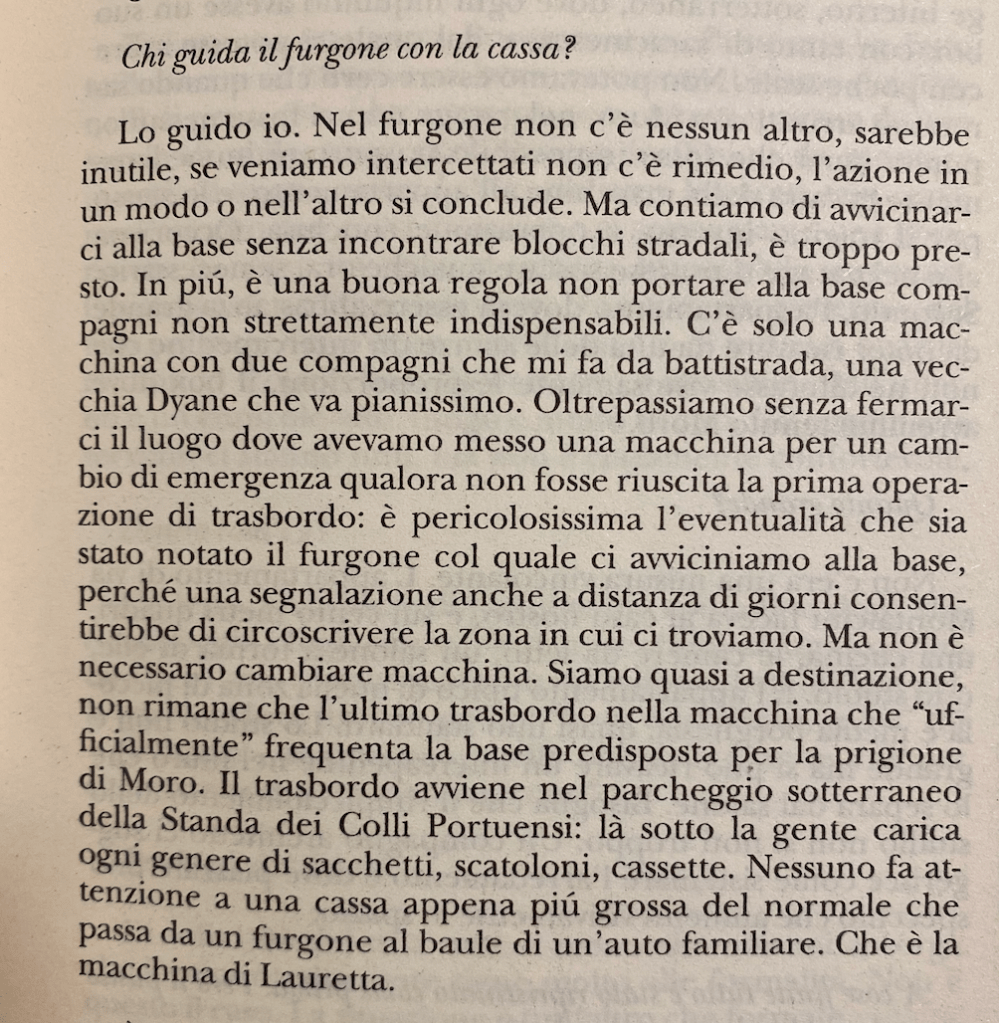Nel corso della trasmissione in onda su Report in questo momento l’ex vice segretario del partito socialista Claudio Signorile afferma di essere stato convocato al Viminale dall’allora ministro dell’Interno Francesco Cossiga la mattina del 9 maggio. Nel corso dell’incontro – afferma – Cossiga sarebbe stato avvisato da una telefonata del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. La comunicazione sarebbe giunta, secondo Signorile non oltre le 10.00 del mattino, perché ricorda che prese con un caffé «e il caffé non si prende a tarda mattinata». La telefonata che Valerio Morucci per conto delle Brigate rosse fece al professor Tritto è delle 12.13 minuti. La notizia venne diramata dall’Ansa alle 13.59 mentre il centralinio della sala operativa dei carabinieri riceve comunicazione del ritrovamento di un corpo all’interno di una Ranault 4 in via Caetani alle 13.50 e alle aale 13.59 conferma che si trattava del cadavere di Aldo Moro.
La testimonianza di Signorile lascia intendere dunque che apparati dello Stato erano al corrente del rinvenimento del corpo dello statista democristiano prima della telefonata della Brigate rosse. Una ricostruzione che porterebbe a ritenere provato il coinvolgimento di questi apparati nella esecuzione o comunque nella conoscenza delle ultime mosse fatte dalle Brigate rosse in quelle ore.
Una memoria scivolosa che cambia nel tempo
Tuttavia la testimonianza attuale di Signorile contrasta con quanto da lui affermato in passato.
A pochi anni di distanza dal ritrovamento del corpo di Moro, nei primi anni 80 davanti alla corte d’assise dove si svolgeva il primo processo sul sequestro dello statista democristiano, Signorile lungamente interrogato dal presidente e dalle parti civili non fece mai riferimento all’incontro conn Cossiga e tantomeno alla telefonata da lui ricevuta con largo anticipo sull’orario ufficiale sul ritrovamento del corpo di Moro.
Nel 1980 audito dalla prima commissione Moro accennò per la prima volta all’incontro con Cossiga, dove si era recato per perorare la causa della trattativa. quella mattina infatti si riuniva la direzione della Dc e Fanfani, da lui convinto, avrebbe dovuto prendere la parola in favore di un’apertura verso la trattativa. Disse che intorno alla 11 giunse la telefonata che avvertì Cossiga del ritrovamento del corpo di Moro. In commissione nessuno eccepì sull’orario, in largo anticipo con quello ufficiale, eppure erano presenti i vari Flamigni e compagni. Probabilmente intesero nell’orario inesatto di Signorile che volesse intendere in tarda mattinata o che le 11 era l’ora in cui fosse arrivato all’appuntamento.
Nel 1999 davanti alla commissione Pellegrino, Signorile tornò sull’incontro con Cossiga la mattina del 9 maggio 1978 senza riferire della telefonata giunta in anticipo.
Nel 2010 Francesco Cossiga è morto.
Nel 2013 l’artificiere Vittantonio Raso che la mattina del 9 maggio giunse in vai Caetani per le verifiche di sicurezza e l’apertura del portellone della Renault 4 dove si trovava Moro affermò di esser giunto sul posto con largo anticipo rispetto all’orario poi divenuto ufficiale e disse di aver visto Cossiga giungere una prima volta da solo e poi succesivamente, quando la notizia venne diffusa, con le altre autorità. L’inchiesta che ne seguì però smenti le sue affermazioni tanto da finire indagato per falsa testimonianza. Dopo le parole dell’artificiere, improvvisamente Claudio Signorile ritrovò la memoria per affermare che il 9 maggio era andato da Cossiga, stavolta non più per parlare della trattativa e di Fanfani ma convocato dal ministro dell’Interno che gli sarebbe apparso molto teso. Anche l’orario cambiava, non più le 11 ma tra le 9 e le 10, perché il caffé, che presero insieme, si prende presto e così anche la telefonata, il cicalino che suonò sulla scrivania del minsitro, si fece sentire molto prima. Insomma la polizia e Cossiga avrebbero saputo del ritrovamento del corpo la mattina del 9 maggio e questo perché forze straniere avrebbero agito quel giorno sostituendosi e imponendosi sulle Brigate rosse.
Da allora Signorile ha ribadito questa versione in interviste e in davanti la seconda commissione Moro nel 2016.
Insomma una memoria scivolosa quella dell’ex segretario del partito socialista che si arricchisce nel tempo di dettagli per decenni dimenticati e soprattutto quando chi potrebbe smentirlo e morto. Forse Signorile ha bisogno di dire queste cose per farsi perdonare il suo convolgimento nel tentativo di dare vita ad una trattativa che salvasse Moro.