Note a margine di un dibattito infinito
di Vladimiro Satta*
L’Altro, 17 giugno 2009
Un passaggio del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica lo scorso 9 maggio, in occasione della Giornata della Memoria, ha suscitato una pubblica discussione storiografica tuttora in corso. Napolitano ha definito «fantomatico» il “doppio Stato”, locuzione che fu introdotta nel  panorama italiano degli studi venti anni fa da Franco De Felice a proposito dei fenomeni eversivi degli anni di piombo e, in seguito, fu replicata con modifiche nelle varianti chiamate “Stato parallelo”, “Stato duale” e simili. In molti casi, il “doppio Stato” e i suoi derivati sono stati raffigurati quali protagonisti di una storia dell’Italia repubblicana vista in termini di sequela di complotti orditi in seno alle istituzioni.
panorama italiano degli studi venti anni fa da Franco De Felice a proposito dei fenomeni eversivi degli anni di piombo e, in seguito, fu replicata con modifiche nelle varianti chiamate “Stato parallelo”, “Stato duale” e simili. In molti casi, il “doppio Stato” e i suoi derivati sono stati raffigurati quali protagonisti di una storia dell’Italia repubblicana vista in termini di sequela di complotti orditi in seno alle istituzioni.
Tra i primi commenti al cenno presidenziale sul «fantomatico doppio Stato» si registra (11 maggio) il plauso di Pierluigi Battista, vicedirettore del Corriere della Sera, il quale lo ha salutato come una solenne bocciatura delle connesse teorie cospirative. Battista, nel suo pezzo, ha tratteggiato origini e lineamenti di quella che ha chiamato «misteriologia doppiostatista», ha elencato coloro che a suo avviso ne sono stati i maggiori esponenti e ha prospettato la possibilità che essa vada «in soffitta, almeno come storia ufficiale», se non anche come «fiction». Più sinteticamente e meno trionfalisticamente pure lo storico Giovanni Sabbatucci (Messaggero, 10 maggio) ha ripercorso il cammino della teoria del “doppio Stato” e se ne è augurato il definitivo tramonto. Su Liberazione (30 maggio) un altro storico, Marco Clementi, ha osservato che «uno studioso non può certo accontentarsi di una teoria senza riscontri (…) e i riscontri, per il doppio Stato, mancano», dopo che un redattore del quotidiano, Paolo Persichetti, aveva parlato d’inclinazione delle teorie complottistiche a disinteressarsi delle prove e, anzi, a spacciare le smentite per indizi di ulteriori cospirazioni contro la verità (21 maggio).
Alcuni fautori della tesi “doppiostatista” sono rimasti silenti, mentre altri hanno ribadito pienamente le loro convinzioni (senza pretese di completezza, segnalo: il 12 maggio L. Orlando, intervistato dal Corriere della Sera; il 13 maggio, G. De Lutiis su Liberazione, B. Gravagnuolo e M. Travaglio su Unità, F. Orlando su Europa; il 15 maggio, L. Grimaldi su Liberazione; poi di nuovo Travaglio, dapprima oralmente alla Fiera del Libro a Torino, il 16 maggio, e successivamente in forma scritta su Internet). Altri ancora, infine, hanno preso le distanze in vario modo rispetto alla teoria del “doppio Stato” e all’elenco redatto da Battista (G. Fasanella, lettera al Corriere della Sera, 12 maggio; G. Pellegrino, intervistato pure lui dal Corriere della Sera, 13 maggio; A. Giannuli, Liberazione, 4 giugno). Giannuli, in particolare, ha demolito «il mito» che le sconfitte della sinistra siano imputabili al “doppio Stato”; d’altro lato, asserendo che il “doppio Stato” non è un soggetto bensì «un processo», non è una doppia rete istituzionale mezza legale e mezza no, non è una sorta di cupola politico-criminale, non è la P2 né un servizio segreto misterioso e rinunciando ad attribuirgli il fine di «destabilizzare per stabilizzare» (conclusione che ancora compariva in un suo saggio del 2007), egli in pratica lo ha ridotto ad una mera astrazione priva di ragion d’essere, dai connotati a dir poco evanescenti, la cui identità poggia su un nome che non si addice ad «uno stato di fatto» né ad un «modo duplice di funzionare». Giannuli non ha intenzione di abbandonare del tutto il concetto di “doppio Stato”, ma arrivati a questo punto sarebbe più consequenziale farlo e guardare avanti.
Qualcuno ha protestato contro Battista interpretando la sua soddisfazione alla stregua di un anatema contro i teorici del complottismo “doppiostatista” e leggendo le sue indicazioni nominative alla stregua di liste di proscrizione, perciò è bene puntualizzare che la libertà di continuare a pensarla diversamente dal Capo dello Stato, dal vicedirettore del Corriere della Sera o da chiunque altro non è minimamente in questione. E guai se lo fosse. Le critiche altrui possono dispiacere ed alle volte essere sommarie o ingiuste, ma non vanno dipinte come intimidatorie quando non lo sono, anche perché così facendo si renderebbe impossibile il sano confronto tra opinioni diverse. Fare nomi, di per sé, non equivale a stilare liste di proscrizione e anzi ha due pregi: offre ai lettori riferimenti utili per approfondire (se lo desiderano) e consente di dare a ciascuno il suo. A condizione, beninteso, di non commettere errori nell’attribuzione delle rispettive posizioni.
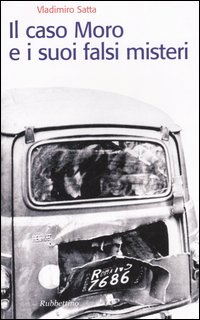 L’articolo di Battista tanto deprecato dai teorici della cospirazione contiene qualche inesattezza e tende ad appiattire le differenze tra i personaggi che cita: per fare un paio di esempi, Fasanella non fu consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta su terrorismo e stragi, e la linea di Giannuli diverge sensibilmente dallo schema iniziale di De Felice. Inoltre, l’articolo ha il difetto di non spiegare perché il giornalista concordi con Napolitano e dissenta dai teorici del “doppio Stato”.
L’articolo di Battista tanto deprecato dai teorici della cospirazione contiene qualche inesattezza e tende ad appiattire le differenze tra i personaggi che cita: per fare un paio di esempi, Fasanella non fu consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta su terrorismo e stragi, e la linea di Giannuli diverge sensibilmente dallo schema iniziale di De Felice. Inoltre, l’articolo ha il difetto di non spiegare perché il giornalista concordi con Napolitano e dissenta dai teorici del “doppio Stato”.
Dal canto mio, avendo in passato criticato estesamente le teorie del “doppio Stato” e simili, mi rallegro della dichiarazione del Quirinale. Trovo altresì opportuno che il Presidente abbia soggiunto: «per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull’operato di quanti indagarono e in particolare sull’operato della magistratura, esplicatosi in molteplici istanze e gradi di giudizio». Non si dimentichino i successi, dunque, non si dia per scontato che tutti gli sbagli fossero dolosi, e si consideri che un conto è avere decenni per riflettere giovandosi del lavoro pregresso compiuto da inquirenti, tribunali, commissioni di inchiesta, studiosi e via dicendo, mentre altro conto è agire sul momento, magari con urgenza.
E’ dolorosamente vero che le conoscenze sullo stragismo sono tuttora alquanto lacunose e che il disastro aereo di Ustica nel quale perirono 81 persone è addirittura un mistero, essendo certo solo che non si trattò di guasto ai motori né di cedimento strutturale. Ma le istanze di più verità e più giustizia non si appagano con le fantasie. Il discorso complessivo sulla condotta dello Stato di fronte agli attacchi piovuti da destra e da sinistra dalla fine degli anni Sessanta agli Ottanta, la quale presenta luci ed ombre, va impostato partendo da un quadro della situazione che esamini contestualmente le forze attaccanti e gli strumenti di contrasto disponibili.
In Italia le offensive eversive furono, per ampiezza e articolazione, superiori agli analoghi fenomeni occorsi in altri Paesi democratici. Lo stragismo neo-nazifascista, il terrorismo rosso e lo spontaneismo armato nero furono prodotti genuini degli ambienti più estremisti della società italiana di allora. Sebbene parzialmente concomitanti, essi non formarono un blocco unico né si allearono fra loro. Sul versante statale, i primi tempi furono caratterizzati da impreparazione degli apparati –che erano strutturati prevalentemente in funzione di controllo dell’ordine pubblico, un altro fronte caldo- e arretratezza della normativa, che per inerzia del legislatore si protrassero fino alla metà del 1974; seguì una seconda fase, da metà del 1974 ai primi del 1978, segnata da interventi rilevanti ma ondivaghi, per certi aspetti persino contraddittori e, comunque, non sempre positivi nel breve termine, che interessarono sia l’assetto degli apparati repressivi, sia la normativa su ordine pubblico, libertà dei cittadini e relative garanzie; una terza ed ultima fase si aprì dopo la pesante sconfitta militare patita in occasione della vicenda Moro, allorché lo Stato seppe risalire la china e maturò la sua vittoria definitiva grazie al concorso di molteplici fattori, fra i quali la ricostituzione in versione rafforzata dei nuclei antiterrorismo dei Carabinieri al comando di Carlo Alberto dalla Chiesa e la legislazione che incoraggiò il cosiddetto pentitismo. L’emergenza eversiva legittimò norme e trattamenti giuridici di eccezione a difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza che, tuttavia, non compromisero la libertà di espressione, il pluralismo politico e lo svolgimento di libere elezioni, una triade che rappresenta l’essenza delle democrazie. Anzi, i metodi con i quali l’Italia riuscì a debellare gli eversori furono più morbidi che in altri Paesi.
Passando ad analisi differenziate dei risultati conseguiti contro i nemici di turno, si nota che furono diseguali: maggiori contro il terrorismo rosso e contro lo spontaneismo armato nero, minori contro lo stragismo, un po’ perché quest’ultimo era più sfuggente, e un po’ perché esso talvolta usufruì di protezioni, attestate da episodi di slealtà degli apparati nei confronti della magistratura inquirente. Si trattò di favoreggiamenti a posteriori che, quantunque intrinsecamente gravi, non equivalgono a responsabilità dirette né a complicità nell’ideazione, preparazione o esecuzione degli attentati. Il Sid, quando nel 1973 negò alla magistratura le informazioni sul Giannettini da essa richieste, travalicò le comprensibili esigenze di copertura del suo collaboratore, i cui legami con il Servizio furono poi rivelati dal Ministro della Difesa Andreotti nel 1974. De Lutiis, nel 1997, scrisse che l’iniziale copertura del Giannettini, a suo avviso avallata dai politici, dipese dal fatto che «nell’attuazione dell’eccidio [di Piazza Fontana] era in qualche modo coinvolto un settore istituzionale dello Stato e dunque un possibile esecutore o intermediario non poteva essere abbandonato, rischiandosi in tal caso il disvelamento dell’intera catena di comando della strage». Se fosse stato così, però, non si capirebbe perché nel 1974 Andreotti abbia rovesciato la decisione di un anno prima. E’ più ragionevole supporre che, seppure tardivamente, l’opportunità di collaborare alle indagini su un crimine quale la bomba di Piazza Fontana abbia finalmente prevalso sulla tutela di una fonte del Servizio. In questo e negli altri casi del genere non ravviso le catene di comando dirette dalla Nato evocate da De Lutiis su Liberazione, e non le ravvisò neppure la magistratura che respinse le corrispondenti ipotesi in sede giudiziaria.
Comunque, lo stragismo cessò più per il fallimento dei propri obiettivi politici e per lo scioglimento del Movimento Politico Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale che per l’azione di contrasto svolta da forze di polizia e servizi segreti.
Concludo associandomi a Fassino e a Tranfaglia (cfr. Ansa e varie) nel dire che la gestione del Ministero dell’Interno negli anni Novanta da parte di Napolitano non merita il biasimo di Travaglio. L’attuale Presidente, all’epoca, diede piena collaborazione alla magistratura e alla Commissione Stragi, adoperandosi per recuperare e fornire tutta la documentazione possibile. Per quanto riguarda la Stragi valgano gli apprezzamenti tributati a Napolitano di cui è rimasta traccia nei resoconti e nelle relazioni periodiche sull’attività della Commissione.
* Documentarista della ex-Commissione Stragi
Link
Dietrologia e doppio Stato nella narrazione storiografica della sinistra italiana-PaoloPersichetti
La teoria del doppio Stato e i suoi sostenitori – Pierluigi Battista
La leggenda del doppio Stato – Marco Clementi
Italie, le theme du complot dans l’historiographie contemporaine – Paolo Persichetti
I marziani a Reggio Emilia – Paolo Nori
Ci chiameremo la Brigata rossa
Spazzatura, Sol dell’avvenir, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella
Lotta armata e teorie del complotto
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Storia della dottrina Mitterrand


 panorama italiano degli studi venti anni fa da Franco De Felice a proposito dei fenomeni eversivi degli anni di piombo e, in seguito, fu replicata con modifiche nelle varianti chiamate “Stato parallelo”, “Stato duale” e simili. In molti casi, il “doppio Stato” e i suoi derivati sono stati raffigurati quali protagonisti di una storia dell’Italia repubblicana vista in termini di sequela di complotti orditi in seno alle istituzioni.
panorama italiano degli studi venti anni fa da Franco De Felice a proposito dei fenomeni eversivi degli anni di piombo e, in seguito, fu replicata con modifiche nelle varianti chiamate “Stato parallelo”, “Stato duale” e simili. In molti casi, il “doppio Stato” e i suoi derivati sono stati raffigurati quali protagonisti di una storia dell’Italia repubblicana vista in termini di sequela di complotti orditi in seno alle istituzioni.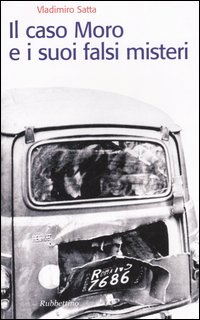 L’articolo di Battista tanto deprecato dai teorici della cospirazione contiene qualche inesattezza e tende ad appiattire le differenze tra i personaggi che cita: per fare un paio di esempi, Fasanella non fu consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta su terrorismo e stragi, e la linea di Giannuli diverge sensibilmente dallo schema iniziale di De Felice. Inoltre, l’articolo ha il difetto di non spiegare perché il giornalista concordi con Napolitano e dissenta dai teorici del “doppio Stato”.
L’articolo di Battista tanto deprecato dai teorici della cospirazione contiene qualche inesattezza e tende ad appiattire le differenze tra i personaggi che cita: per fare un paio di esempi, Fasanella non fu consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta su terrorismo e stragi, e la linea di Giannuli diverge sensibilmente dallo schema iniziale di De Felice. Inoltre, l’articolo ha il difetto di non spiegare perché il giornalista concordi con Napolitano e dissenta dai teorici del “doppio Stato”.
 riuscita nelle politiche dell’aprile scorso, quando l’Idv ha raggiunto il 4,4% su scala nazionale, con punte molto significative nel feudo storico dell’ex pm, il Molise, dove il logo di famiglia ha conquistato il 27%. Un risultato di gran lunga superiore a quello del Pd, fermo al 17%. In Abruzzo è arrivato al 7,1% nelle liste del senato mentre gli ultimi sondaggi delineano addirittura la possibilità di un raddoppio del bottino elettorale. Su scala nazionale tutti gli indicatori attuali segnalano una ulteriore progressione, che alcuni quantificano intorno a una forbice che oscilla tra il 6 e l’8%. La scomparsa della sinistra radicale, marxista e antagonista dalla rappresentanza parlamentare ha ulteriormente amplificato la portata politica di questo successo, garantendo a Di Pietro l’apertura imprevista di uno spazio politico enorme. La politica ha orrore del vuoto e così Di Pietro è subito corso a riempirlo. Mera logica del mercato politico, tanto più quando l’avventura dipietrista è ispirata da ragioni d’imprenditoria politica ovvero di chi costruisce la propria offerta sulla base della domanda che gli si pone davanti, dove idealità, valori, cultura, concezione del mondo, progetti globali di società non esistono o hanno un profilo molto basso e strumentale. E bene Di Pietro non si è lasciato sfuggire questa opportunità e così l’incubo del populismo giustizialista s’addensa sui territori un tempo occupati dai partiti del movimento operaio.
riuscita nelle politiche dell’aprile scorso, quando l’Idv ha raggiunto il 4,4% su scala nazionale, con punte molto significative nel feudo storico dell’ex pm, il Molise, dove il logo di famiglia ha conquistato il 27%. Un risultato di gran lunga superiore a quello del Pd, fermo al 17%. In Abruzzo è arrivato al 7,1% nelle liste del senato mentre gli ultimi sondaggi delineano addirittura la possibilità di un raddoppio del bottino elettorale. Su scala nazionale tutti gli indicatori attuali segnalano una ulteriore progressione, che alcuni quantificano intorno a una forbice che oscilla tra il 6 e l’8%. La scomparsa della sinistra radicale, marxista e antagonista dalla rappresentanza parlamentare ha ulteriormente amplificato la portata politica di questo successo, garantendo a Di Pietro l’apertura imprevista di uno spazio politico enorme. La politica ha orrore del vuoto e così Di Pietro è subito corso a riempirlo. Mera logica del mercato politico, tanto più quando l’avventura dipietrista è ispirata da ragioni d’imprenditoria politica ovvero di chi costruisce la propria offerta sulla base della domanda che gli si pone davanti, dove idealità, valori, cultura, concezione del mondo, progetti globali di società non esistono o hanno un profilo molto basso e strumentale. E bene Di Pietro non si è lasciato sfuggire questa opportunità e così l’incubo del populismo giustizialista s’addensa sui territori un tempo occupati dai partiti del movimento operaio.


 inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che
inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che  potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.
potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.
 migranti e richiedenti asilo. D’altro canto, con la crescente interdipendenza tra paesi e popoli, e con la coabitazione ‘coatta’ tra questi ultimi, la presenza dell’altro si rende visibile e finisce per creare insicurezza. Ecco un paradosso. L’insicurezza creata dai mercati riguarda tutti, o per lo meno le maggioranze, in termini di paura rispetto al futuro, vulnerabilità nei confronti del datore di lavoro, impotenza verso i processi decisionali. Ma una simile paura, che Bakhtin definirebbe ‘cosmica’, rivolta com’è a un potere inafferrabile e debordante, viene tradotta in sgomento indirizzato a minoranze visibili. Se lo Stato non può più difenderci dall’economnia, se non è più in grado di guidarla ma solo di obberdirle, allora dovrà difenderci da altre fonti di insicurezza. A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Il populismo non aspira al sostegno dell’opinione pubblica in generale, ma solo di quel settore della società che si crede sfavorito e danneggiato dalla presenza e dalle attività di altri gruppi. Questi ultimi, ritenuti immeritevoli di quanto posseggono, vengono indicati come responsabli dell’emarginazione di chi non vuole far altro che condurre un’esistenza ordinaria e silenziosa. Michael Howard, ministro britannico conservatore, in una dichiarazione rilasciata nel 1993, espresse con chiarezza questo pensiero: la maggioranza silenziosa è diventata rumorosa, perché il sistema della giustizia criminale fa ormai troppo per i criminali e troppo poco per la protezione del pubblico. Secondo una definizione comune, sono populisti i politici che concepiscono politiche penali punitive le quali sembrano rispecchiare gli umori popolari. Il populismo penale che si diffonde oggi, in realtà, nasconde altro. Assistiamo allo spettacolo dell’affluenza privata e dello squallore pubblico. Avvertiamo che i legami sociali si indeboliscono e sappiamo che solo questi legami possono contribuire, almeno parzialmente, a ostacolare gli appetiti individuali
migranti e richiedenti asilo. D’altro canto, con la crescente interdipendenza tra paesi e popoli, e con la coabitazione ‘coatta’ tra questi ultimi, la presenza dell’altro si rende visibile e finisce per creare insicurezza. Ecco un paradosso. L’insicurezza creata dai mercati riguarda tutti, o per lo meno le maggioranze, in termini di paura rispetto al futuro, vulnerabilità nei confronti del datore di lavoro, impotenza verso i processi decisionali. Ma una simile paura, che Bakhtin definirebbe ‘cosmica’, rivolta com’è a un potere inafferrabile e debordante, viene tradotta in sgomento indirizzato a minoranze visibili. Se lo Stato non può più difenderci dall’economnia, se non è più in grado di guidarla ma solo di obberdirle, allora dovrà difenderci da altre fonti di insicurezza. A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Il populismo non aspira al sostegno dell’opinione pubblica in generale, ma solo di quel settore della società che si crede sfavorito e danneggiato dalla presenza e dalle attività di altri gruppi. Questi ultimi, ritenuti immeritevoli di quanto posseggono, vengono indicati come responsabli dell’emarginazione di chi non vuole far altro che condurre un’esistenza ordinaria e silenziosa. Michael Howard, ministro britannico conservatore, in una dichiarazione rilasciata nel 1993, espresse con chiarezza questo pensiero: la maggioranza silenziosa è diventata rumorosa, perché il sistema della giustizia criminale fa ormai troppo per i criminali e troppo poco per la protezione del pubblico. Secondo una definizione comune, sono populisti i politici che concepiscono politiche penali punitive le quali sembrano rispecchiare gli umori popolari. Il populismo penale che si diffonde oggi, in realtà, nasconde altro. Assistiamo allo spettacolo dell’affluenza privata e dello squallore pubblico. Avvertiamo che i legami sociali si indeboliscono e sappiamo che solo questi legami possono contribuire, almeno parzialmente, a ostacolare gli appetiti individuali  eccessivi. La paura dell’altro, in questo contesto, è paura del tipo di sistema che abbiamo creato, è consapevolezza che sappiamo rispondere al crimine, ma non siamo in grado di rispondere alle sue cause. In una situazione di ineguaglianza crescente, con una polarizzazione della ricchezza che torna a livelli ottocenteschi, si teme che il crimine sia destinato a diffondersi e ad assumere i connotati della disperazione. Si teme l’ineguaglianza, non il crimine. Il populismo penale, infine, può avere una propria funzione latente. Se la severità penale, nei primi decenni della rivoluzione industriale, intendeva disciplinare le orde di spossessati al lavoro di fabbrica, nell’epoca corrente una simile severità può educare chi conduce vita precaria ad accettare la propria insicurezza e interiorizzare il proprio scarso valore sociale e umano. La pena, allora, contribuirà alla riduzione delle aspettative, convincendo chi ne è colpito della propria inutilità. Il populismo penale, in breve, è il compagno ideale della crescita economica, basata spesso sulla produzione dell’inutile che rende alcuni gruppi di esseri umani inutili. Ho detto in apertura che, nell’esaminare i paesi individualmente, si notano differenze non secondarie. Guardando all’Italia, ad esempio, credo che il populismo penale si avvalga di uno sfondo culturale e politico davvero singolare. Con una vita pubblica ormai priva di qualsiasi missione etica, e un’élite che moltiplica le manifestazioni della propria illegalità, il populismo non è il trasferimento in politica del risentimento popolare o delle intuizioni che vengono dalla strada, ma è l’insulto, l’aggressione, la depredazione che alcuni temono di poter subire per strada.
eccessivi. La paura dell’altro, in questo contesto, è paura del tipo di sistema che abbiamo creato, è consapevolezza che sappiamo rispondere al crimine, ma non siamo in grado di rispondere alle sue cause. In una situazione di ineguaglianza crescente, con una polarizzazione della ricchezza che torna a livelli ottocenteschi, si teme che il crimine sia destinato a diffondersi e ad assumere i connotati della disperazione. Si teme l’ineguaglianza, non il crimine. Il populismo penale, infine, può avere una propria funzione latente. Se la severità penale, nei primi decenni della rivoluzione industriale, intendeva disciplinare le orde di spossessati al lavoro di fabbrica, nell’epoca corrente una simile severità può educare chi conduce vita precaria ad accettare la propria insicurezza e interiorizzare il proprio scarso valore sociale e umano. La pena, allora, contribuirà alla riduzione delle aspettative, convincendo chi ne è colpito della propria inutilità. Il populismo penale, in breve, è il compagno ideale della crescita economica, basata spesso sulla produzione dell’inutile che rende alcuni gruppi di esseri umani inutili. Ho detto in apertura che, nell’esaminare i paesi individualmente, si notano differenze non secondarie. Guardando all’Italia, ad esempio, credo che il populismo penale si avvalga di uno sfondo culturale e politico davvero singolare. Con una vita pubblica ormai priva di qualsiasi missione etica, e un’élite che moltiplica le manifestazioni della propria illegalità, il populismo non è il trasferimento in politica del risentimento popolare o delle intuizioni che vengono dalla strada, ma è l’insulto, l’aggressione, la depredazione che alcuni temono di poter subire per strada.