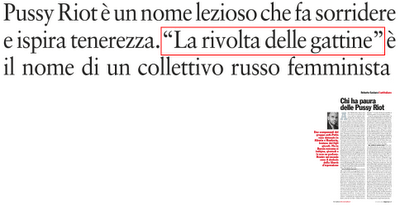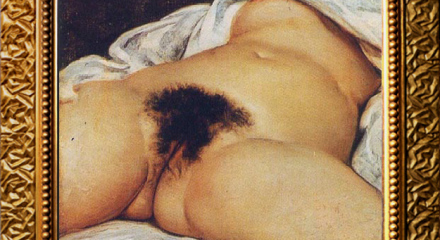«In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi», disse una volta Sandro Pertini, Presidente della Repubblica. Il vecchio Pertini, ormai un po’ troppo in avanti con gli anni (in un discorso di fine anno confuse la dittatura militare guatemalteca con il Nicaragua insorto; il giorno dopo la retata del 7 aprile 1979 inviò un telegramma al pm Calogero – alla faccia della separazione dei poteri – per complimentarsi della sua inchiesta-teorema su una fantomatica cupola insurrezionale e degli arresti del giorno prima, più o meno lo stesso stile del suo acerrimo nemico di un tempo, il Duce Benito Mussolini), era in buona fede quando pronunciò queste incaute parole. Non mentiva con se stesso, semplicemente non vedeva, non voleva vedere, non poteva più vedere, troppo lontana nel tempo era la sua cella sull’isola-carcere di santo Stefano e la condanna inferta dal Tribunale speciale.
La lotta armata e la sovversione sociale in Italia vennero sconfitti dai mutamenti produttivi, dalla rivoluzione neoconservatrice che lentamente prosciugarono le basi sociali della rivolta, ma è vero che nel corso di quella guerra civile vennero inferti duri colpi non «negli spogliatoi degli stadi», aveva ragione Pertini, ma in un villino, un residence tra Cisano e Bardolino, vicino al lago di Garda di proprietà di un parente di un poliziotto (lo racconta l’ex ispettore capo della Digos di Verona, Giordano Fainelli e lo conferma anche Salvatore Genova, commissario Digos), oppure all’ultimo piano della questura di Verona, requisita dalla struttura speciale coordinata da Umberto Improta, diretta da Gaspare De Francisci, a cui partecipavano Salvatore Genova, Oscar Fioriolli, De Gregorio e Nicola Ciocia, o ancora in altre caserme d’Italia, quella della Celere di Padova (Cesare Di Lenardo parla di un locale dove c’erano delle docce). Anche Enrico Triaca, prelevato dalla caserma di Castro pretorio, accanto alla stazione Termini di Roma, arriva bendato in un posto dove c’era sicuramente un cancello metallico con apertura automatica. Probabilmente anche questa una caserma, situata forse in cima ad una salita, ancora in città o nelle immediate vicinanze.
Non erano stadi ma erano caserme, come la famigerata Esma argentina, la scuola meccanica della marina dove vennero torturati ed uccisi centinania di militanti di sinistra e oppositori della giunta militare.
Enrico Triaca ha deciso di bussare alle porte del Quirinale, inviando una lettera aperta al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano «perché convinto che questa storia non è, e non può essere, solo, storia giudiziaria, se è vero, quel che ci dicono gli ex funzionari, questa volta non si può licenziare la cosa con frasi tipo: parti deviate dello Stato, mele marce o schegge impazzite. Questa volta è lo Stato tutto ad essere coinvolto, la Politica che ordinò le torture, i “bravi” tutori dell’ordine che le eseguirono, la magistratura che li assolse, i media che li coprirono».
Da oltre un anno sono emersi sui media e in un libro fatti nuovi, circostanze, testimonianze, amissioni, rivelazioni. Che farà Napolitano? Vorrà ribadire ancora una volta che «In Italia abbiamo sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi»?
Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
di Enrico Triaca
 Esimio Presidente, scrivo a Lei in quanto Presidente della Repubblica, Capo della Magistratura e uomo politico che ha attraversato l’intera Storia, fino ad oggi, della Repubblica italiana.
Esimio Presidente, scrivo a Lei in quanto Presidente della Repubblica, Capo della Magistratura e uomo politico che ha attraversato l’intera Storia, fino ad oggi, della Repubblica italiana.
E’ certamente per Lei una degna chiusura di carriera la presidenza quirinalizia, come immagino qualsiasi politico agogni per se stesso, anche se, lavoro faticoso, specie in questo inizio di Secolo, in cui decisioni forti sono state prese, come il dover imporre un Professore alla guida del Paese per risolvere i problemi che ci angustiano.
E a ben vedere non è la prima volta che l’Italia si affida a “Professori” per risolvere i propri problemi, già negli anni 70/80 lo Stato fece ricorso ad un “Professore”, in questo caso, al famigerato “Professor de Tormentis” ovvero un ex funzionario di Stato, dell’UCIGOS, così soprannominato dai suoi colleghi e amici. Tale “Professore” ha di recente dichiarato, ma in realtà ci sono anche le testimonianze dell’ex commissario Salvatore Genova, di aver praticato la tortura contro prigionieri politici di quegli anni. Si è vantato (dietro anonimato) di essere lui il torturatore di Stato, il professionista della Tortura, che veniva inviato nelle varie questure italiane quando si ritenevano necessari i “servigi” suoi, e dei suoi collaboratori.
Da tali confessioni e testimonianze si evince che questo personaggio ha goduto della protezione e copertura della Politica, e non solo.
Tale personaggio, che oggi sappiamo chiamarsi Nicola Ciocia, ha confessato di avermi torturato; torture che io denunciai di aver subito nel 1978 e per la cui denuncia fui, oltretutto, condannato per calunnia.
Oggi chiedo la revisione di quella condanna, perché la verità venga ristabilita, ma visto il silenzio, POLITICO, che sta accompagnato questa vicenda dopo che stampa e televisione ne hanno denunciato l’avvenimento, non nutro molta speranza nell’esito positivo di questa storia. Pur tuttavia, è una strada che sento di dover percorrere, anche perché ci sono personaggi, coinvolti, o che quanto meno sanno, che ancora oggi ricoprono ruoli Istituzionali, e per contro ci sono ancora prigionieri che sono in carcere dopo 30 anni, dopo aver subito torture dallo Stato che Lei, magnificamente, oggi rappresenta.
Scrivo a Lei, Presidente, perché convinto che questa storia non è, e non può essere, solo, storia giudiziaria, se è vero, quel che ci dicono gli ex funzionari, questa volta non si può licenziare la cosa con frasi tipo: parti deviate dello Stato, mele marce o schegge impazzite. Questa volta è lo Stato tutto ad essere coinvolto, la politica che ordinò le torture, i “bravi” tutori dell’ordine che le eseguirono, la magistratura che li assolse, i media che li coprirono. E capisco anche le difficoltà alle quali dovete far fronte, per 30 anni avete raccontato al popolo di aver vinto usando, solo, i mezzi e gli strumenti che la legge e la Costituzione vi consentivano, ma è proprio in questi frangenti che si misura la DIGNITA’ e AUTOREVOLEZZA di una persona, di uno STATO.
Lei oltre ad essere l’attuale Presidente della Repubblica è stato, anche, un membro autorevole del Pci, Ministro dell’ Interno e Presidente della Camera, sarebbe quindi logico e coerente un suo intervento; trovo paradossale che in una Società civile, uno Stato di diritto, come si pretende l’Italia, la società civile si interroghi su questi fatti, di cui non serve sottolineare la gravità, mentre la politica e quindi Lei, che ne rappresenta la massima espressione, taccia; la gravità Presidente non risiede solo nel fatto che dei prigionieri 30 anni fa venivano torturati in questo paese, ma nel fatto che tali pratiche si sono succedute nel tempo; ancora oggi ragazzi vengono massacrati e uccisi nelle caserme, questure, carceri e sui marciapiedi.
Lei poco tempo fa ebbe a dire che “i processi celebrati in quegli anni sono stati processi svolti in uno Stato di Diritto” sottintendendo, così almeno io l’ho letto, processi giusti, equi, ebbene io un dubbio ce lo avrei e credo che anche a Lei dovrebbe venirle leggendo queste righe, ed a maggior ragione, leggendo le confessioni di Nicola Ciocia e Salvatore Genova, ex funzionari di Stato e non “terroristi”.
Signor Presidente, le trascrivo un articolo, sul processo per calunnia ai miei danni, di quello che fu l’organo di informazione del suo partito, il Pci, L’Unità dell’8 novembre 1978: «L’avvocato Alfonso Cascone ha invece avanzato apertamente il sospetto che le accuse di Triaca alla polizia fossero false e che il suo assistito avesse mentito poiché – pensando di essere considerato dalle BR un delatore – temeva rappresaglie. Il reato di calunnia, ha detto quindi il legale, sarebbe stato compiuto in “stato di necessità”. Nonostante i dubbi suscitati dal comportamento della polizia durante il processo, dunque, uno scorcio di verità è arrivata inaspettatamente proprio da uno dei difensori del tipografo delle BR».
L’avvocato Alfonso Cascone presentò una denuncia contro il giornale che venne, immediatamente, archiviata.
Anche l’attuale Esecutivo è stato investito della questione con una interpellanza parlamentare, ma la risposta è stata elusiva e fuorviante, oltretutto affidata ad un personaggio, ironia della sorte, il cui nome era già, comunque, apparso nella vicenda che mi riguarda.
Ogni volta che una vetrina viene danneggiata in un corteo, politici, magistrati, sindacalisti, opinionisti, intellettuali, si lanciano nella ricerca della frase più di condanna più brillante: fiumi di inchiostro invadono le colonne dei giornali per giorni, per contro solo trafiletti quando ad usare la violenza è un corpo o lo Stato tutto; e la differenza si nota Signor Presidente e rende risibile qualsiasi frase ad effetto pronunciata contro la violenza.
E di frasi “IMPEGNATIVE” ne sono state pronunciate tante, ne riporto solo due:
“Alcuna ragione di Stato può giustificare ritardi nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità, l’unica ragione di Stato è la verità” Mario Monti, Presidente del Consiglio (23 maggio 2012) Parole riprese e confermate da Anna Maria Cancellieri, Ministro degli Interni. Con riferimento all’attentato alla scuola di Brindisi.
“Non ci sono ragioni di dissenso politico e tensione sociale che possano giustificare ribellismi, illegalismi, forme di ricorso alla forza destinate a sfociare in atti di terrorismo”.
Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica (09 maggio 2012). In occasione della giornata della memoria delle vittime del terrorismo.
Restando a sua disposizione per ogni eventuale altro chiarimento le invio i miei più Cordiali Saluti.
Enrico Triaca
Per chi vuole approfondire
Torturartori che siedono ancora sulle poltrone del Viminale
L’ordine dall’alto: 8 gennaio 1982, quando il governo Spadolini autorizzò il ricorso alla tortura
Il brigatista torturato vuole sapere tutto sulla squadra speciale guidata da Nicola Ciocia che praticava il waterboarding
Ciocia-De Tormentis: “Torturavo per il bene dell’Italia”
Chi è “Tormentis”?
Condannato per calunnia dopo-aver-denunciato le torture, Triaca chiede la revisione del-processo
Enrico Triaca denunciò le torture ma fu condannato per calunnia. In un libro il torturatore Nicola Ciocia-alias De Tormentis rivela “Era tutto vero”. Parte la richiesta di revisione
Triaca: “De Tormentis mi ha torturato così”
Triaca: dopo la tortura l’inferno del carcere/ seconda parte
Che delusione professore! Una lettera di Enrico Triaca a Nicola Ciocia-professor De Tormentis
Processo verso la revisione per il tipografo Br torturato