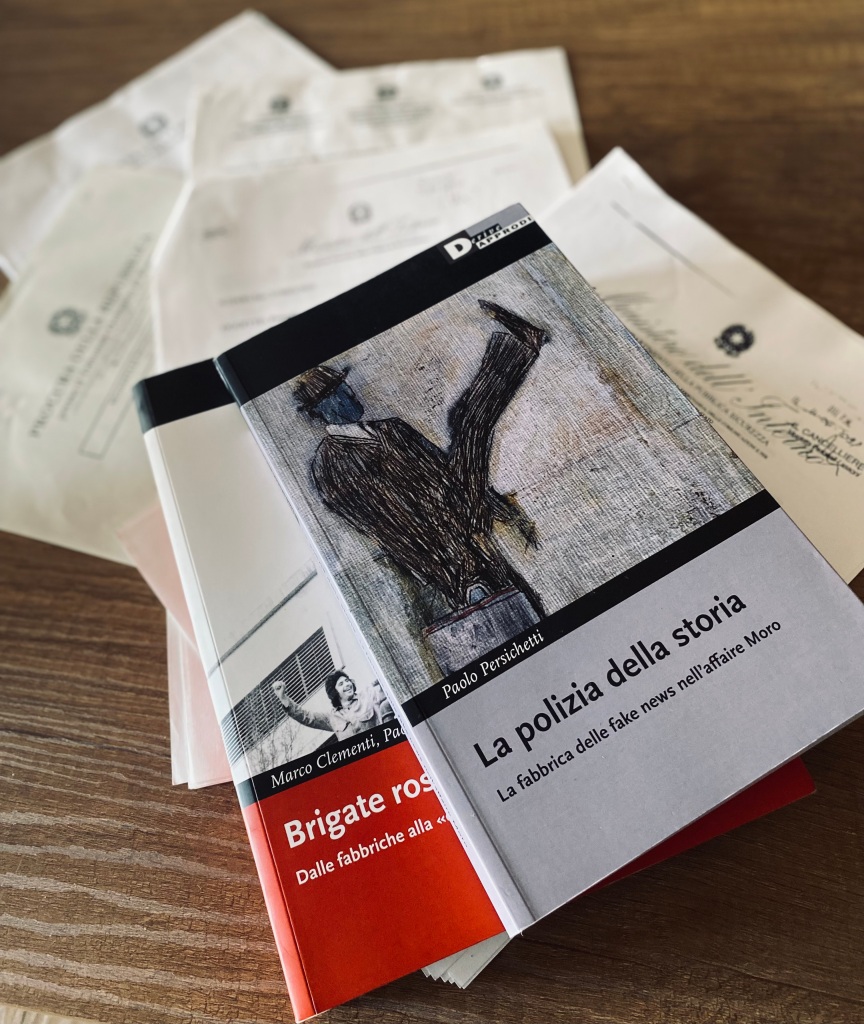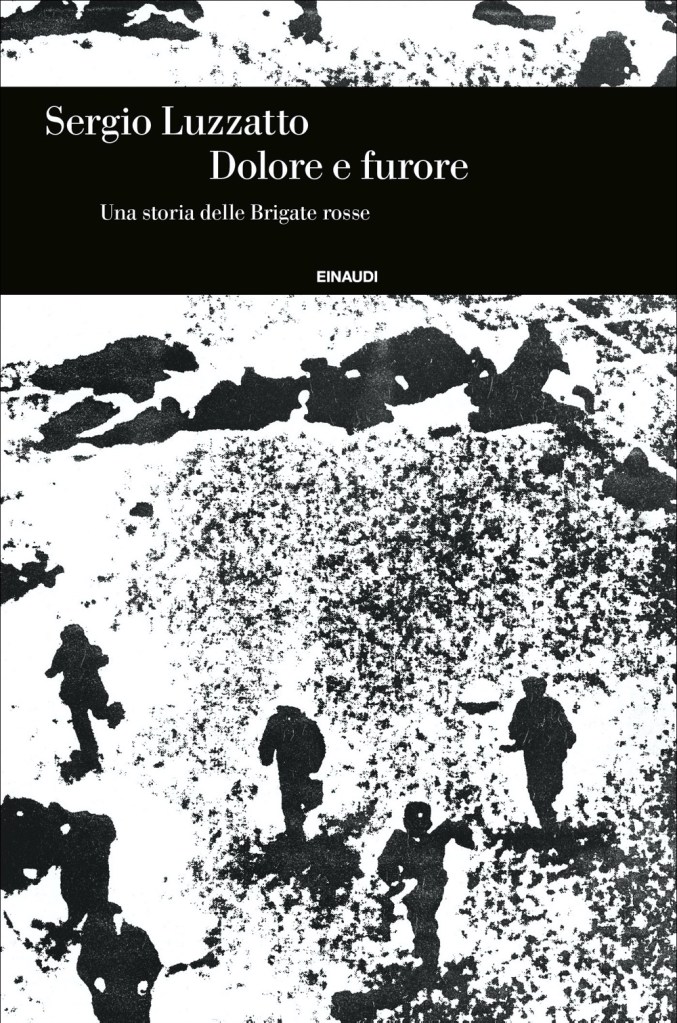Agli occhi del generale Dalla Chiesa la città di Genova appariva la capitale del brigatismo italiano. Lì era avvenuto, nel 1974, il primo rapimento politico di caratura nazionale col sequestro del pm Mario Sossi e poi, nel 1976, il primo omicidio politico brigatista, l’uccisione del procuratore generale Francesco Coco, infine il primo grande sequestro per autofinanziamento nei confronti dell’armatore Pietro Costa nel 1977.
Per Dalla Chiesa le bierre genovesi erano diventate una ossessione. L’arresto nel 1976 dell’operaio dell’Ansaldo Giuliano Naria, nella lontana Valle D’Aosta, e poi quello in Italsider di Francesco Berardi, denunciato dal sindacalista della Cgil Guido Rossa, non avevano scalfito i cinque lunghi anni di impenetrabilità della organizzazione. Dalla Chiesa non poteva ancora sapere che Sossi era stato rapito da un gruppo composto da brigatisti milanesi e torinesi venuti da fuori e che sotto la lanterna le Br erano arrivate dopo, in pieno 1975.
A Milano, Torino e in Veneto i carabinieri avevano realizzato brillanti operazioni, scoperto basi, arresto militanti. A Genova nulla. Tutto ciò aveva alimentato una leggenda che deformava la percezione reale dei fatti.
Era necessario portare a termine una brillante operazione anche qui. L’occasione si presentò nel maggio del 1979 quando venne realizzata una retata con l’arresto di 15 persone accusate di appartenere alle bierre genovesi. Oggi sappiamo che di quel gruppo solo un paio aveva reali contatti con le Brigate rosse del posto. Gli altri non c’entravano nulla.
In questo articolo Pino Narducci col piglio del giurista ma anche dello storico ricostruisce la storia di questa clamorosa e vergognosa montatura costruita a tavolino da alcuni funzionari dei Servizi che si servirono di due testimoni d’accusa, soggetti labili e manipolabili, attraverso un intermediario, tale Mezzani il cui nome era già apparso nei comunicati resi pubblici dalle Br durante il sequestro Sossi, materiale poi consegnato a Dalla Chiesa che per ragioni politiche e d’immagine diede seguito all’operazione.
Emergono così i metodi opachi e privi di scrupoli impiegati dal generale e dai suoi nuclei, in particolare quello genovese i cui componenti, dal capitano Riccio al maresciallo Segatel, ritroveremo coinvolti negli anni successivi in storie torbide (narcotraffico, raffinerie e depistaggi nella strage di Bologna). Metodi che si confermeranno l’anno successivo in via Fracchia, con l’esecuzione dei quattro brigatisti catturati vivi e poi fucilati.
di Pino Narducci, 17 ottobre 2023
presidente della sezione riesame del Tribunale di Perugia
apparso su www.questionegiustizia.it
Alla fine degli anni ’70, la colonna genovese delle Brigate Rosse è all’apice del suo radicamento nel capoluogo ligure e della sua indiscutibile capacità militare. Ma soprattutto, se nelle grandi aree industriali del Nord, Piemonte e Lombardia, in molte circostanze, sin dai primi anni del decennio, l’organizzazione clandestina ha subito colpi anche duri, con l’arresto di dirigenti e militanti e la scoperta di basi, a Genova non ha patito e continua a non patire azioni repressive e gli inquirenti, di fatto, non conoscono praticamente nulla del gruppo che opera nel capoluogo ligure.
Nella valutazione di un ex dirigente nazionale della organizzazione, in quel momento storico la colonna genovese è la più prestigiosa, forse anche più della “storica” colonna torinese.
Il 25 ottobre ’78, Francesco Berardi, operaio Italsider e militante brigatista, viene individuato subito dopo aver collocato volantini BR all’interno dello stabilimento in cui lavora. Nel corso del processo per direttissima, che si celebra il 31 ottobre, testimonia contro di lui anche l’operaio Guido Rossa, militante del PCI e della CGIL, membro del Consiglio di fabbrica, l’uomo che l’ha denunciato e che ha permesso il suo arresto.
Condannato ad oltre quattro anni di reclusione, Berardi, avvicinato da alcuni ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, si lascia andare a confidenze sulla persona che l’ha reclutato e dalla quale ha ricevuto incarico di distribuire il materiale propagandistico. Gli mostrano, informalmente, una foto e la riconosce.
È Enrico Fenzi, professore di letteratura italiana nell’Università di Genova. Questa è l’unica informazione che Berardi, sia pure senza aver mai firmato un verbale, fornisce ai due ufficiali che lo incontrano. Non molto, ancora, per provare a scompaginare la colonna genovese.
Ma i carabinieri del generale Dalla Chiesa hanno altri assi nella manica, di portata superiore all’operaio dell’Italsider il cui patrimonio di conoscenze, probabilmente, è davvero limitato e che non ha nemmeno intenzione di fornire quelle scarne informazioni attraverso un vero e proprio interrogatorio.
L’omicidio di Guido Rossa ad opera dei brigatisti, il 24 gennaio 1979, impone agli investigatori di imprimere uno slancio ulteriore all’indagine.
Due ragazze genovesi, Susanna Chiarantano e Patrizia Clemente, studentesse della facoltà di Lettere, permettono così ai carabinieri, finalmente, di squarciare il velo di impenetrabilità che avvolge l’organizzazione che ha ucciso Rossa e di individuare molti suoi componenti, alcuni anche di spicco.
Susanna Chiarantano ha frequentato Lotta Continua ed altri ambienti della sinistra extraparlamentare, se ne è allontanata e poi è tornata sui suoi passi, registrando però una forte diffidenza nei suoi confronti perché ha un rapporto di lavoro con Enrico Mezzani, conosciuto come ex fascista e confidente delle forze di polizia. Per questa ragione la ragazza, così lei sostiene, viene sottoposta a una sorta di “processo politico” per valutare la sua richiesta di rientrare nel gruppo della sinistra estrema. Le persone che la processano si qualificano come membri delle Brigate Rosse e la ragazza, a questo punto, li accusa e rivela i loro nomi.
Patrizia Clemente ha militato in Lotta Continua e poi in Autonomia Operaia e può raccontare episodi vissuti in prima persona che dimostrano come nell’area dell’autonomia si è verificata una frattura ed alcuni esponenti, come Giorgio Moroni, hanno già scelto la strada della lotta armata e, di fatto, già agiscono nella colonna BR(1).
L’Ufficio per il Coordinamento e la Cooperazione nella lotta al terrorismo, organo alla cui guida è stato posto il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, elabora il rapporto giudiziario che arriva sul tavolo della procura genovese il 9 maggio ‘79. Dopo appena dieci giorni, i carabinieri eseguono, il 17 maggio, i mandati di cattura emessi dal giudice istruttore contro quindici persone accusate di far parte della banda armata Brigate Rosse.
Entrano in carcere, tra gli altri, Enrico Fenzi, la sua compagna, Isabella Ravazzi, Giorgio Moroni, uno degli esponenti più noti dell’Autonomia operaia genovese, e gli insegnanti Luigi Grasso e Mauro Guatelli. Nei giorni successivi, altri mandati di cattura permettono di arrestare altri due insegnanti, un operaio ed un giovane laureato in sociologia.
Il quotidiano “L’Unità”, organo del PCI, all’indomani della operazione giudiziaria, titola: «Operazione anti BR a Genova. Sette arresti, una decina di fermi».
Tutti gli organi di informazioni esaltano la prima azione repressiva contro la colonna, quella di Genova, che, sino a quel momento, si è rivelata una sorta di fortino inespugnabile.
Alcuni mesi dopo, il generale Dalla Chiesa, in una relazione riservata al Ministro dell’Interno Virginio Rognoni, così descrive l’operazione portata a termine alcune settimane prima: «…militari dei reparti speciali dei carabinieri per la lotta al terrorismo, al termine di un’indagine difficile e complessa, protrattasi per oltre otto mesi, diretta a individuare, localizzare e disarticolare la colonna eversiva clandestina delle BR operante in Liguria, acquisiscono elementi di prova inconfutabili a carico di molti dei suoi componenti».
Nei mandati di cattura non compaiono i nomi di Francesco Berardi e delle due studentesse perché il rigido segreto istruttorio del codice processuale del ’30 tutela il lavoro degli inquirenti e gli indiziati, durante l’istruttoria, non sono messi nella condizione di conoscere l’identità delle persone da cui proviene la pesante accusa di essere membri delle BR.
In assenza di informazioni ufficiali, si rincorrono le voci più disparate, puntualmente riprese dagli organi di informazione: gli inquirenti hanno a disposizione un «infiltrato alla Girotto» oppure l’omicidio di Guido Rossa ha prodotto «crisi di coscienza» che hanno aperto varchi nella organizzazione clandestina.
Il 24 ottobre ’79, Francesco Berardi si toglie la vita nel carcere di Cuneo.
Nel novembre ’79, il giudice istruttore rinvia a giudizio quattordici persone per i reati di banda armata ed associazione sovversiva. Quattro imputati sono prosciolti.
Il disvelamento dei nomi di Susanna Chiarantano e Patrizia Clemente lascia sgomento il multiforme ambiente politico (autonomi, anarchici, lottacontinuisti, comunisti marxisti-leninisti ecc.) dal quale provengono gli arrestati.
Se il nome della Clemente è conosciuto soprattutto come quello di persona che vive una sofferta esperienza di dipendenza dall’eroina, quello della Chiarantano si rivela, da subito, particolarmente inquietante.
La sinistra estrema genovese conosce i legami della donna con Enrico Mezzani, pregiudicato per reati comuni e notoriamente considerato un confidente delle forze di polizia, ma soprattutto è ritenuta a tal punto inaffidabile da essere accusata, alternativamente, di essere lei stessa una spia al servizio di servizi segreti greci sin dai primi anni ’70 o un fiduciario dei servizi segreti italiani con il nome di copertura “Camilla”.
Tuttavia, l’operazione giudiziaria del maggio ’79 non sembra aver scalfito più di tanto la solidità e le capacità della organizzazione clandestina radicata nel capoluogo ligure.
Il 21 novembre 1979, i brigatisti genovesi uccidono il maresciallo Vittorio Battaglini e il carabiniere Mario Tosa, sorpresi all’interno di un bar a Sampierdarena(2).
Poi addirittura, a dicembre, scelgono Genova per svolgervi una riunione della Direzione Strategica, riunione convocata con urgenza perché il nucleo storico della organizzazione che si trova recluso a Palmi (Curcio, Franceschini ed altri) chiede le dimissioni del Comitato Esecutivo.
All’incontro, che si tiene nell’appartamento di proprietà di Annamaria Ludmann in via Fracchia 12, nel quartiere Oregina, partecipano quindici persone, delle quali ben dodici arrivano a Genova da varie città italiane.
Nella imminenza del processo di primo grado contro Enrico Fenzi e gli altri imputati, le Brigate Rosse non sembrano particolarmente preoccupate per l’attività di indagine iniziata nel mese di maggio. Evidentemente considerano Genova una roccaforte e non esitano a farvi convergere tutto il gruppo dirigente nazionale della organizzazione.
Nella notte tra il 27 e il 28 marzo ’80, sulle base delle rivelazioni fatte da Patrizio Peci nel carcere di Cuneo, i carabinieri fanno irruzione nell’appartamento di via Fracchia(3). Il maresciallo Rinaldo Benà resta ferito gravemente ad un occhio mentre perdono la vita il capo della colonna genovese, Riccardo Dura, gli operai torinesi Lorenzo Betassa e Piero Panciarelli e la militante irregolare Annamaria Ludmann.
Tuttavia, la scoperta della base più importante della colonna genovese ed il sequestro di una ingentissima documentazione non permettono ai carabinieri di acquisire altre prove a carico delle persone detenute ormai già da dieci mesi(4).
Il processo inizia lunedì 14 aprile 1980, davanti la Corte di Assise di Genova.
Il giorno successivo, il giornalista Gad Lerner pubblica un articolo che contiene una lunghissima intervista a Susanna Chiarantano(5). La donna rivela i retroscena della sua collaborazione con i carabinieri. È stata intimidita/irretita/plagiata da Enrico Mezzani, confidente della Guardia di Finanza e collaboratore del capo dell’ufficio politico della Questura, Umberto Catalano(6). È stato Mezzani ad istigarla ed a suggerirle di rivelare al capitano dei carabinieri Gustavo Pignero, da lei incontrato tre volte prima degli arresti, informazioni non vere su Grasso e altri, informazioni false, sostiene la donna, perché a lei non risulta che queste persone facciano parte delle BR. Racconta ancora che, il 17 maggio ’79, mentre venivano eseguiti i mandati di cattura, prelevata da casa, era stata condotta nella caserma di Via Moresco dove aveva incontrato il capitano Riccio e il maresciallo Mumolo che avevano con lei riletto tutti i fatti esposti nei rapporti giudiziari. Dopo una estenuante attesa di molte ore, già prostrata, era stata interrogata dal magistrato avendo già deciso che avrebbe confermato qualsiasi circostanza, anche quelle false, pur di allontanarsi da quel luogo. Dopo gli arresti, il capitano Pignero le aveva detto che, per lei, erano pronti il passaporto ed una somma di denaro sino a 100 milioni di lire. Aveva però rifiutato l’offerta ed aveva redatto un memoriale sulla vicenda depositato in una cassetta di sicurezza di una banca. Sapeva che le persone da lei accusate non facevano parte della colonna genovese BR, ma, in quel momento, più che ritorsioni da parte degli ex compagni di militanza aveva paura dei carabinieri. Commentando la storia raccontata dalla donna, Lerner ritiene che è stata messa in piedi “una montatura” decisa nella convinzione secondo la quale nell’ambiente della sinistra estrema c’è del marcio ed un blitz può farlo venire fuori.
Quattro giorni dopo, avviene un episodio drammatico che si ripercuote immediatamente sugli imputati che hanno scelto di affidare la propria difesa al noto penalista genovese Edoardo Arnaldi.
La magistratura torinese, dopo aver raccolto le dichiarazioni di Patrizio Peci, emette mandati di cattura contro alcuni avvocati penalisti membri della associazione “Soccorso Rosso” ed impegnati nella difesa di militanti delle Brigate Rosse. Sono accusati di aver travalicato il proprio mandato di difensori e di essere, in realtà, il tramite che permette il costante collegamento tra militanti arrestati/detenuti ed organizzazione(7).
Quando i carabinieri, il 19 aprile ’80, si presentano nella abitazione di Arnaldi per eseguire il suo arresto, il legale si toglie la vita con una pistola che possiede legalmente.
I giudici della Corte di Assise di Genova non hanno la possibilità di interrogare direttamente le due principali testimoni di accusa che non si presentano per deporre. Anzi, Patrizia Clemente ha fatto perdere le sue tracce ed è diventata irreperibile.
L’istruttoria si chiude rapidamente ed il 3 giugno 1980 il Presidente del Collegio legge il clamoroso ed inaspettato dispositivo della sentenza: tutti gli imputati sono assolti con formula piena.
I giudizi contenuti nella sentenza che demolisce l’indagine sono impietosi e lapidari: «…sarebbe illogico ed arbitrario affidarsi alle dichiarazioni di Pignero e Paniconi…», cioè gli ufficiali dei carabinieri ai quali Berardi fece confidenze su Fenzi che non vennero verbalizzate(8); le dichiarazioni della Chiarantano – rese informalmente al capitano Pignero, da questo riferite al colonello Bozzo e, infine, solo parzialmente confermate dalla donna nell’unico interrogatorio reso al Giudice istruttore del 17 maggio 1979, cioè lo stesso giorno in cui vennero eseguiti gli arresti – sono «indegne di fede» in quanto «tutti i riferimenti alle BR attribuiti agli imputati dalla Chiarantano sono soltanto il parto della sua mente, probabilmente influenzata e ed esaltata dallo stesso compito assegnatole inopinatamente dalla polizia giudiziaria»; le accuse rivolte da Patrizia Clemente a Giorgio Moroni «sono infondate», la donna non si è resa disponibile a comparire personalmente davanti alla Corte per spiegare le molte contraddizioni del suo racconto ed i giudici ritengono, alla fine del processo, che «le sue accuse non siano altro che il frutto di ingiustificate supposizioni».
Nel giro di 48 ore dalla lettura del dispositivo, il 5 giugno ’80, da Milano, arriva la risposta del generale Dalla Chiesa. Alla commemorazione del 166° anniversario dell’Arma, attacca frontalmente i magistrati genovesi: «…non passerà la prepotenza, non passerà la follia, non passerà il terrorismo né l’ingiustizia che lo assolve».
La pubblica accusa impugna la sentenza di assoluzione e, mentre la città è in attesa che si celebri il processo di secondo grado, un altro giudice inizia ad occuparsi della vicenda.
È il Pretore di Genova al quale prima Vincenzo Masini (prosciolto in istruttoria dal giudice istruttore) e poi Giorgio Moroni si rivolgono presentando una denuncia contro Patrizia Clemente per il reato di falsa testimonianza.
Il Pretore, che ascolta anche Enrico Mezzani, il 19 ottobre 1981, condanna l’imputata per aver reso falsa testimonianza nei confronti di Masini. Quanto alla denuncia di Moroni, assolve la donna per insufficienza di prove, ma ritiene, comunque, provato che Patrizia Clemente, che ha seri problemi di tossicodipendenza, ha reso la sua deposizione in circostanze anomale (nella sua abitazione, e non in una caserma o in un ufficio giudiziario, il giorno dopo aver affrontato un aborto), che Mezzani aveva esercitato una influenza sulla donna per farle rendere dichiarazioni «non assolutamente limpide» e che la donna, emigrata in Australia, era stata fatta rientrare in Italia per sostenere un interrogatorio davanti al giudice istruttore con un viaggio quasi certamente pagato dai carabinieri.
Nell’autunno 1980, decine di arresti colpiscono duramente la colonna genovese delle BR e molti militanti fuggono da Genova. Alcuni, esponenti di rilievo della colonna, come Livio Baistrocchi e Lorenzo Carpi, non saranno mai più trovati.
La strada tracciata da Patrizio Peci a Torino viene seguita anche da molti militanti genovesi che, arrestati, decidono di dissociarsi o di collaborare con la magistratura.
Il 4 aprile 1981, a Milano, i poliziotti arrestano Mario Moretti ed Enrico Fenzi(9). A questo punto, le univoche circostanze della cattura “inchiodano” il professore genovese all’accusa di essere un militante brigatista.
Nel processo di secondo grado, che inizia nel novembre ‘81, i giudici della Corte di Assise di Appello ascoltano anche i militanti dissociati/collaboratori di giustizia. Ma se la mole delle dichiarazioni degli ex brigatisti disvela alla magistratura genovese la vera struttura della organizzazione e l’identità dei suoi componenti, nessun dissociato/collaboratore fornisce informazioni sugli arrestati, salvo quelle che riguardano Enrico Fenzi ed altri due imputati.
La Corte di Assise di Appello, ritiene attendibili le accuse di Susanna Chiarantano e Patrizia Clemente, rovescia la sentenza di assoluzione di primo grado e, nel febbraio ‘82, condanna otto imputati (tra cui Fenzi, Ravazzi, Moroni, Grasso e Guatelli) per il reato di associazione sovversiva. Gli altri sei imputati vengono assolti.
Nel frattempo, nel novembre ‘81, è stata arrestata la latitante Fulvia Miglietta, nome di battaglia “Nora”, compagna di Riccardo Dura, sino alla vicenda di via Fracchia membro della direzione della colonna genovese con la responsabilità del fronte della controrivoluzione. Miglietta sceglie di collaborare con la magistratura, ma anche da lei non arriva alcuna accusa nei confronti degli imputati.
Dopo la condanna nel giudizio di appello, si avvia un tortuoso iter giudiziario che, a seguito di una pronunzia di annullamento della Corte di Cassazione, determina lo spostamento del processo da Genova alla Corte di Assise di Appello di Torino chiamata, tuttavia, solo a valutare alcune questioni di diritto. Susanna Chiarantano invia ai giudici torinesi una lettera nella quale conferma la ritrattazione delle accuse fatta nel corso dell’intervista resa a Gad Lerner. Quanto ad Enrico Fenzi – che sin dal settembre ’82 ha scelto di dissociarsi dalla lotta armata e rende dichiarazioni accusando ex compagni di militanza – sostiene, nel corso del processo, che, ad eccezione di Lorenzo La Paglia, nessuno degli altri imputati è mai stato membro delle BR.
La Corte di Assise di Appello di Torino condanna sette imputati (Isabella Ravazzi viene assolta) per il più grave reato di partecipazione a banda armata.
Trascorsi oltre cinque anni dall’arresto di 19 persone nel maggio ’79, i proscioglimenti e le assoluzioni di ben dodici imputati hanno profondamente ridimensionato la portata della prima operazione contro i brigatisti genovesi.
La condanna per il reato di partecipazione a banda armata diventa definitiva solo per sette imputati
Scontata la pena definitiva, Giorgio Moroni dedica ogni propria energia alla scoperta della verità e conduce una investigazione personale alla ricerca delle due testimoni le cui accuse costituiscono il fondamento della sentenza di condanna.
Rintraccia Patrizia Clemente in Australia e la convince a raccontare la verità.
Il 14 febbraio 1991, la testimone sottoscrive una dichiarazione davanti ai funzionari del Consolato italiano a Sydney. Riconosce di aver mosso accuse false contro Giorgio Moroni e Luigi Grasso a causa delle pressioni esercitate contro di lei da Enrico Mezzani che l’aveva messa in contatto con il Capitano Riccio(10). Mezzani, che sosteneva di essere il collaboratore di un Ministro, le aveva offerto denaro se lei avesse reso dichiarazioni a carico di persone che, secondo lo stesso Mezzani, facevano parte delle BR. Pressata continuamente da Mezzani e Riccio, aveva infine ceduto alla richiesta ed aveva accusato Moroni e Grasso, imputati che lei neppure conosceva. Le dichiarazioni erano state concordate con Mezzani che, tempo dopo, era andato addirittura a scovarla in Australia perché la donna doveva assolutamente tornare a Genova per rendere una deposizione al magistrato. Lei aveva accettato a condizione che le fosse pagato il viaggio di andata e ritorno. In Italia, la donna aveva manifestato la preoccupazione di non essere in grado di individuare Moroni se fosse stata chiamata ad effettuare un riconoscimento fotografico. A quel punto, il capitano Riccio aveva consegnato alla donna una foto segnaletica di Moroni, foto che era ancora in possesso della testimone.
Giorgio Moroni, Luigi Grasso e Mauro Guatelli attivano la procedura per ottenere la revisione della sentenza definitiva di condanna.
Il 24 gennaio ‘92, nel corso di una udienza del processo di revisione, Giorgio Moroni consegna ai giudici una lettera, ancora sigillata, inviata da Sydney. Il plico contiene la foto segnaletica di Moroni che Patrizia Clemente ha gelosamente custodito per anni ed ha ritrovato tra le carte personali.
I giudici ascoltano Susanna Chiarantano. La testimone sostiene di non conoscere Guatelli e, quanto all’amico Luigi Grasso, esclude di aver mai chiesto o ricevuto informazioni sulle BR. Enrico Mezzani l’ha messa in contatto con il capitano Gustavo Pignero ed il giorno del blitz giudiziario, il 17 maggio ‘79, i carabinieri si sono presentati a casa sua, l’hanno “arrestata” e condotta in caserma. Un ufficiale in borghese la minaccia dicendo che, se non avesse firmato un verbale di accusa, non sarebbe più uscita di lì. Così, molte ore dopo, quando è arrivato il magistrato, le è stato letto un verbale che lei ha firmato perché, a quel punto, avrebbe firmato qualsiasi cosa pur di essere rilasciata. La verità, prosegue la testimone, l’ha raccontata, già molti anni prima, al giornalista Gad Lerner.
I giudici della Corte di Appello di Genova accolgono le richieste di revisione, revocano la sentenza irrevocabile di condanna ed assolvono con formula piena Giorgio Moroni, Luigi Grasso e Mauro Guatelli(11).
La vicenda giunge al suo epilogo. La verità processuale torna a coincidere con la verità storica: gli arrestati del maggio ’79, ad eccezione di quattro di essi, non sono mai stati militanti delle Brigate Rosse.
Tuttavia, le sentenze del ‘92/’93 non segnano, per intero, la fine della tormentata vicenda che, a questo punto, inizia a svilupparsi in luoghi diversi dagli uffici giudiziari.
Nel 2015/17, l’attività della Commissione parlamentare di indagine sul caso Moro arricchisce di elementi inediti la vecchia storia genovese, elementi che contribuiscono, in larga parte, a renderla ancor più intricata ed inquietante.
Ascoltando Elio Cioppa e Maurizio Navarra(12), funzionari in servizio, nel 1978/’79, presso il Centro Roma 2 del SISDE, i parlamentari apprendono che Navarra (che aveva lavorato a Genova quale ufficiale della Guardia di Finanza), appena arrivato al SISDE nell’agosto ’78, incontra un suo vecchio confidente utilizzato per indagini sul contrabbando. Il confidente si propone di aiutare Navarra poiché ha rapporti con una donna che può fornire informazioni importanti sulla colonna genovese delle BR. La fonte, raccolte queste notizie dalla donna, le fornisce subito a Navarra che, sua volta, le condivide con il capitano Riccio dei Carabinieri di Genova. Il confidente di Navarra, per l’opera prestata, riceve 2/3milioni di lire e “l’Operazione Canepa” (così era stata denominata dall’agenzia di sicurezza) è appunto quella che conduce agli arresti del 17 maggio ‘79, in particolare a quello di Enrico Fenzi, ritenuto dal servizio segreto civile capo della colonna brigatista.
Secondo Elio Cioppa, il confidente di Navarra, in cambio dell’apporto che fornisce al servizio, chiede che la Questura di Genova gli rilasci una licenza per un esercizio commerciale. Cioppa incontra più volte la donna sul lungomare Canepa di Genova (questo è il motivo del nome dato alla operazione) e raccoglie notizie su Fenzi e sulle BR genovesi. La donna (“messa nelle mani” dei carabinieri dal pregiudicato che funge da confidente di Navarra) riceve sei milioni ed annuncia che fuggirà all’estero. Cioppa redige una corposa relazione di trenta pagine (seguita da altre due relazioni) consegnata a Domenico Sica e, da quest’ ultimo, al generale Dalla Chiesa.
I due ex funzionari del SISDE rifiutano di rivelare ai parlamentari i nomi del confidente e della misteriosa donna che sa tutto delle BR genovesi, ma è evidente che si riferiscono ad Enrico Mezzani, il confidente di Navarra, ed altrettanto chiaramente ad una delle due testimoni della indagine.
Se le cose sono andate nel modo descritto da Cioppa e Navarra(13), occorre riscrivere la storia della genesi della indagine genovese, genesi sensibilmente diversa da quella raccontata nella versione ufficiale descritta in questo modo nella sentenza del 3 giugno 1980: «Con i rapporti giudiziari in atti, i Carabinieri del Nucleo operativo di Genova comunicarono che dalle indagini in corso intese all’identificazione degli assassini del Rossa erano emersi indizi i quali consentivano di ipotizzare come la persona che aveva contattato il Berardi quale postino delle BR fosse Enrico Fenzi e come variamente collegati con le BR ed altri similari organizzazioni eversive fossero Isabella Ravazzi, Luigi Grasso, Mauro Guatelli…».
In origine, quindi, già dall’agosto ’78, i contatti con Mezzani ed una delle testimoni sarebbero stati avviati e coltivati dal SISDE e non immediatamente dai carabinieri dei reparti speciali di Dalla Chiesa che, solo in un secondo momento, avrebbero “ricevuto in consegna” l’uomo e la donna dal servizio segreto interno. Se fosse vero che la testimone ricevette sei milioni dal SISDE, questo starebbe a significare che, quando rendeva dichiarazioni ai carabinieri e ai magistrati, la donna, in realtà, onorava un impegno assunto con il servizio segreto, impegno per il quale aveva chiesto ed ottenuto una ricompensa.
Non sappiamo ancora se la storia raccontata dai due funzionari dei servizi sia vera. Per certo sappiamo che, durante l’istruttoria e poi nel corso dei processi, anche quelli di revisione delle sentenze, non è mai emerso il ruolo del SISDE nella vicenda giudiziaria, ancor oggi presentata solo come il risultato del lavoro dei reparti speciali antiterrorismo diretti dal generale Dalla Chiesa.
Emerge poi un’altra circostanza inedita.
La Commissione parlamentare sul caso Moro esegue accertamenti su una audiocassetta che, ufficialmente, risulta essere stata sequestrata, il 29 maggio ’79, nell’appartamento di Giuliana Conforto, in via Giulio Cesare 47 a Roma, luogo in cui i poliziotti arrestano i latitanti Valerio Morucci e Adriana Faranda che hanno abbandonato le Brigate Rosse già da diversi mesi(14). La cassetta contiene la registrazione di un colloquio tra un uomo e una donna, avvenuto, per quello che afferma il soggetto maschile, il 2 novembre ’78.
La donna (nel colloquio chiamata con il nome in codice “Camillo”) risponde a domande su Gianfranco Faina, Luigi Grasso, Giorgio Moroni, Giuliano Naria, Sergio Adamoli ed altri. L’uomo l’avverte che sta registrando il colloquio e che il nastro sarà ascoltato da persone legate al Ministero dell’Interno. Un preciso riferimento nel dialogo ad un comunicato scritto nel ‘74 mentre è in corso il sequestro Sossi (si tratta proprio di una delle accuse rivolte inizialmente da Chiarantano a Luigi Grasso), permette al generale Paolo Scriccia, consulente della Commissione parlamentare Moro, di concludere che, molto verosimilmente, la fonte “Camillo” è, in realtà, Susanna Chiarantano(15).
La Commissione non ha scoperto l’identità dell’uomo che dialoga con “Camillo”. E’ Enrico Mezzani? Si tratta di un funzionario del SISDE? Forse è un ufficiale dei carabinieri?
Il colloquio avviene il 2 novembre ‘78, a pochissimi giorni di distanza dall’arresto e dalla condanna di Francesco Berardi e ben due mesi prima dell’omicidio di Guido Rossa. La data della registrazione e l’assenza nel colloquio di qualsiasi riferimento alle figure di Francesco Berardi ed Enrico Fenzi dimostrano che le fondamenta dell’operazione genovese del maggio ’79 vennero gettate prima delle confidenze di Berardi e ben prima dell’indagine sull’omicidio Rossa del gennaio ‘79, come sostiene invece la versione ufficiale.
Trascorsi oltre 40 anni, la ricerca della verità sulla “Operazione Canepa” è compito degli studiosi e degli storici a cui spetta ricercare nuove fonti e nuovi documenti, anzitutto quelli compilati dal SISDE che occorre, finalmente, declassificare.
Ai giuristi compete la comprensione delle vicende giudiziarie e la riflessione critica sulle indagini e sui processi che, negli anni ’70 e ’80, si celebrarono nei confronti di imputati accusati di fatti di terrorismo/eversione o che militarono nelle organizzazioni che praticarono la lotta armata.
I giudici Giuseppe Quaglia e Andrea Giordano, della Corte di Assise di Genova, esposero, nella sentenza assolutoria del 3 maggio ’80, la propria visione della giurisdizione e dei compiti del processo penale, visione non solo non datata, ma ancora straordinariamente aderente ai principi costituzionali.
Queste le loro parole: «…Compito del giudice è però quello – e soltanto quello – di accertare la sussistenza dei fatti posti a base della pretesa punitiva dedotta in giudizio e non già di seguire la cd. “logica del sospetto” nei riguardi di persone atteggiantesi, nel loro foro interno, come favorevoli all’eversione e che comunque non risulta abbiano commesso alcun fatto penalmente rilevante».
Note
(1) Una minuziosa ricostruzione della vicenda narrata in questo articolo è contenuta nel libro del giornalista Andrea Casazza sulla colonna genovese delle Brigate Rosse Gli imprendibili. Storia della colonna simbolo delle Brigate Rosse, DeriveApprodi, 2013.
(2) Rivendicando il duplice omicidio di Sampierdarena, la colonna genovese annunciava di aver assunto il nome di “Colonna Francesco Berardi”.
(3) Nel libro-intervista a Rossana Rossanda e Carla Mosca (Brigate Rosse. Una storia italiana, Mondadori, 2007), Mario Moretti riconoscerà il grave errore commesso al momento della scelta dell’appartamento della Ludmann per la riunione della Direzione Strategica. La violazione di una regola essenziale della “compartimentazione” e della segretezza delle basi della organizzazione aveva prodotto effetti catastrofici perché Peci aveva indicato ai carabinieri una abitazione/base che non avrebbe in alcun modo dovuto conoscere.
(4) Un elemento più di ogni altro dimostrativo del fatto che la colonna genovese fosse un mondo sconosciuto agli inquirenti è la storia personale di Riccardo Dura “Roberto”, membro della direzione di colonna e poi capo della stessa, componente della Direzione strategica e del Comitato esecutivo BR. Clandestino da diversi anni, al momento della sua morte non era mai stato colpito da un provvedimento giudiziario e non era ricercato dalle forze di polizia. Addirittura, i carabinieri non riuscirono ad identificarlo per diversi giorni dopo la sua morte, tanto che, il 3 aprile ‘80, un brigatista fece una telefonata all’ANSA per rivelare che il compagno “Roberto” caduto a via Fracchia era Riccardo Dura.
(5) L’articolo di Gad Lerner che contiene le rivelazioni di Susanna Chiarantano viene pubblicato in contemporanea, il 15 aprile 1980, sul giornale Lotta Continua e sul quotidiano genovese Il Lavoro.
(6) Il nome di Mezzani aveva già incrociato la storia delle Brigate Rosse molti anni prima della vicenda raccontata in questo articolo. Durante il sequestro del magistrato Mario Sossi (18 aprile-23 maggio 1974), le BR, diffondendo il comunicato n. 4, annunciarono che Sossi, collaborando con i sequestratori, aveva ammesso la macchinazione giudiziaria contro i componenti del gruppo XXII Ottobre rivelando che l’indagine era stata costruita anche grazie ad alcuni provocatori, tra i quali Mezzani. Inoltre, le BR, nel famoso comunicato n. 5 dal titolo Non trattiamo con i delinquenti, annunciarono che le informazioni fornite dal magistrato prigioniero dimostravano che l’allora capo dell’ufficio politico della Questura di Genova, Umberto Catalano, era alla testa di una organizzazione che organizzava il traffico clandestino di armi in Liguria e che il funzionario di polizia godeva della copertura del Ministro dell’Interno, il genovese Paolo Emilio Taviani.
(7) Insieme ad Arnaldi, i magistrati torinesi ordinarono l’arresto anche dell’avvocato milanese Sergio Spazzali, anche questo aderente a Soccorso Rosso Militante.
(8) I due ufficiali dell’Arma dei Carabinieri erano il Capitano Fausto Paniconi e il Capitano Gustavo Pignero. Pignero è l’ufficiale che, utilizzando l’infiltrato Silvano Girotto, aveva arrestato Renato Curcio e Alberto Franceschini, a Pinerolo, l’8 settembre 1974.
(9) L’arresto di Moretti e Fenzi fu possibile grazie alla soffiata di un pregiudicato per reati comuni, Renato Longo, che fornì informazioni alla polizia sull’appartamento di Via Cavalcanti, 4 a Milano che veniva utilizzato da Moretti.
(10) Il capitano Michele Riccio, nel 1980 comandante la 1° Sezione del Nucleo Operativo Gruppo Carabinieri Genova, fu l’ufficiale che, alla testa di un gruppo di sei uomini, fece irruzione, il 28 marzo 1980, nella base BR di via Fracchia, 12. Proprio una delle persone arrestate da Riccio nel maggio ’79, Luigi Grasso, nel 2017, sulla scorta del materiale fotografico inedito pubblicato dal giornale Il Corriere Mercantile nel 2004, chiese alla Procura di Genova di riaprire l’indagine sui fatti di via Fracchia sostenendo che Riccardo Dura non era stato ucciso nel corso del conflitto a fuoco con i carabinieri, ma era stato deliberatamente ammazzato. Il procedimento nato dall’esposto di Grasso è stato archiviato.
(11) Le sentenze di revisione sono state emesse dalla Corte di Appello di Genova, Presidente Benedetto Schiavo, rispettivamente, l’8 aprile 1992 per Moroni e il 7 aprile 1993 per Grasso e Guatelli.
(12) Elio Cioppa venne ascoltato dai membri della Commissione Moro nel corso della audizione del 2 maggio 2017. Maurizio Navarra, invece, sottoscrisse un verbale di sommarie informazioni, il 22 maggio 2017, fornendo dichiarazioni al consulente Paolo Scriccia ed all’ufficiale di collegamento Laura Tintisona. Nel corso della audizione di Elio Cioppa del maggio ’17 emerse anche che il generale Giulio Grassini, direttore del SISDE, aveva consegnato a Cioppa, con la richiesta di svolgere accertamenti, un appunto scritto a mano che conteneva i nomi di alcuni avvocati e giornalisti possibili fiancheggiatori delle BR o di altre organizzazioni. Nell’appunto (conservato agli atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2), Grassini aveva annotato i nomi degli avvocati Guiso, Spazzali e Di Giovanni, di Franco Piperno e Toni Negri, di tale «Sivieri 4° anno di fisica» (quasi certamente si tratta del brigatista Paolo Sivieri arrestato, nell’ottobre ’78, nella base di Via Montenevoso a Milano, con Bonisoli, Azzolini ed altri, poi morto suicida nel gennaio 1989) e dei giornalisti Scialoja, Tessandori, Isman e Battistini
(13) Le dichiarazioni di Navarra e Cioppa divergono, almeno in apparenza, su una circostanza importante. Mentre Cioppa sostiene di aver conversato con la testimone genovese sul lungomare Canepa, Navarra afferma di non aver mai conosciuto questa donna e di aver raccolto notizie sulle BR solo attraverso il suo confidente. Tuttavia, il nome in codice scelto dal servizio segreto civile, “Operazione Canepa”, come pacificamente riferito anche da Navarra, sembra confermare la versione di Cioppa e dimostrare che, effettivamente, la testimone incontrò il funzionario SISDE sul lungomare Canepa di Genova.
(14) Il generale Paolo Scriccia, nella relazione del 2 novembre 2025 alla Commissione parlamentare sul caso Moro, sostiene di aver accertato che, nell’elenco dei materiali sequestrati dalla Digos nella abitazione di Via Giulio Cesare 47, non compariva una audiocassetta e che, anche a causa della confusione esistente tra i reperti custoditi nei locali della Procura Generale romana, è verosimile che quella che contiene il dialogo sulle vicende genovesi, collocata in un reperto con rubrica «1980» (l’irruzione a Via Giulio Cesare risale invece al 1979), sia stata sequestrata in altro luogo e provenga da un procedimento penale diverso da quello che riguarda l’arresto di Morucci, Faranda e Conforto.
(15) La relazione del consulente generale Paolo Scriccia alla Commissione Parlamentare Moro è del 26 ottobre 2015. Appare importante aggiungere che, nell’aprile ’74, subito dopo il sequestro di Mario Sossi, i GAP (Gruppi Azione Partigiana) genovesi diffusero un comunicato nel quale si rivolgevano alle Brigate Rosse a cui chiedevano di liberare il magistrato solo se, in cambio, lo stato avesse rilasciato i detenuti del gruppo XXII Ottobre. Il comunicato si concludeva con il famoso slogan «Fuori Rossi o morte a Sossi». Susanna Chiarantano dichiarava di essere stata coinvolta nella compilazione e divulgazione di questo comunicato da Luigi Grasso.