Colloquio con Gianrico Carofiglio senatore Pd, magistrato e scrittore, autore de Il paradosso del poliziotto, edizioni nottetempo 2009: «Senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza»
Paolo Persichetti
Liberazione 1 novembre 2009
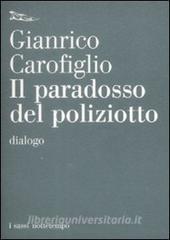 «Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».
«Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».
A Stefano Cucchi è accaduta una cosa del genere?
Questo lo dovranno appurare i titolari dell’inchiesta. Piuttosto sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni fatte da un ufficiale dell’Arma, secondo cui l’unica cosa certa in questa storia è che i carabinieri quella notte si sono comportati correttamente. Un dato certo in realtà è che qualcuno ha prodotto quelle terribili lesioni sul corpo del ragazzo. Se quell’ufficiale garantisce che i carabinieri non hanno nulla di cui rimproverarsi, vuol dire che sa anche chi ha provocato quelle lesioni sul giovane. La conseguenza successiva è che lo deve dire, se vuole essere credibile e non dare l’idea di una difesa d’ufficio di comportamenti inaccettabili.
Nelle indagini uno dei maggiori momenti di criticità è la fase iniziale, quella dove le forze di polizia, in presenza di un fermo, possono agire d’impeto prima dell’intervento della magistratura.
E’ normale che un soggetto tratto in arresto possa essere informalmente interrogato per acquisire notizie utili all’immediato proseguimento dell’indagine. Queste dichiarazioni però non sono utilizzabili e nemmeno verbalizzabili. Un soggetto in stato di arresto non può essere formalmente interrogato dalla polizia giudiziaria.
Però nel suo libro il vecchio poliziotto non aspetta il magistrato. Dialoga col rapinatore, gli toglie le manette, gli offre una sigaretta e quello parla?
Nell’ultimo capitolo del mio prossimo romanzo, c’è un dialogo tra un avvocato e un poliziotto. Ad un certo punto i due parlano delle loro regole nella vita. Il poliziotto dice: «faccio lo sbirro. La prima regola per uno sbirro è non umiliare chi ha di fronte». Dice questo perché il potere sulle altre persone è qualcosa di osceno, perché è l’impossessamento di un corpo e l’unico modo per renderlo tollerabile è il rispetto. Evitare di passare da una funzione tecnica d’investigatore o giudice, a una funzione di giustiziere morale. Rispettare l’altro indipendentemente da chi è, da cosa ha fatto o si suppone abbia fatto. Si tratta della regola più importante ma anche di quella più facile da violare.
Il corpo di Stefano Cucchi non ha avuto questo rispetto. Negli ultimi tempi le cronache hanno registrato anomalie, o per utilizzare il linguaggio dei suoi personaggi, hanno umiliato gli indiziati. Basti pensare a una vicenda come quella della Caffarella, o alla morte di Stefano Brunetti nel 2008, deceduto in carcere per traumi subiti nella fase dell’arresto.
Io non parlerei di una recrudescenza. Il fenomeno è più strutturale e si colloca in quella zona grigia che caratterizza le prime fasi concitate delle indagini. In genere, in queste circostanze, c’è il rischio che si manifestino due tipi di violenza, entrambe illegittime, ovviamente. La prima legata alla fase operativa, quando intervengono modalità movimentate di un arresto o di un fermo. La seconda, molto più grave, è quella praticata negli uffici, a volte come inaccettabile punizione preventiva, a volte come altrettanto inaccettabile tecnica investigativa finalizzata ad acquisire prove. Si tratta di una dimensione difficilmente governabile che si colloca nella fase successiva all’arresto, all’apprensione fisica del soggetto interessato all’attività investigativa. Credo che l’unica soluzione – oltre alla repressione rigorosa degli episodi provati – sia lavorare sulla cultura dei dirigenti e degli operatori, mostrando una tolleranza zero verso forme ingiustificabili di puro sadismo. La capacità di parlare con le persone – indagati e testimoni – è in realtà molto più efficace e positiva nelle prospettiva di un’indagine dagli esiti attendibili.
Ci sono analisi sociologiche che descrivono una sorta di hooliganizzazione della polizia. «L’Italia non è uno stivale. È un anfibio di celerino». La frase è di un esponente delle forze di polizia, e si trova nel libro di Carlo Bonini, Acab. Qualcosa vorrà pur dire, se un agente si esprime in questo modo?
Non si può generalizzare l’atteggiamento di un balordo, o di qualcuno che agisce sotto stress. Non dobbiamo commettere l’errore di dire che la polizia, o i carabinieri, siano questo. Ed è altresì un errore confondere l’uso della violenza che a volte si verifica all’interno dell’attività investigativa con le modalità più o meno brutali di gestione dell’ordine pubblico. Si tratta di due fenomeni distinti. Il primo lo si ritrova, in misura minore o maggiore, nelle polizie di tutto il mondo ed è inversamente proporzionale al grado di civilizzazione e cultura del Paese e delle sue forze di polizia. Altra questione, più legata anche a sollecitazioni politiche, dirette o indirette, quella sull’uso eccessivo della forza in situazioni d’ordine pubblico. Certo si può sempre osservare che in una situazione di barbarie collettiva, di violenza verbale, di perdita di freni inibitori, è più facile che la violenza, in generale, si incrementi.
Può anticipare il contenuto dell’interpellanza parlamentare che depositerà la prossima settimana?
Tra le altre cose, ho chiesto chiarimenti sul fatto che l’autopsia sul corpo di Stefano Cucchi è stata disposta nell’ambito di un fascicolo che nel gergo si chiama modello 45, cioè il fascicolo in cui si inseriscono gli atti non costituenti notizia di reato. Quando l’autorità giudiziaria dispone un’autopsia, la premessa concettuale e giuridica è che ci sia un’ipotesi di reato, anche remota, benché in questo caso remota non lo fosse affatto. Si tratta di una strana anomalia che dovrà essere spiegata.
Di anomalie in questa storia ce ne sono tante. Sembra che Chucchi in caserma avesse indicato un proprio legale di fiducia, che però non risulta mai essere stato avvertito. Quando è comparso in tribunale è stato assistito, per così dire, da un legale d’ufficio.
Se la cosa dovesse trovare conferma sarebbe una circostanza di inaudita gravità e probabilmente un indicatore del fatto che si voleva evitare l’intervento del legale di fiducia e la sua funzione di controllo.
Per saperne di più
Cronache carcerarie
Stefano Cucchi, quella morte misteriosa di un detenuto in ospedale
Stefano Cucchi morto nel Padiglione penitenziario del Pertini, due vertebre rotte e il viso sfigurato
Violenza di Stato non suona nuova

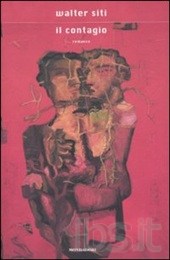
 In alcune redazioni non esitarono a definirla la «belva», e tutto a causa di una minuta sequestrata nella sua cella. Un abbozzo di lettera mai conclusa a un suo coimputato, soprattutto mai spedita. In realtà si trattava della messa per iscritto di un delirio scatenatosi in uno dei momenti più acuti della sua malattia psichiatrica. Era l’estate del 2005, e Diana Blefari Melazzi si trovava in regime di 41 bis aggravato, nella cosiddetta “area riservata” del carcere di Benevento. Nel pozzo più profondo che l’ingegneria sadica della punizione è riuscita a concepire. Ma la «belva» doveva essere lei. Faceva comodo quell’immagine bestiale da sovrapporre alla sparuta pattuglia di aspiranti nuovi brigatisti che, con i loro spari improvvisi, senza radici e senza futuro, avevano bruscamente risvegliato un paese distratto e annoiato. Alcune frasi di odio verso Marco Biagi, estrapolate dal testo, finirono in un rapporto della digos e poi sui giornali. Lo squilibrio mentale venne presentato come un proclama politico. La “pazzia” per la Blefari ha sempre funzionato come un elemento a carico, un’aggravante utile solo per condannarla all’ergastolo. Non è vero che poteva stare nel processo, come i giudici hanno sentenziato con ostinazione. “Doveva” stare nel processo, non aveva scampo. I suoi legali fecero ricorso contro il sequestro di quei fogli privati. Che rilevanza processuale poteva mai avere la parola di una persona ridotta in quello stato? Il tribunale del riesame di Bologna accolse il reclamo e ne dispose la cancellazione dal fascicolo processuale. Un riconoscimento che non ebbe seguito. Per anni la Blefari ha rifiutato le ore di socialità concesse. Non è mai uscita per l’ora d’aria, non ha mai acceso la luce della cella, è stata quasi sempre rintanata sotto le coperte e per lunghi periodi non ha effettuato i colloqui con i familiari e i suoi avvocati. Sospettava che il cibo dell’amministrazione fosse avvelenato e per lunghi periodi non mangiava. Aveva crisi d’identità e disturbi percettivi fino ad arrivare ad allucinazioni visive, particolarmente legate alla televisione nella quale vedeva dei “mostri”, motivo per cui aveva smesso di utilizzarla. Nel 41 bis di L’Aquila rifiutava di avere contatti con le sue coimputate, scambiandone una per Provenzano e l’altra per sua sorella. Rivedeva sua madre, morta suicida dopo una lunga depressione, sul muro di fronte alla sua cella. Nella sua ultima lettera annotava, «continuano le vibrazioni, le sensazioni negative, i sapori di merda in ogni cosa che mangio, le intrusioni nella mia testa sia quando sono sveglia che quando dormo». Ma per i periti nominati dai giudici il suo atteggiamento rientrava nella tipica condotta oppositiva di chi vive un rapporto di inimicizia politica verso le istituzioni. Singolare capovolgimento di fronte. Ogni volta che un detenuto politico è sottoposto a “osservazione scientifica della personalità”, per fruire dei cosiddetti benefici penitenziari deve lottare con chi pensa di poter leggere il suo vissuto politico come una devianza che rinvia a disturbi della personalità. Quando questi ci sono realmente, vengono interpretati in modo politico. L’avvocato Caterina Calia ha ricordato la disponibilità venuta da molte detenute politiche storiche ad assistere la Blefari. Nelle carceri esiste la figura del “piantone”, ovvero di un detenuto che assume l’incarico di assistere un suo compagno impossibilitato a occuparsi di se stesso. La Blefari poteva essere aiutata, ma venne sempre tenuta isolata dalle altre politiche. C’era chi sperava di strumentalizzarne la sofferenza per farne una collaboratrice di giustizia. All’inizio dell’anno la
In alcune redazioni non esitarono a definirla la «belva», e tutto a causa di una minuta sequestrata nella sua cella. Un abbozzo di lettera mai conclusa a un suo coimputato, soprattutto mai spedita. In realtà si trattava della messa per iscritto di un delirio scatenatosi in uno dei momenti più acuti della sua malattia psichiatrica. Era l’estate del 2005, e Diana Blefari Melazzi si trovava in regime di 41 bis aggravato, nella cosiddetta “area riservata” del carcere di Benevento. Nel pozzo più profondo che l’ingegneria sadica della punizione è riuscita a concepire. Ma la «belva» doveva essere lei. Faceva comodo quell’immagine bestiale da sovrapporre alla sparuta pattuglia di aspiranti nuovi brigatisti che, con i loro spari improvvisi, senza radici e senza futuro, avevano bruscamente risvegliato un paese distratto e annoiato. Alcune frasi di odio verso Marco Biagi, estrapolate dal testo, finirono in un rapporto della digos e poi sui giornali. Lo squilibrio mentale venne presentato come un proclama politico. La “pazzia” per la Blefari ha sempre funzionato come un elemento a carico, un’aggravante utile solo per condannarla all’ergastolo. Non è vero che poteva stare nel processo, come i giudici hanno sentenziato con ostinazione. “Doveva” stare nel processo, non aveva scampo. I suoi legali fecero ricorso contro il sequestro di quei fogli privati. Che rilevanza processuale poteva mai avere la parola di una persona ridotta in quello stato? Il tribunale del riesame di Bologna accolse il reclamo e ne dispose la cancellazione dal fascicolo processuale. Un riconoscimento che non ebbe seguito. Per anni la Blefari ha rifiutato le ore di socialità concesse. Non è mai uscita per l’ora d’aria, non ha mai acceso la luce della cella, è stata quasi sempre rintanata sotto le coperte e per lunghi periodi non ha effettuato i colloqui con i familiari e i suoi avvocati. Sospettava che il cibo dell’amministrazione fosse avvelenato e per lunghi periodi non mangiava. Aveva crisi d’identità e disturbi percettivi fino ad arrivare ad allucinazioni visive, particolarmente legate alla televisione nella quale vedeva dei “mostri”, motivo per cui aveva smesso di utilizzarla. Nel 41 bis di L’Aquila rifiutava di avere contatti con le sue coimputate, scambiandone una per Provenzano e l’altra per sua sorella. Rivedeva sua madre, morta suicida dopo una lunga depressione, sul muro di fronte alla sua cella. Nella sua ultima lettera annotava, «continuano le vibrazioni, le sensazioni negative, i sapori di merda in ogni cosa che mangio, le intrusioni nella mia testa sia quando sono sveglia che quando dormo». Ma per i periti nominati dai giudici il suo atteggiamento rientrava nella tipica condotta oppositiva di chi vive un rapporto di inimicizia politica verso le istituzioni. Singolare capovolgimento di fronte. Ogni volta che un detenuto politico è sottoposto a “osservazione scientifica della personalità”, per fruire dei cosiddetti benefici penitenziari deve lottare con chi pensa di poter leggere il suo vissuto politico come una devianza che rinvia a disturbi della personalità. Quando questi ci sono realmente, vengono interpretati in modo politico. L’avvocato Caterina Calia ha ricordato la disponibilità venuta da molte detenute politiche storiche ad assistere la Blefari. Nelle carceri esiste la figura del “piantone”, ovvero di un detenuto che assume l’incarico di assistere un suo compagno impossibilitato a occuparsi di se stesso. La Blefari poteva essere aiutata, ma venne sempre tenuta isolata dalle altre politiche. C’era chi sperava di strumentalizzarne la sofferenza per farne una collaboratrice di giustizia. All’inizio dell’anno la

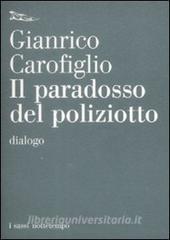 «Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».
«Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».



