Da sempre priva di riscontri la vecchia dietrologia cerca conforto nelle nuove tecnologie. Domenica 22 febbraio la polizia scientifica ha effettuato una scansione laser del luogo dove Aldo Moro venne sequestrato 36 anni fa.
Questo è il primo di un ciclo di interventi dedicato ai lavori della nuova commissione d’inchiesta parlamentare sul rapimento e l’uccisione del presidente della Democrazia cristiana. Leggi le puntate successive (2a e 3a)
Paolo Persichetti
Il Garantista 28 febbraio 2015
 Il tratto di strada che il 16 marzo 1978 vide alcuni operai scesi dalle fabbriche del Nord dare l’assalto, insieme a dei giovani romani di varia estrazione, al convoglio di auto che trasportava il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro, non trova pace.
Il tratto di strada che il 16 marzo 1978 vide alcuni operai scesi dalle fabbriche del Nord dare l’assalto, insieme a dei giovani romani di varia estrazione, al convoglio di auto che trasportava il presidente della Democrazia cristiana Aldo Moro, non trova pace.
Quella mattina, lungo via Fani si erano dati appuntamento in dieci: un tecnico, un contadino, una assistente di sostegno, diversi studenti, un artigiano, un paio di disoccupati, alcuni operai, un commerciante. Il più anziano aveva 32 anni, la più giovane 20. Erano le Brigate rosse, intenzionate a sferrare un attacco senza precedenti al «cuore dello Stato».
A distanza di 36 anni questo fatto storico non è ancora accettato dai cultori del complotto, anzi dei ripetuti complotti di diversa natura e colore, tutti assolutamente reversibili, che nei tre decenni ormai alle spalle si sono succeduti in perfetta antitesi tra loro.
E’ per questo che domenica scorsa l’incrocio tra via Fani e via Stresa, situato nella zona nord di Roma, è stato sottoposto a scansione laser da alcuni tecnici della polizia scientifica che in questo modo tenteranno di far rivivere i fatti di quella mattina di 36 anni fa attraverso alcuni software tridimensionali in grado di elaborare e verificare tutti i dati balistici, peritali e testimoniali raccolti all’epoca delle indagini e dei processi.
Lo ha deciso la terza commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento del leader  democristiano, insediatasi in ottobre. Dopo tanta dietrologia i commissari hanno pensato di ricostruire sotto forma di realtà virtuale la scena del rapimento. Quanto alla fine possa risultare attendibile una ricostruzione del genere, che integra dati raccolti in epoche lontane e con tecniche ormai sorpassate rispetto all’odierna tecnologia forense, per ora non ci è dato sapere. Il teatro dell’azione fu largamente inquinato dall’invasione di funzionari e vertici delle forze dell’ordine, fotografi e giornalisti che calpestarono i reperti. Addirittura una vettura della Digos, un’Alfasud beige, piombò sulla scena dell’attentato e fu parcheggiata sul lato del marciapiede dove era partito il commando. Si può facilmente ipotizzare che i suoi pneumatici abbiano fatto schizzare, o comunque spostato, diversi reperti, in particolare i bossoli. Ma in fondo, questo è l’aspetto meno importante: dei nuovi rilievi – sempre che risultino attendibili – non possono che confortare quanto è già noto da tempo.
democristiano, insediatasi in ottobre. Dopo tanta dietrologia i commissari hanno pensato di ricostruire sotto forma di realtà virtuale la scena del rapimento. Quanto alla fine possa risultare attendibile una ricostruzione del genere, che integra dati raccolti in epoche lontane e con tecniche ormai sorpassate rispetto all’odierna tecnologia forense, per ora non ci è dato sapere. Il teatro dell’azione fu largamente inquinato dall’invasione di funzionari e vertici delle forze dell’ordine, fotografi e giornalisti che calpestarono i reperti. Addirittura una vettura della Digos, un’Alfasud beige, piombò sulla scena dell’attentato e fu parcheggiata sul lato del marciapiede dove era partito il commando. Si può facilmente ipotizzare che i suoi pneumatici abbiano fatto schizzare, o comunque spostato, diversi reperti, in particolare i bossoli. Ma in fondo, questo è l’aspetto meno importante: dei nuovi rilievi – sempre che risultino attendibili – non possono che confortare quanto è già noto da tempo.
Significativo, invece, è il dato politico che esprime questa iniziativa, mirata «a stabilire – come ha dichiarato il presidente della nuova commissione d’inchiesta, Giuseppe Fioroni – l’oggettività di alcuni fatti sulla base di una certezza: non c’è corrispondenza tra il racconto dei 55 giorni e alcune chiare circostanze».
Cinque processi, decine e decine di ergastoli erogati insieme centinaia di anni di carcere, due commissioni parlamentari, le testimonianze dei protagonisti, alcuni importanti lavori storici, non hanno scalfito l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico che da oltre tre decenni alligna sul caso Moro e l’intera storia della lotta armata per il comunismo, quando in realtà è proprio questa ostinazione negazionista il nodo che ha trasformato in un “caso” l’azione di via Fani.
Fa paura ancora oggi cercare risposte alle vere domande che quei 55 giorni sollevano: come prevalse la linea della fermezza? Perché Dc e Pci, in un reciproco gioco di ricatti e sospetti, rimasero irremovibili sulla posizione del rigor mortis? Perché gli uomini di Moro, ben piazzati dentro la Dc e nei gangli dello Stato, non fecero nulla, o ben poco, per agevolare la sua liberazione? Perché il Pci sabotò ogni tentativo di trattativa, anzi denigrò le lettere dell’ostaggio dichiarando che non erano farina del suo sacco, se è vero che Moro era ritenuto la pedina decisiva per portare a termine la strategia del compromesso storico? Le culture politiche di questi due grandi partiti furono poi così all’altezza degli eventi? Non è lì dentro che si dovrebbe scavare senza riverenze e scrupoli per capire?
Invece ancora oggi c’è chi prova ad offuscare l’intelligibilità di quell’evento, come ha fatto recentemente lo storico, ora parlamentare e membro della nuova commissione Moro, Miguel Gotor, restio ad accettare l’idea che dei giovani operai e borgatari romani si fossero organizzati al punto da sfidare lo Stato lasciando il corpo di Moro nel cuore della toponomastica del compromesso storico, «della lotta politica e della guerra fredda» (episodio reiterato con il sequestro D’Urso), a due passi da via delle Botteghe oscure (allora sede nazionale del Pci) e piazza del Gesù (sede nazionale della Dc).
Per Gotor, se le Brigate rosse volevano raggiungere quell’obbiettivo propagandistico, «lo avrebbero lasciato in una discarica della periferia con nella destra una copia dell’Unità e nella sinistra una copia del Popolo, e non si sarebbero mai e poi mai assunte tutti quei rischi incredibili».
Dunque Moro doveva finire nell’immondizia perché ciò che muove dalle periferie non può che sfociare nelle discariche, è quanto mostra di pensare il braccio destro di Bersani, dando prova di un forte pregiudizio classista venato di populismo anticasta. La storia successiva ci dice che a mettergli l’Unità in tasca non furono le Brigate rosse ma l’autore del monumento che gli venne dedicato a Maglie, in Puglia, mentre la sola idea che le periferie dell’epoca potessero appostarsi sotto i Palazzi della politica e dell’economia suscita ancora negli esemplari odierni del ceto politico quegli stessi brividi freddi che l’aristocrazia versagliese provò di fronte ai sanculotti che mettevano a ferro e fuoco l’ancien régime.
Si comprende perché la dietrologia, ora nella sua veste tridimensionale, oltre ad essere un redditizio affare per l’industria editoriale e la pubblicistica da marciapiede, si presta come balsamo consolatorio, diversivo che consente di evadere i quesiti più imbarazzanti, le responsabilità più pesanti. Quanti su questa fondamentale rimozione hanno costruito la loro fortuna, le loro carriere negli anni di quella Seconda repubblica nata sul funerale di Moro?
- 1/continua
- Le altre puntate
2a puntata – Il caso Moro e il paradigma di Andy Warhol
- 3a puntata – Via Fani e il fantasma del colonnello Guglielmi
- Per saperne di più
Rapimento Moro, la ricostruzione dell’azione di via Fani disegnata da Mario Moretti
Ecco la prova che nessuno sparò al motorino di Marini in via Fani
Lotta armata e teorie del complotto









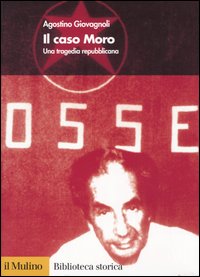 esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana. Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da
esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana. Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da