
di Paolo Persichetti
Quattro anni fa, qualche tempo dopo l’uscita del primo volume sulla storia delle Brigate rosse (Brigate rosse, dalle fabbriche alla campagna di primavera, Deriveapprodi marzo 2017), scritto insieme a Marco Clementi ed Elisa Santalena, ho ricevuto una telefonata di Sante Notarnicola. Nel volume, dove un intero capitolo curato da Elisa si occupava della realtà carceraria (la grande stagione delle lotte dei detenuti, le commissioni interne, le proteste sui tetti, la dura repressione alle Murate e ad Alessandria, la riforma subito bloccata, la parabola dei Nap, la differenziazione, lo stato d’eccezione carcerario e le carceri speciali), inevitabilmente il nome di Sante, protagonista decisivo di quella stagione, tornava più volte. Raccontavamo anche lo scambio epistolare che ebbe con Primo Levi, riportando in particolare il passaggio in cui lo scrittore motivava il suo disaccordo sull’uso del termine «lager» (in una lettera del 5 settembre 1979), ampiamente in uso in quegli anni nel linguaggio e nelle pubblicazioni del movimento dei prigionieri e delle organizzazioni comuniste combattenti quando descrivevano le terribili condizioni di vita e il sistema detentivo messo in piedi nelle carceri speciali di massima sicurezza. Ad avviso di Primo Levi quel termine non era estensibile a realtà diverse da quelle esistenti nei campi nazisti, come Auschwitz. L’obiezione di Levi forte della sua sensibilità di reduce dell’olocausto sovrapponeva la realtà dei campi di sterminio ai campi di concentramento, un modello di internamento totale precedente l’esperienza del nazismo. Il grande scrittore successivamente si soffermava sull’opera poetica che Notarnicola aveva realizzato in carcere: «le tue poesie – scriveva – (alcune, come sai, le conoscevo già) sono belle, quasi tutte: alcune bellissime, altre strazianti. Mi sembra che, nel loro insieme, costituiscano una specie di teorema, e ne siano anzi la dimostrazione: cioè, che è poeta solo chi ha sofferto o soffre, che perciò la poesia costa cara» (p. 132).
Sante aveva chiamato per raccontarmi un fatto che lo aveva amareggiato molto. Il professor Agostino Giovagnoli, in un passo del volume dedicato al rapimento Moro, Il caso Moro, una tragedia repubblicana, aveva realizzato un falso storico nei suoi confronti. Nel raccontare le reazioni suscitate dal comunicato numero otto della Brigate rosse, nel quale in cambio della liberazione di Aldo Moro si chiedeva la scarcerazione di tredici prigionieri politici tra i quali figurava in testa alla lista il nome di Notarnicola, aveva scritto: «Sante Notarnicola si dissociò subito dalla richiesta brigatista», (p. 202). Non era affatto vero, per altro l’articolo di Giuliano Zincone, riportato in nota dal professore, non confermava affatto la circostanza mentre molti quotidiani di quei giorni, tra cui lo stesso Corriere della sera, avevano correttamente riportato la posizione di Notarnicola. Sante aveva cercato in ogni modo di raggiungere Giovagnoli per spiegargli l’errore e ottenere la correzione, ma non aveva mai ottenuto risposta. Mi raccontò i fatti e mi chiese di tornare su quell’episodio appena possibile, magari in una nuova edizione del libro, chiarendo come erano andate veramente le cose in quelle ore concitate nel supercarcere di Nuoro, dove era rinchiuso.
Oggi, che ci ha lasciato, voglio saldare la promessa che gli feci.
Dopo la diffusione del comunicato brigatista, il 30 aprile 1978, fu chiamato dal Direttore del carcere, che – circostanza davvero incredibile – lo lasciò solo nel suo ufficio davanti ad un telefono, «prendi tutto il tempo che vuoi e telefona a chi vuoi, se necessario», gli disse chiudendosi la porta alle spalle. Erano arrivati ordini ben precisi dai piani alti del ministero dove qualcuno sperava in questo modo di ottenere una presa di distanza, molto potente sul piano simbolico, da parte di Notarnicola.
All’altro capo del filo Sante riconobbe la voce di Valentino Parlato del manifesto che tentò in tutti i modi di convincerlo a prendere le distanze da quella richiesta di scambio, confidando sul lungo rapporto di stima e collaborazione costruito negli anni delle lotte carcerarie. La pressione fu notevole, e per Sante suonò come un ricatto dei sentimenti che ancora sembrava gli pesasse, ma disse no. La stessa cosa, raccontano le cronache dei quotidiani, avvenne poco dopo con Paolo Brogi, che chiamava per conto del quotidiano Lotta continua, giornale che più di ogni altro aveva dato voce alla stagione delle lotte e rivolte contro le condizioni di vita nelle carceri. Attraverso l’avvocato Giannino Guiso, il giorno successivo Notarnicola diffuse una breve dichiarazione che metteva fine ad ogni tentativo di separare i prigionieri dalla richiesta di liberazione avanzata dalle Brigate rosse: «L’unica soluzione è lo scambio, anche perché questo Stato l’unica riforma carceraria che sa fare è quella delle carceri speciali e l’unico modo per liberare i compagni prigionieri è quello portato avanti dalle Brigate rosse»1.
Chiudo queste righe con un altro racconto di Sante: l’arrivo di Franca Salerno a Badu ’e Carros, il carcere speciale di Nuoro. Raccolsi la sua testimonianza per Liberazione alla morte di Franca, storica militante dei Nap. Sante parlava come un libro stampato, era una grande narratore di storie, ancora sento i brividi:
«Franca arrivò col suo bambino di pochi giorni. Occupava una sezione isolata, la vedevamo e la sentivamo. Ci fu subito la corsa a prendere le celle che davano sul suo lato. La sera si spegnevano tutte le televisioni e sul carcere calava un silenzio surreale. Cominciava così il dialogo. Anche se ero uno dei pochi compagni, e quindi avevo con lei un rapporto privilegiato, Franca era ben attenta a non trascurare nessuno. Il piccino fu subito adottato da tutta la comunità carceraria e così i pacchi di cibo che arrivavano dalle famiglie venivano mandati a lei. Una mattina, fatto insolito, mi urlò dalla cella. Improvvisamente il carcere si ammutolì. Il bambino stava male e le guardie non facevano niente. Franca mi chiese di chiamare il capo delle guardie. Quel silenzio totale risuonò per loro come una minaccia. Il maresciallo arrivò di corsa chiedendoci di restare tranquilli che il medico sarebbe arrivato entro 5 minuti. Una macchina era stata spedita a prenderlo. “Avete rischiato molto – gli dissi -, siete feroci ma non potete immaginare quanto potremmo diventarlo noi per una cosa del genere”». Sante si ferma, è commosso. «Quanta forza venne dai Nap, organizzazione fatta di studenti e detenuti. Di fronte allo sfacelo che c’è oggi nelle carceri, a Franca vorrei dire “avevate ragione voi”».
Ciao Sante!
- Corriere della sera, 1 maggio 1978; Tutto quotidiano, 1 maggio 1978.


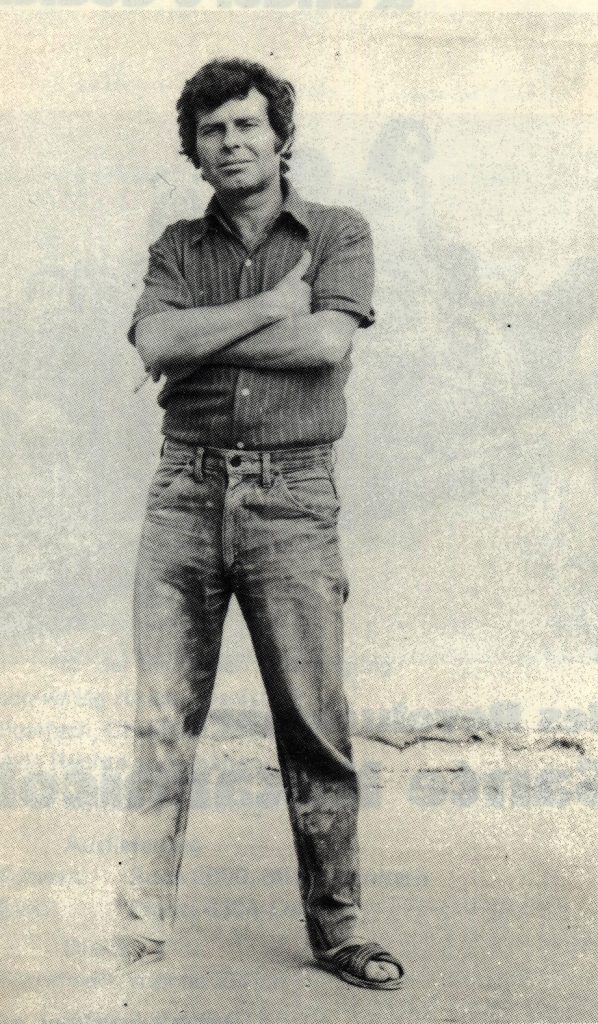


 prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra
prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra  condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili».
condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili». gennaio 1979 colpì suo padre. «Ho incontrato Vincenzo Guagliardo quando era in regime di semilibertà e credo di poter testimoniare a favore del suo ravvedimento», ha dichiarato la senatrice del Pd, aggiungendo di voler «parlare con il giudice perché possa riconsiderare la sua decisione». Guido Rossa venne colpito dopo aver denunciato e fatto arrestare dai carabinieri un altro operaio, Francesco Berardi, suo compagno di lavoro, sospettato di diffondere volantini delle Br in fabbrica e poi morto suicida nel carcere speciale di Cuneo. L’episodio fu uno dei momenti più drammatici e laceranti della storia di quegli anni. Mise a nudo la profondità di un conflitto che arrivava fin nel cuore più rosso e combattivo della classe operaia e segnò uno dei punti di crisi maggiore nella strategia brigatista.
gennaio 1979 colpì suo padre. «Ho incontrato Vincenzo Guagliardo quando era in regime di semilibertà e credo di poter testimoniare a favore del suo ravvedimento», ha dichiarato la senatrice del Pd, aggiungendo di voler «parlare con il giudice perché possa riconsiderare la sua decisione». Guido Rossa venne colpito dopo aver denunciato e fatto arrestare dai carabinieri un altro operaio, Francesco Berardi, suo compagno di lavoro, sospettato di diffondere volantini delle Br in fabbrica e poi morto suicida nel carcere speciale di Cuneo. L’episodio fu uno dei momenti più drammatici e laceranti della storia di quegli anni. Mise a nudo la profondità di un conflitto che arrivava fin nel cuore più rosso e combattivo della classe operaia e segnò uno dei punti di crisi maggiore nella strategia brigatista. Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che
Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che  permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.
permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.