Basta con il livore verso i fuoriusciti è ora di fare la storia degli anni 70
Paolo Persichetti
Liberazione, venerdì 2 febbraio 2007
Apparso anche su www.carmillaonline.com
Francesco Merlo, su la Repubblica del 18 gennaio, scrive peste e corna dei fuoriusciti riparati in Francia. Li raffigura simili ad  un circo Barnum e, come in un mattinale della questura, s’inventa pure un fantomatico dibattito tra ‘uscisti’ ed ‘entristi’ della lotta armata. Soprattutto prende di petto Oreste Scalzone, che dopo trent’anni ha avuto reati e condanna prescritti. Il suo è un minestrone di parole che ammucchiano colore, gossip, dicerie, fandonie, pregiudizi. Ce l’ha persino col loro modo di parlare. L’argot inevitabile d’ogni migrante che ha dovuto apprendere la nuova lingua per necessità. Ma poi aggiunge che alcuni tra loro pubblicano libri, fanno ricerca universitaria, aprono librerie e negozietti, senza rendersi conto della contraddizione. Ha da ridire anche sul fatto che non vestono Prada e si meraviglia di come si possa campare ventisei anni di espedienti, cioè di precariato. Domanda interessante, questa, che dovrebbe rivolgere ai cantori nostrani della deregolamentazione del mercato del lavoro.
un circo Barnum e, come in un mattinale della questura, s’inventa pure un fantomatico dibattito tra ‘uscisti’ ed ‘entristi’ della lotta armata. Soprattutto prende di petto Oreste Scalzone, che dopo trent’anni ha avuto reati e condanna prescritti. Il suo è un minestrone di parole che ammucchiano colore, gossip, dicerie, fandonie, pregiudizi. Ce l’ha persino col loro modo di parlare. L’argot inevitabile d’ogni migrante che ha dovuto apprendere la nuova lingua per necessità. Ma poi aggiunge che alcuni tra loro pubblicano libri, fanno ricerca universitaria, aprono librerie e negozietti, senza rendersi conto della contraddizione. Ha da ridire anche sul fatto che non vestono Prada e si meraviglia di come si possa campare ventisei anni di espedienti, cioè di precariato. Domanda interessante, questa, che dovrebbe rivolgere ai cantori nostrani della deregolamentazione del mercato del lavoro.
 Chi vede Parigi dagli appartamenti dei grandi boulevards, e guadagna con un solo articolo il corrispettivo di quattro stipendi da operaio e otto da precario nei call center, è preso d’angoscia di fronte ad una simile prospettiva e percepisce i marciapiedi delle città, il caldo maleodorante del suo reticolo sotterraneo di vie ferrate, come un’insidia dura e ingenerosa. Dante parlava dell’esilio con parole molto amare: «tu lascerai ogni cosa diletta/ […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Sarà che ognuno fa le sue esperienze, saranno le diavolerie della tecnologia, ma a Parigi ci sono tanti ascensori e infinite scale mobili e poi ad esser salato è il burro, non il pane. Insomma, se la città la vivi dai sottotetti dei quartieri popolari e multietnici, quella durezza diventa generosità, solidarietà, complicità naturale, intreccio di vite che arrivano da mille angoli del pianeta, ognuna con la sua valigia di storie. Scalzone, e altri come lui, tutto questo l’hanno vissuto sempre al presente, senza nostalgie, senza rimpianti e con le radici che ormai crescevano all’insù.
Chi vede Parigi dagli appartamenti dei grandi boulevards, e guadagna con un solo articolo il corrispettivo di quattro stipendi da operaio e otto da precario nei call center, è preso d’angoscia di fronte ad una simile prospettiva e percepisce i marciapiedi delle città, il caldo maleodorante del suo reticolo sotterraneo di vie ferrate, come un’insidia dura e ingenerosa. Dante parlava dell’esilio con parole molto amare: «tu lascerai ogni cosa diletta/ […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Sarà che ognuno fa le sue esperienze, saranno le diavolerie della tecnologia, ma a Parigi ci sono tanti ascensori e infinite scale mobili e poi ad esser salato è il burro, non il pane. Insomma, se la città la vivi dai sottotetti dei quartieri popolari e multietnici, quella durezza diventa generosità, solidarietà, complicità naturale, intreccio di vite che arrivano da mille angoli del pianeta, ognuna con la sua valigia di storie. Scalzone, e altri come lui, tutto questo l’hanno vissuto sempre al presente, senza nostalgie, senza rimpianti e con le radici che ormai crescevano all’insù.
Sarà forse solo una lontana parentela, ma le parole di Merlo ricordano quelle di un giornale pubblicato a Parigi con le finanze dell’Ovra, la famigerata polizia politica di Mussolini. Era rivolto alla folta comunità di emigranti italiani e s’intitolava, guarda caso, il Merlo. La sua ragion d’essere era la calunnia quotidiana dei fuoriusciti antifascisti. 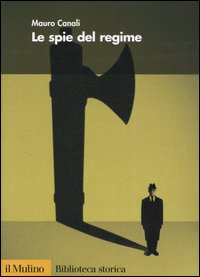 Immorale è il viaggio quando si rimane stranieri, ha scritto tempo fa Claudio Magris. E stranieri i fuoriusciti non lo sono mai stati. La nostalgia è stata quella degli altri, come racconta Milan Kundera, anche lui un tempo esiliato. Nóstos e Àlgos sono parole greche che indicano «ritorno» e «sofferenza». Nostalgia è dunque la tristezza che provoca l’impossibilità di tornare. Ma in altre lingue l’etimologia è diversa e trae origine dal latino ignorare. In questo caso, la nostalgia si esprime come «sofferenza per l’ignoranza» di non sapere quel che accade lontano da noi. Ma Scalzone, in tutti questi anni, non ha avuto il tempo di rimpiangere e ignorare proprio nulla, come Ulisse nell’alcova di Calipso. Coinvolto tra mille incontri e scoperte in tutte le battaglie della nuova modernità liquida, come la chiama Zygmunt Bauman: migranti, senza tetto, giovani delle banlieues, precari, altermondialisti, scioperi come quello generale del ’95, mentre a casa sua facevano tappa musicisti, poeti, teatranti e giramondo, scappati e scampati da magistrature, eserciti e polizie di mezzo mondo, compreso qualche fascista gravemente ammalato e un democristiano ricercato. Per farsi aprire bastava esibire come passaporto un mandato di cattura.
Immorale è il viaggio quando si rimane stranieri, ha scritto tempo fa Claudio Magris. E stranieri i fuoriusciti non lo sono mai stati. La nostalgia è stata quella degli altri, come racconta Milan Kundera, anche lui un tempo esiliato. Nóstos e Àlgos sono parole greche che indicano «ritorno» e «sofferenza». Nostalgia è dunque la tristezza che provoca l’impossibilità di tornare. Ma in altre lingue l’etimologia è diversa e trae origine dal latino ignorare. In questo caso, la nostalgia si esprime come «sofferenza per l’ignoranza» di non sapere quel che accade lontano da noi. Ma Scalzone, in tutti questi anni, non ha avuto il tempo di rimpiangere e ignorare proprio nulla, come Ulisse nell’alcova di Calipso. Coinvolto tra mille incontri e scoperte in tutte le battaglie della nuova modernità liquida, come la chiama Zygmunt Bauman: migranti, senza tetto, giovani delle banlieues, precari, altermondialisti, scioperi come quello generale del ’95, mentre a casa sua facevano tappa musicisti, poeti, teatranti e giramondo, scappati e scampati da magistrature, eserciti e polizie di mezzo mondo, compreso qualche fascista gravemente ammalato e un democristiano ricercato. Per farsi aprire bastava esibire come passaporto un mandato di cattura.  I nostalgici sono rimasti in Italia, alcuni perché hanno fatto degli anni ’70 l’oggetto del loro incarognito risentimento, come Sergio Segio. Uno che si racconta avvinto da un ineluttabile destino. «Non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo», scrive in un libro dove inanella una serie impressionante di goffe citazioni scapigliate, iscrivendosi nel «novero dei destinati alla sconfitta che non scelgono l’esilio ma di andare fino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Convinzione che lo porta a rivendicare una sorta di primazìa etica: l’aver prima commesso l’errore giusto ed in seguito aver ripudiato nel modo più giusto la giustezza dell’errore passato. Prova d’eccellenza assoluta, che giustificherebbe il suo irrefrenabile desiderio d’accedere allo status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista.
I nostalgici sono rimasti in Italia, alcuni perché hanno fatto degli anni ’70 l’oggetto del loro incarognito risentimento, come Sergio Segio. Uno che si racconta avvinto da un ineluttabile destino. «Non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo», scrive in un libro dove inanella una serie impressionante di goffe citazioni scapigliate, iscrivendosi nel «novero dei destinati alla sconfitta che non scelgono l’esilio ma di andare fino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Convinzione che lo porta a rivendicare una sorta di primazìa etica: l’aver prima commesso l’errore giusto ed in seguito aver ripudiato nel modo più giusto la giustezza dell’errore passato. Prova d’eccellenza assoluta, che giustificherebbe il suo irrefrenabile desiderio d’accedere allo status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista.

Vittoriale
Immerso nella recita di uno stucchevole copione dannunziano, raffigura se stesso avvolto in un’atmosfera d’estetismo combattente: «anima capace di tenerezza», che sceglie «di morire non nella lenta emorragia della vita ma di fretta, senza risparmio, come candele accese dai due lati, non per malattia del corpo ma per quella della coerenza, per un’inguaribile infezione dell’anima». Poeta armato, novello Sturm und Drang, sognatore impaziente, adepto del carpe diem, declama: «i nostri attimi sono eterni e ci ripagano di tutto». Fiore appassito più che fiore del male, maledetto mancato ma redento riuscito, anche se con parole che indulgono sempre al calibro ben oliato e al rimirar la poesia del gesto, la metrica dell’intenzione che conduce ad un eroico «andar incontro alla bella morte». Quella altrui, ovviamente.
Una prosa a metà tra l’imitazione di Marinetti e quella del Vittoriale, senza risparmiarci il lieto fine hollywoodiano che condanna l’infausto protagonista a vivere finalmente ravveduto e contento, e che – per dirla con Jim Thompson in Colpo di spugna – di fronte allo specchio della propria vita non può fare a meno di sputare ogni mattino sulla faccia di quel che è stato lo scaracchio di ciò che è diventato. L’esperienza dei fuoriusciti 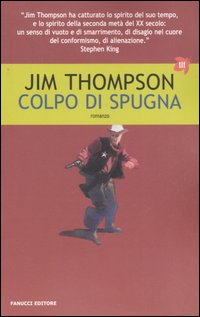 rappresenta da oltre vent’anni un’anticipazione del possibile, ciò che avrebbe potuto essere il futuro italiano se fosse stata varata una soluzione politica per gli anni ’70. Una smentita cocente per gli imprenditori dell’emergenza, un esempio da cancellare con ferocia e motivo d’incontenibile livore per chi tra dissociazioni e pentimenti, in cambio di laute ricompense premiali, non perde occasione di salire in cattedra e recitare l’autocritica degli altri.
rappresenta da oltre vent’anni un’anticipazione del possibile, ciò che avrebbe potuto essere il futuro italiano se fosse stata varata una soluzione politica per gli anni ’70. Una smentita cocente per gli imprenditori dell’emergenza, un esempio da cancellare con ferocia e motivo d’incontenibile livore per chi tra dissociazioni e pentimenti, in cambio di laute ricompense premiali, non perde occasione di salire in cattedra e recitare l’autocritica degli altri.
A Sinistra, come a Destra, molti scimmiottano il riformismo blairiano. Ma il primo ministro inglese si è sporcato le mani con il conflitto irlandese, ha negoziato con l’Ira, ha liberato tutti i prigionieri politici, anche con reati di sangue, e stabilito tappe di un processo politico che ha condotto alla fine del conflitto. In Italia, invece, la sua tanto decantata strategia viene imitata solo per liberalizzazioni e privatizzazioni. Siamo l’unico paese in Europa in cui il ciclo politico della lotta armata è stato chiuso vent’anni fa con un atto unilaterale dei suoi militanti. Siamo gli unici ad avere ancora un centinaio di fuoriusciti e prigionieri politici ormai prossimi ai trenta anni di carcere. Siamo gli unici a selezionare le vittime: Calabresi sì, Pinelli no.
Guardare al rientro di Scalzone come all’ennesima occasione possibile per voltare pagina non sarebbe forse più utile e intelligente? Domanda superflua in un paese che ha seppellito i fatti sociali degli anni ’70 sotto la memoria penale, mentre le stragi, da quelle nazi-fasciste a quelle che hanno tentato di fermare i movimenti, rimangono impunite, senza verità, chiuse in un armadio con le ante rivolte verso il muro. In Italia i passati rivoluzionari non possono diventare Storia. Per questo l’unico futuro che riesce ad affacciarsi all’orizzonte sembra avere il colore plumbeo della colpa. Selettiva, naturalmente.
Articoli correlati
Segio: “La mia rivoluzione era un pranzo di gala”
La Prima linea, il film che vorrebbe seppellire gli anni 70 sotto il peso del senso di colpa
Miccia corta e cervello pure
L’esportazione della colpa
Sergio Segio: “Scalzone e i parigini condannino la lotta armata”
“Segio ha dimostrato solo di avere ancora molte cambiali da pagare per la sua libertà”
“Monsieur de la calomnie”
Scalzone: “Caro Segio, non c’ è nulla da cui mi devo dissociare”
Sergio Segio, il narcisismo del senso di colpa
Segio e l’ideologia del ravvedimento
I Ravveduti

 Fu così che all’alba del giorno seguente venni scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori di ogni trasparenza, concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Quella furtiva consegna celava una flagrante violazione della legalità internazionale: una persona non può essere estradata per dei fatti posteriori a quelli indicati nel decreto, in assenza di una nuova richiesta e previa verifica del suo fondamento. Pur di avallare il teorema della centrale francese le autorità hanno agito aggirando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione europea sulle estradizioni.
Fu così che all’alba del giorno seguente venni scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori di ogni trasparenza, concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Quella furtiva consegna celava una flagrante violazione della legalità internazionale: una persona non può essere estradata per dei fatti posteriori a quelli indicati nel decreto, in assenza di una nuova richiesta e previa verifica del suo fondamento. Pur di avallare il teorema della centrale francese le autorità hanno agito aggirando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione europea sulle estradizioni.
 I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.
I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.
 Era stato
Era stato