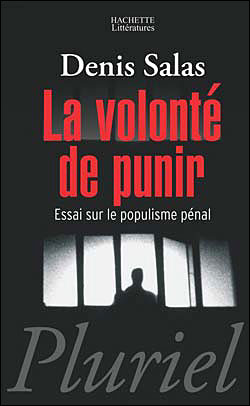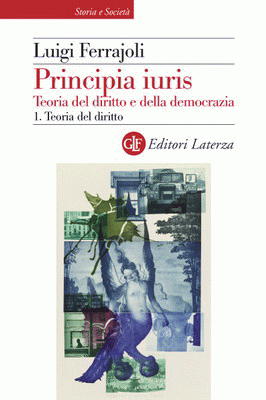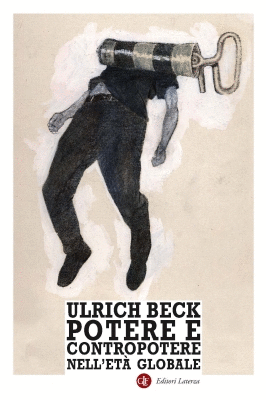Risentimento e vittimismo al posto della giustizia sociale: il “populismo penale” si nutre di paura, insicurezza e dell’utopia reazionaria della “tolleranza zero”
Paolo Persichetti
Liberazione 21 novembre 2010

A metà strada tra il descrittivo e il normativo, il populismo – sostengono molti autori – è una categoria politica di difficile definizione che non designa un fenomeno circoscrivibile ma soltanto una logica sociale i cui effetti producono esperienze politiche molto diverse. In realtà più una sindrome sociale che una dottrina politica, afferma Peter Wiles. Non a caso il populismo viene evocato per dare nome a situazioni che si manifestano in periodi di crisi. Nel contesto europeo la fine del fordismo, la rottura del rapporto identitario legato all’appartenenza sociale, in Italia il crollo del sistema dei partiti, più in generale l’emergere di sistemi politici neo-oligarchici. Il populismo altro non è che «un modo di costruzione del politico», sostiene Ernesto Laclau, La ragione populista (Laterza, 2008) che mette al centro della legittimità politica, manipolandola e passivizzandola, una vaga astrazione denominata “popolo”. Fenomeno che nello specifico laboratorio politico italiano si è diversificato sommando ai tradizionali temi patriottici e nazional-popolari, interpretati in questo caso dai postfascisti, nuove rivendicazioni pseudoetniche o regionalistiche intrecciate a sentimenti di rivolta fiscale contro lo Stato nazione ed a pulsioni xenofobe e razziste incarnate dalla Lega Nord. Forme di ripiego identitario capaci al tempo stesso di coabitare con un “cesarismo mediatico”, espresso dal modello berlusconiano, poco interessato ai localismi valligiani e totalmente proiettato verso una dimensione hertziana e ipnotica della comunicazione politica, fautore di una società lasciata in balia degli appetiti più sfrenati e prédatori del mercato, a tutto vantaggio di un nuovo ordine censitario e di un aggressivo orgoglio proprietario che darwinianamente ha rilegittimato il diritto di sopraffazione sui meno abbienti, sdoganando «la ricchezza come misura del proprio valore e il trionfo degli istinti animali del capitalismo come pubbliche virtù».
Queste nuova dimensione antropologica ha favorito la penetrazione trasversale di altre forme di populismo tra le cui pieghe si è sedimentata un’ossessiva rappresentazione fobica e igienista della società. Un’isteria sociale che ha nutrito la crescita dirompente del fenomeno giustizialista, il cui successo si è riversato sul funzionamento del sistema giudiziario trasformato in una nuova arena da combattimento tra attori e gruppi sociali dominanti. Il ricorso a nuovi repertori moralistici, improntati sul tema della virtù, è così servito a giustificare l’uso strategico dello strumento giudiziario, impiegato in un primo momento, gli anni 90, dalle singole fazioni dominanti nella rincorsa ad etichettarsi reciprocamente come criminali. Paura e insicurezza sono diventate le parole chiave di questo dispositivo che infrange le tradizionali barriere tra destra e sinistra e al cui interno coesistono grammatiche politiche eterogenee: una nevrotica e l’altra psicotica. Questa trasversalità della paura è frutto dell’attuale società dell’incertenza, un derivato di rapporti sociali e di lavoro improntati sulla flessibilità e il precariato. La modificazione del paradigma produttivo, il declino di modelli politici edificati sulla base del compromesso rappresentato dello Stato sociale, il trionfo dei modelli neoliberali, hanno mutato ciò che un tempo si intendeva per sicurezza, ovvero una idea progettuale di esistenza fondata su diritti sociali e politici garantiti: dal lavoro, al reddito, alla scuola, all’assistenza sanitaria, alla pensione, all’azione sindacale. Diritti che a loro volta dispiegavano nuove richieste e bisogni inclusivi. Tutto ciò si è rovesciato trasformandosi in una visione arroccata dell’esistenza, costruita attorno all’utopia reazionaria della “tolleranza zero”. Alla sicurezza si chiede la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, reali o immaginari, che sia il capitale o una casa popolare non fa differenza, anziché la difesa da un’economia che li minaccia.
Il populismo ha assunto dunque una connotazione «penale» declinata come risposta alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo va riferito quindi al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Un risentimento che si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Ecco che a differenza dei populismi passati, il populismo penale attenua la tradizionale carica antielitaria per rivolgere la propria stigmatizzazione verso capri espiatori individuati nelle posizioni più basse della scala sociale: dagli immigrati, ai nomadi, ai giovani delle periferie, agli emarginati, più in generale a quelle figure che riempiono le fila dell’esercito salariale di riserva. La sua caratteristica è quelle di muovere una guerra sociale verso il basso. Guerre dei possidenti contro i nulla tenenti e guerra tra poveri. Secondo il sociologo Vincenzo Ruggiero, una spiegazione provvisoria potrebbe essere la seguente: nelle società neoliberiste il successo individuale viene premiato tanto quanto l’insuccesso viene punito. «Chi nel mercato mostra segni di fallimento va espulso, castigato; si rischia altrimenti di lanciare un messaggio insidioso, vale a dire che la responsabilità per il fallimento non è da attribuire all’individuo, ma al mercato medesimo». Si afferma così – ha denunciato il giurista Luigi Ferrajoli – una «duplicazione del diritto penale» che designa il passaggio dalla fase giustizialista al populismo penale vero e proprio. Un diritto mite per i ricchi e i potenti e un diritto massimo per i poveri e gli emarginati. «E’ la prova che oggi la giustizia – sostiene sempre Ferrajoli – è sostanzialmente impotente nei confronti della delinquenza dei colletti bianchi, mentre è severissima nei confronti della delinquenza di strada. Si pensi agli aumenti massicci di pena per i recidivi previsti dalla legge Cirielli, sull’esempio degli Stati Uniti, simultaneamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i delitti societari. E si pensi, invece, alle pene durissime introdotte dal decreto sulla sicurezza: espulsione dello straniero condannato a più di due anni, reclusione da 1 a 5 anni per avere dichiarato false generalità, aumento della pena fino a un terzo nel caso in cui lo straniero sia clandestino».
Emerso negli Stati Uniti durante gli anni 80 come discorso politico, proprio della destra neoconservatrice, specializzato nelle promesse punitive capaci di sedurre l’elettorato, il populismo penale ha rotto gli argini nei decenni successivi per divenire l’oggetto irrinunciabile della contesa tra i partiti politici di ogni schieramento. Il populismo penale non è più di destra o di sinistra: è la forma della politica attuale interpretata con minori o maggiori sfumature. Quest’ideologia presenta tuttavia sfaccettaure diverse tra la realtà nordamericana e quella europea. Differenze legate alla presenza di modelli sociali, istituzionali e giudiziari dissimili.
Il tema della complicità dello Stato con il crimine, tacciato per questo d’elitismo e corruzione, appartiene al repertorio classico della critica neoconservatice e dei libertarians americani (i fautori dello Stato minimo) nei confronti di quello che viene ritenuto un eccessivo presenzialismo statale. Al contrario, da noi, i “professionisti dell’antimafia” denunciano il lassismo del governo nella lotta alla criminalità auspicando un sempre maggiore coinvolgimento dello Stato. Il sistema giudiziario di tipo accusatorio fa si che nel modello nordamericano si configura una contrapposizione politico-ideologica tra gli incarichi elettivi e quelli indipendenti che reggono il sistema della giustizia penale. Lo sceriffo della contea insieme a l’attorney (il procuratore) sono ritenuti gli eroi della guerra senza quartiere al crimine. Mentre il giudice terzo, in quanto garante delle forme della legge, è percepito come un ostacolo se non addirittura una figura connivente con la delinquenza. La tradizione inquisitoria che pervade ancora il sistema giudiziario italiano, via di mezzo tra rito istruttorio e “semiaccusatorio”, consente invece alla nostra magistratura di essere individuata come il perno centrale della lotta non solo alla criminalità ma più in generale all’ingiustizia. Gli strumenti giudiziari d’eccezione e la cultura inquirente congeniata per contrastare la sovversione sociale degli anni 70, la lunga stagione delle leggi penali speciali e dei maxiprocessi che hanno traversato il decennio 80, e lo tsunami giudiziario che ha preso il nome di “Tangentopoli” nella prima metà degli anni 90, hanno conferito alla nostra magistratura il ruolo di vero e proprio soggetto politico portatore di un disegno generale della società.
Il modello del capro espiatorio ha svolto un ruolo centrale nella vicenda passata alle cronache come la rivoluzione di “Mani pulite”. Le conseguenze, per nulla percepite dagli attori dell’epoca, che spesso pensavano di interpretare una stagione di rinnovamento del Paese, sono state enormi. E’ da lì che hanno preso forma e si sono strutturate le ideologie del rancore e del vittimismo che fomentano trasversalmente le attuali correnti populiste, stravolgendo quell’idea di giustizia che per lungo tempo era stata sospinta da ragioni che disprezzavano gli strumenti della penalità e del carcere in favore della ricerca del bene comune. Se prima si trattava di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi in un miglioramento delle condizioni di vita di ciascuno, ora il traguardo più ambito è l’aula processuale, conquistare un posto in prima fila nei tribunali, sedere sui banchi della pubblica accusa o delle parti civili. Si pensa e si parla solo attraverso le lenti dell’ideologia penale. Una sovrabbondanza che alla fine, è superfluo ricordarlo, non ha creato più giustizia. Come dicevano già i romani: summum ius, summa iniuria. Il mito della giustizia penale ha alla fine trasformato la politica nel cimitero della giustizia sociale. L’esaltazione delle qualità salvifiche del potere giudiziario ha fatto tabula rasa di ogni critica dei poteri.