Libri – Il Nemico inconfessabile, Paolo Persichetti, Oreste Scalzone, Odradek 1999
Capitolo secondo – Un maggio lungo dieci anni
Altro era il fare convulso che mi raccontavi e che conteneva, secondo quanto mi dicevi, parte di un mondo futuro […] Era un modo di battersi. Non si chiedeva di essere d’accordo con un progetto, solo darsi alle lotte. Furono case vuote che vennero occupate, pigioni che non si pagarono più, bollette di elettricità bruciate in piazza. Si impedivano le ritorsioni degli stacchi, degli sfratti. Si era smesso di pagare i conti, si passava a esigere. Quando finiva il tempo della lotta, con risultato buono o cattivo, si cominciava da un’altra parte […] Non eravamo convenienti, il nostro metodo era l’urto, tecnica faticosa per ottenere anche poco, a volte niente. Però procurava peso. C’è un tempo della vita in cui un uomo vuol poggiare al suolo una pianta larga, un passo non leggero. Non per pestarlo, ma per caricarlo con tutto il corpo. In quegli anni nessuno voleva essere lieve. Urgeva una diversa gravità che cambiò l’andatura di molti […] Negli anni degli urti nessuno voleva essere più alto, più magro, nemmeno più sano: ridevano volentieri le bocche sdentate […]
Erri De Luca, Aceto, Arcobaleno. 
1. Quando si guarda alla storia italiana degli anni 70, quando si affronta quella lunga stagione di sovversione politica e sociale, il pensiero corre in ritirata, la profondità diventa pesantezza e l’intelligenza lascia il posto alla piattezza. Allora ogni considerazione indugia sovente più al giudizio che alla riflessione. Un lungo maggio rampante tamtamizzato, disseminato, ha attraversato per intero gli anni Settanta, tra insurrezione e controinsurrezione, persistenze e resistenze, protraendosi fino ai soprassalti degli anni 80. Questa contestazione sociale generalizzata ha avuto il suo epicentro nell’insorgenza selvaggia di un vero potere operaio, il cui fulcro, nel contesto della regolamentazione fordista e della produzione taylorista, è stato rappresentato dalla fanteria degli operai massa(1). Questi ultimi erano costituiti per la maggior parte da terroni, omologhi dei turchi alla Volkswagen, dei pachistani della Gran Bretagna, dei magrebini a Billancourt. Terroni i cui padri, annessi in un’epoca relativamente recente, erano stati assimilati e italianizzati a forza, prima col sistema fiscale dei Savoia, poi attraverso il battesimo del fuoco e del sangue – nel fango delle trincee della Grande Guerra – in regioni dove gli abitanti parlavano una lingua a loro straniera.
Origini lontane dell’anomalia italiana
2. Bisogna considerare le specificità del processo di costruzione, sulle spalle del corpo sociale, di uno Stato-nazione fabbricato dall’alto sulla società civile, le società dell’antico paese dalle cento città. E poi, risalire alla questione delle masse cattoliche, al «non expedit»(2), all’Italietta, al fascismo, alle avventure coloniali, alla guerra persa. E ancora, al «compromesso storico» ante litteram dei grandi partiti di massa: la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, coppia opposta, associati e antagonisti di due egemonie. Il mito fondatore della Repubblica fu dunque il Risorgimento, ma l’Assemblea costituente risultò talmente ossessionata dalla volontà di rilegittimare il modello centralista, da scartare il federalismo e facilitare l’avvio della «partitocrazia». Da un lato, il Piano Marshhall, lo scudo crociato Libertas, la Chiesa, la Nato, il Mercato comune; dall’altro, l’attesa della rivoluzione, la telenovela dello Sputnik(3), e sulla terra, il valore del lavoro e il lavoro come valore, una sorta di “calvinismo del capitale variabile”. La gestione, insieme, di un’economia mista sulla base della dialettica tra difesa del lavoro e iniziativa del capitale, come riflesso privilegiato della diarchia geopolitica definita a Yalta: il «bipartitismo imperfetto», il «fattore K», la «dottrina Sonnenfeldt»(4) – l’elemento di sovradeterminazione geopolitica che ha congelato l’Italia, permettendo più di quaranta anni di equilibrio eccezionale(5) – e il «consociativismo»(6) (cioè l’associazione dell’opposizione comunista ai poteri e alle decisioni come compenso all’impossibilità dell’alternanza). E ancora, la configurazione ideologica e politica assunta in Italia dalla contro-rivoluzione stalinista: il togliattismo(7), il «nazional-popolare», un misto di machiavellismo, di spirito contro-riformista, di filosofia della storia – necessariamente idealista – di egualitarismo e di collettivismo verso il basso (l’egualitarismo dei «più uguali degli altri», il comunismo degli uomini non comuni, il comunismo cratico invece del comunismo critico), e un’ibridazione profusa, tra le quali l’eredità dello storicismo hegeliano versione Benedetto Croce, o dell’attualismo di Gentile(8).
Originalità della sovversione sociale italiana nel contesto europeo
3. Nel dopoguerra, a partire dagli anni cinquanta, cominciò un enorme trasferimento interno di forza-lavoro dovuto alla  domanda generata dalle rapide forme di sviluppo del capitalismo italiano. Il vecchio operaio professionale, a forte spessore ideologico, dotato di una memoria storica legata alla Resistenza, si fuse progressivamente con la nuova figura dell’«operaio massa». I nostri «arabi» alla Fiat erano loro, con la differenza che essi possedevano una carta d’identità italiana e non erano dunque sottomessi al ricatto dell’espulsione, e inoltre potevano comunicare alla catena di montaggio con lo stesso medium linguistico. Questa «rude razza pagana», massa arrabbiata di giovani meridionali sottratta al tradizionale controllo della Chiesa esercitato nelle campagne, incontrò la scuola della lotta di classe nelle fabbriche del nord e la tradizione del sovversivismo rivoluzionario della Resistenza. S’innescò così una miscela esplosiva(9). I fatti del «luglio 60»(10). e quelli di Piazza Statuto nel 1961(11), furono le prime grandi manifestazioni di autonomia operaia del dopoguerra. Due episodi che assunsero il ruolo simbolico di apertura dei cicli di lotte che condussero agli anni 70. Questi due momenti rappresentarono l’affacciarsi sulla scena delle nuove generazioni operaie che si andavano formando nel tessuto sociale metropolitano: i giovani dalle «magliette a strisce» e i nuovi «operai di linea», carichi di una rabbia sociale nuova, un’insofferenza per la tradizionale rigida morale operaia e la prospettiva di una vita di fabbrica, sotto l’influenza di culture giovanili che trovavano spazio tra le pieghe della società dei consumi che si approssimava. Fece irruzione una nuova immaginazione del conflitto e una fantasia delle forme di lotta che sorprese e scavalcò le organizzazioni tradizionali del movimento operaio e della sinistra(12).
domanda generata dalle rapide forme di sviluppo del capitalismo italiano. Il vecchio operaio professionale, a forte spessore ideologico, dotato di una memoria storica legata alla Resistenza, si fuse progressivamente con la nuova figura dell’«operaio massa». I nostri «arabi» alla Fiat erano loro, con la differenza che essi possedevano una carta d’identità italiana e non erano dunque sottomessi al ricatto dell’espulsione, e inoltre potevano comunicare alla catena di montaggio con lo stesso medium linguistico. Questa «rude razza pagana», massa arrabbiata di giovani meridionali sottratta al tradizionale controllo della Chiesa esercitato nelle campagne, incontrò la scuola della lotta di classe nelle fabbriche del nord e la tradizione del sovversivismo rivoluzionario della Resistenza. S’innescò così una miscela esplosiva(9). I fatti del «luglio 60»(10). e quelli di Piazza Statuto nel 1961(11), furono le prime grandi manifestazioni di autonomia operaia del dopoguerra. Due episodi che assunsero il ruolo simbolico di apertura dei cicli di lotte che condussero agli anni 70. Questi due momenti rappresentarono l’affacciarsi sulla scena delle nuove generazioni operaie che si andavano formando nel tessuto sociale metropolitano: i giovani dalle «magliette a strisce» e i nuovi «operai di linea», carichi di una rabbia sociale nuova, un’insofferenza per la tradizionale rigida morale operaia e la prospettiva di una vita di fabbrica, sotto l’influenza di culture giovanili che trovavano spazio tra le pieghe della società dei consumi che si approssimava. Fece irruzione una nuova immaginazione del conflitto e una fantasia delle forme di lotta che sorprese e scavalcò le organizzazioni tradizionali del movimento operaio e della sinistra(12).
4. Questo vero e proprio contro-potere si esprimeva prima di tutto attraverso l’assalto al reddito e la critica pratica del lavoro. Un contro-potere che si presentava come una potenza di, opposta ai poteri su. Era l’espressione di un alto livello d’indipendenza, dunque di virtuale autonomia. Questo forte antagonismo operaio agiva come embrione di un potere alternativo: scioperi a oltranza e scioperi selvaggi, cortei di officina, occupazioni e insubordinazione operaia, forme dure di lotta che avevano modificato i rapporti di forza. La gerarchia del comando capitalista era rimessa in discussione, le vecchie commissioni interne vennero sostituite dai consigli di fabbrica, la cui spinta radicale fu ben presto normalizzata con la loro trasformazione in strutture di base dalle confederazioni sindacali, attraverso la formazione del sindacato dei consigli(13). L’esperienza dei Cub (Comitati Unitari di Base(14) in alcune grandi fabbriche, che vede la classe operaia trasformarsi in soggetto, segno di una forte spinta di autonomia, è alla base delle rivendicazioni sociali economicamente più sovversive, come la rottura del legame tra aumento del salario e incremento della produttività. Il salario diventa così una variabile indipendente dalla produttività(15). Gli operai escono dalla fabbrica, occupano i centri urbani e si legano agli altri settori di classe: studenti, senza-casa, donne. L’intera società si infiamma. Lo scontro sociale tocca livelli altissimi. La massa delle ore di sciopero, i grafici del conflitto, la dimensione quantitativa e qualitativa del confronto, mostrano tetti mai raggiunti nei decenni precedenti. Il che spiega come un’epoca in cui l’autonomia del politico aveva trovato nel «compromesso storico» la sua realizzazione più ardita, avesse come riflesso speculare e vitale una furibonda autonomia del sociale.
Gli anni 70: l’autonomia del sociale contro l’autonomia del politico
 5. È l’epoca dell’unione sacra, che ha conosciuto il suo apogeo al momento del «compromesso storico» e dell’«unità nazionale», nell’ipertrofia del regime dei partiti, dello Stato dei partiti sostituitosi allo Stato sociale(16). Al suo posto si ebbe, o la potenza delle lotte sociali – il «Vogliamo tutto»(17) – oppure, i corporativismi incrociati: le strutture sindacali e politiche del «Movimento operaio» istituzionale, che esercitavano il ruolo di padrini sociali sulla forza lavoro; o la balena bianca, partito-madre, partito-regime, partito-Stato, che è stata la Democrazia cristiana. La quale, a suo modo, era anche partito-Stato sociale con la sua politica di redistribuzione “a pioggia” dei redditi in cambio di consenso elettorale, una specie di versione clientelare del keynesismo(18). Oltre trent’anni di potere avevano trasformato la dc in un partito-società, fotocopia della maggioranza sociale del Paese, agglomerato di classi, corporazioni, ceti, lobbies, che in essa trovavano il luogo della rappresentanza e della mediazione dei loro interessi. Al suo interno c’erano la destra e la sinistra sociale, una miscela di modernità e tradizione. Con un rapporto di egemonie concatenate l’una all’altra, Dc e Pci gestivano ognuno la propria sfera: ai democristiani quella superiore che controllava l’esecutivo, gli esteri, gli interni, la politica economica, la difesa; ai comunisti la forza-lavoro e la cultura. Persino all’interno degli organi repressivi dello Stato – dove carabinieri e polizia erano sempre rimasti rigidamente controllati dalla dc, si aprivano spazi per la presenza di uomini legati al Pci. Nella magistratura inquirente, soprattutto; ovvero tra quei sostituti procuratori che hanno avuto un ruolo chiave nel supplire all’incapacità di risposta politica dello Stato alla sovversione sociale montante. Questa «gestione simbiotica» dello Stato e della società civile trovò un cemento ulteriore, una legittimità ideologica, nella gestione dello stato di emergenza antiterrorista. La sovversione politica e sociale che cresceva in quegli anni fu anche il primo grande nemico del consociativismo e della partitocrazia.
5. È l’epoca dell’unione sacra, che ha conosciuto il suo apogeo al momento del «compromesso storico» e dell’«unità nazionale», nell’ipertrofia del regime dei partiti, dello Stato dei partiti sostituitosi allo Stato sociale(16). Al suo posto si ebbe, o la potenza delle lotte sociali – il «Vogliamo tutto»(17) – oppure, i corporativismi incrociati: le strutture sindacali e politiche del «Movimento operaio» istituzionale, che esercitavano il ruolo di padrini sociali sulla forza lavoro; o la balena bianca, partito-madre, partito-regime, partito-Stato, che è stata la Democrazia cristiana. La quale, a suo modo, era anche partito-Stato sociale con la sua politica di redistribuzione “a pioggia” dei redditi in cambio di consenso elettorale, una specie di versione clientelare del keynesismo(18). Oltre trent’anni di potere avevano trasformato la dc in un partito-società, fotocopia della maggioranza sociale del Paese, agglomerato di classi, corporazioni, ceti, lobbies, che in essa trovavano il luogo della rappresentanza e della mediazione dei loro interessi. Al suo interno c’erano la destra e la sinistra sociale, una miscela di modernità e tradizione. Con un rapporto di egemonie concatenate l’una all’altra, Dc e Pci gestivano ognuno la propria sfera: ai democristiani quella superiore che controllava l’esecutivo, gli esteri, gli interni, la politica economica, la difesa; ai comunisti la forza-lavoro e la cultura. Persino all’interno degli organi repressivi dello Stato – dove carabinieri e polizia erano sempre rimasti rigidamente controllati dalla dc, si aprivano spazi per la presenza di uomini legati al Pci. Nella magistratura inquirente, soprattutto; ovvero tra quei sostituti procuratori che hanno avuto un ruolo chiave nel supplire all’incapacità di risposta politica dello Stato alla sovversione sociale montante. Questa «gestione simbiotica» dello Stato e della società civile trovò un cemento ulteriore, una legittimità ideologica, nella gestione dello stato di emergenza antiterrorista. La sovversione politica e sociale che cresceva in quegli anni fu anche il primo grande nemico del consociativismo e della partitocrazia.
La tribù delle talpe
6. La prima metà degli anni 70 è caratterizzata dal proliferare di numerose formazioni extraparlamentari che si lanciano in una rissosa disputa concorrenziale nel tentativo di occupare lo spazio politico apertosi, dopo il ‘68, alla sinistra del Pci. La  stagione degli anni 60, sotto la spinta di un clima internazionale caratterizzato dallo sviluppo di numerosi «movimenti di liberazione nazionale», anticolonialisti e antimperialisti, di fronte all’effervescenza teorica e ideologica legata alla nascita o alla ripresa di diverse scuole marxiste, aveva visto formarsi numerosi gruppi e organismi marxisti-leninisti, operaisti, trotzkisti, consiliaristi, situazionisti, bordighisti, anarchici e maoisti. Il ‘68 e sopratutto l’offensiva operaia del ‘69, danno vita a un nuovo «ceto politico» che si struttura nella decisione di fondare l’«organizzazione rivoluzionaria». Ha origine così un’inflazione di «partitini» in rivalità aperta sullo stesso terreno sociale e nello stesso spazio politico. Le ragioni della loro rapida ascesa e soprattutto della folgorante caduta sono molteplici e complesse; un nodo decisivo fu certamente quello che venne a costituirsi verso la metà degli anni 70. La radicalizzazione estrema delle lotte sociali aveva generato, per effetto anche del «compromesso storico», una unipolarizzazione dello spazio politico. Il ventaglio delle opzioni strategiche percorribili si era assai ridotto. La rottura violenta, l’approfondimento di un tragitto radicalmente sovversivo – linea che al tempo stesso teorizzava e assecondava una spinta sociale violenta, di rottura, proveniente dal basso, dalle fabbriche e dalle periferie urbane – fu il progetto, l’elemento di demarcazione e di selezione (che si manifestò in forme diverse e concorrenziali), scelto dalle formazioni che intendevano ancora proseguire un percorso politico autonomo, non subalterno e incisivo. Il Collettivo politico metropolitano (a partire dalla quale nasceranno le Br) sarà il primo a intraprendere in modo risolutivo questa strada; qualche anno dopo, sull’onda dell’occupazione di Mirafiori del 1973 sarà la volta di Potere operaio, che aveva già una importante struttura di «lavoro illegale» attiva fin dai primi momenti degli anni 70. Lotta continua, il gruppo con più forte séguito di massa, resta invece lacerata da un contrasto di fondo. Una linea che radicalizza lo scontro, sostenuta dalla frazione operaia e da parte del servizio d’ordine – attratti dalla scelta combattente – si oppone a quella del gruppo dirigente che, una volta superate le oscillazioni del ‘72-’73, spinge per trasformare il movimento in partito, teorizzando l’ingresso nell’area istituzionale. Lotta continua traverserà una lunga crisi che si concluderà con il suo scioglimento nell’autunno del 1976. I maoisti di Servire il popolo, l’organizzazione-sètta, una struttura tra le più burocratiche e verticali degli anni 70 (essa programmava la vita dei suoi militanti, la morale, persino i comportamenti sessuali), con un certo séguito proletario nel meridione, si sfalderà sotto l’insorgenza della «nuova soggettività militante»(19) espressa dal movimento del ‘77. Altrove l’Mls, il Manifesto, Avanguardia operaia, Pdup, ripropongono modelli che oscillano tra posizioni ultrastaliniste e «rivisitazioni togliattiane verniciate di maoismo» e rivalutano «figure ed epoche storiche del movimento comunista italiano, da Gramsci alla Resistenza»(20). Convinti che il tema centrale fosse la battaglia contro il terrorismo di Stato, la «strategia della tensione»(21) e il «fanfascismo»(22), questi gruppi concentravano tutta la loro attenzione sulle battaglie democratiche e civili perdendo contatto con le lotte sociali e la fabbrica. «I “gruppi” non hanno una strategia di fabbrica, i loro militanti sono esposti all’epurazione, vengono spesso licenziati o si autolicenziano o s’imboscano nel sindacato»(23). Nelle grosse concentrazioni operaie del Nord solo le formazioni clandestine riescono a proteggere per lungo tempo la loro sottile rete organizzativa. Le formazioni extraparlamentari sopravvissute al movimento del ‘77 vengono gradualmente assorbite nel «sistema dei partiti» fino a dar vita a esperienze di tipo parlamentare come quella di Democrazia proletaria(24), protrattasi fino alla fine degli anni 80. «Nell’autunno del ‘73 mentre sulla fiat occupata sventolano le bandiere rosse, i “gruppi” hanno già di fatto concluso il loro breve ciclo»(25).
stagione degli anni 60, sotto la spinta di un clima internazionale caratterizzato dallo sviluppo di numerosi «movimenti di liberazione nazionale», anticolonialisti e antimperialisti, di fronte all’effervescenza teorica e ideologica legata alla nascita o alla ripresa di diverse scuole marxiste, aveva visto formarsi numerosi gruppi e organismi marxisti-leninisti, operaisti, trotzkisti, consiliaristi, situazionisti, bordighisti, anarchici e maoisti. Il ‘68 e sopratutto l’offensiva operaia del ‘69, danno vita a un nuovo «ceto politico» che si struttura nella decisione di fondare l’«organizzazione rivoluzionaria». Ha origine così un’inflazione di «partitini» in rivalità aperta sullo stesso terreno sociale e nello stesso spazio politico. Le ragioni della loro rapida ascesa e soprattutto della folgorante caduta sono molteplici e complesse; un nodo decisivo fu certamente quello che venne a costituirsi verso la metà degli anni 70. La radicalizzazione estrema delle lotte sociali aveva generato, per effetto anche del «compromesso storico», una unipolarizzazione dello spazio politico. Il ventaglio delle opzioni strategiche percorribili si era assai ridotto. La rottura violenta, l’approfondimento di un tragitto radicalmente sovversivo – linea che al tempo stesso teorizzava e assecondava una spinta sociale violenta, di rottura, proveniente dal basso, dalle fabbriche e dalle periferie urbane – fu il progetto, l’elemento di demarcazione e di selezione (che si manifestò in forme diverse e concorrenziali), scelto dalle formazioni che intendevano ancora proseguire un percorso politico autonomo, non subalterno e incisivo. Il Collettivo politico metropolitano (a partire dalla quale nasceranno le Br) sarà il primo a intraprendere in modo risolutivo questa strada; qualche anno dopo, sull’onda dell’occupazione di Mirafiori del 1973 sarà la volta di Potere operaio, che aveva già una importante struttura di «lavoro illegale» attiva fin dai primi momenti degli anni 70. Lotta continua, il gruppo con più forte séguito di massa, resta invece lacerata da un contrasto di fondo. Una linea che radicalizza lo scontro, sostenuta dalla frazione operaia e da parte del servizio d’ordine – attratti dalla scelta combattente – si oppone a quella del gruppo dirigente che, una volta superate le oscillazioni del ‘72-’73, spinge per trasformare il movimento in partito, teorizzando l’ingresso nell’area istituzionale. Lotta continua traverserà una lunga crisi che si concluderà con il suo scioglimento nell’autunno del 1976. I maoisti di Servire il popolo, l’organizzazione-sètta, una struttura tra le più burocratiche e verticali degli anni 70 (essa programmava la vita dei suoi militanti, la morale, persino i comportamenti sessuali), con un certo séguito proletario nel meridione, si sfalderà sotto l’insorgenza della «nuova soggettività militante»(19) espressa dal movimento del ‘77. Altrove l’Mls, il Manifesto, Avanguardia operaia, Pdup, ripropongono modelli che oscillano tra posizioni ultrastaliniste e «rivisitazioni togliattiane verniciate di maoismo» e rivalutano «figure ed epoche storiche del movimento comunista italiano, da Gramsci alla Resistenza»(20). Convinti che il tema centrale fosse la battaglia contro il terrorismo di Stato, la «strategia della tensione»(21) e il «fanfascismo»(22), questi gruppi concentravano tutta la loro attenzione sulle battaglie democratiche e civili perdendo contatto con le lotte sociali e la fabbrica. «I “gruppi” non hanno una strategia di fabbrica, i loro militanti sono esposti all’epurazione, vengono spesso licenziati o si autolicenziano o s’imboscano nel sindacato»(23). Nelle grosse concentrazioni operaie del Nord solo le formazioni clandestine riescono a proteggere per lungo tempo la loro sottile rete organizzativa. Le formazioni extraparlamentari sopravvissute al movimento del ‘77 vengono gradualmente assorbite nel «sistema dei partiti» fino a dar vita a esperienze di tipo parlamentare come quella di Democrazia proletaria(24), protrattasi fino alla fine degli anni 80. «Nell’autunno del ‘73 mentre sulla fiat occupata sventolano le bandiere rosse, i “gruppi” hanno già di fatto concluso il loro breve ciclo»(25).
La fine dell’innocenza
7. L’ammutinamento crescente, propagatosi di settimana in settimana, da una città all’altra, la contestazione di massa  dell’intera istituzione sociale, di ogni relazione di potere, avevano prodotto una situazione preinsurrezionale. La risposta alle aggressioni brutali della polizia aveva permesso di verificare la possibilità della violenza collettiva. A quel punto essa fu considerata come inevitabile e propria delle epoche rivoluzionarie. Per alcuni gruppi divenne l’atto costitutivo della propria azione politica. In ogni caso essa partecipò alla radicalizzazione delle forme di lotta. Potere contro potere, a lungo andare è la forza che decide. Non sarebbe necessario ritornare ai classici della teoria politica(26), per capire che un movimento sovversivo multipolare, disseminato e prolungato negli anni, abbia suscitato un livello di scontro che dilagò in forme dure di violenza sociale e politica. Tra il 1947 e il 1969, 171 persone, per la maggior parte operai e contadini, vennero uccise dalle forze dell’ordine durante manifestazioni, picchetti di sciopero, e occupazioni di terre(27), tanto che il Pci di allora aveva richiesto il «disarmo delle forze di polizia in attività di ordine pubblico». Si trattava di un’epoca in cui al massimo i manifestanti si armavano di pietre. Questo stillicidio di morti ha rappresentato il costo del mantenimento dell’ordine pubblico in tempo di pace. Nel corso degli anni Settanta l’irruzione sociale della forza ha rimesso in discussione il monopolio della violenza detenuto dallo Stato(28). Ci sarebbe stato da stupirsi se fosse accaduto il contrario; in quel caso una simile assenza avrebbe posto un vero problema teorico(29).
dell’intera istituzione sociale, di ogni relazione di potere, avevano prodotto una situazione preinsurrezionale. La risposta alle aggressioni brutali della polizia aveva permesso di verificare la possibilità della violenza collettiva. A quel punto essa fu considerata come inevitabile e propria delle epoche rivoluzionarie. Per alcuni gruppi divenne l’atto costitutivo della propria azione politica. In ogni caso essa partecipò alla radicalizzazione delle forme di lotta. Potere contro potere, a lungo andare è la forza che decide. Non sarebbe necessario ritornare ai classici della teoria politica(26), per capire che un movimento sovversivo multipolare, disseminato e prolungato negli anni, abbia suscitato un livello di scontro che dilagò in forme dure di violenza sociale e politica. Tra il 1947 e il 1969, 171 persone, per la maggior parte operai e contadini, vennero uccise dalle forze dell’ordine durante manifestazioni, picchetti di sciopero, e occupazioni di terre(27), tanto che il Pci di allora aveva richiesto il «disarmo delle forze di polizia in attività di ordine pubblico». Si trattava di un’epoca in cui al massimo i manifestanti si armavano di pietre. Questo stillicidio di morti ha rappresentato il costo del mantenimento dell’ordine pubblico in tempo di pace. Nel corso degli anni Settanta l’irruzione sociale della forza ha rimesso in discussione il monopolio della violenza detenuto dallo Stato(28). Ci sarebbe stato da stupirsi se fosse accaduto il contrario; in quel caso una simile assenza avrebbe posto un vero problema teorico(29).
NOTE
1. Operai di linea addetti alla catena di montaggio, differenziati, per livello contrattuale e mansioni, dagli operai specializzati.
2. Nel marzo 1871 il Vaticano, che non riconosceva formalmente lo Stato unitario italiano, introdusse la formula del non expedit (letteralmente, “non giova”, “non conviene”). Essa impediva ai cattolici di partecipare alle elezioni politiche. Questo divieto perdurò per oltre trenta anni e fu abbandonato progressivamente nel primo decennio del 1900 (patto Gentiloni, alleanza tra cattolici e liberali di Giolitti) soltanto per arginare lo sviluppo tra le masse popolari del Partito socialista. L’11 febbraio 1929 ci fu il reciproco riconoscimento tra Stato Pontificio e Stato fascista.
3. Primo satellite spaziale. Fu messo in orbita dai sovietici nel 1958.
4. Il riferimento è a Helmut Sonnenfeldt, politologo statunitense di marca moderata, consigliere per gli affari europei della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato. La sua dottrina prevedeva l’impossibilità di accesso del Pci al governo e la strutturazione del sistema politico in una sorta di “conventio ad excludendum” (patto per l’esclusione) tra tutte le restanti forze politiche.
5. L’Italia non è stata affatto un paese instabile dal punto di vista istituzionale, come una parte della pubblicistica di scuola liberale (contraria al sistema elettorale proporzionale e alla “democrazia dei partiti”) ha sostenuto. Cambiavano i governi ma le leve del potere politico sono rimaste saldamente nelle mani dello stesso partito per oltre quaranta anni.
6. Il primo a utilizzare il modello di “democrazia consociativa” alla fine degli anni 60 è lo studioso olandese Arend Lijphart. Essa consiste “in una fondamentale cooperazione a livello delle élites con lo scopo deliberato di combattere le tendenze disgregratrici del sistema”, Arend LIJPHART, “Typologies of democratic System”, (in Comparative Political Studies, n. 1, 1968) e “Consociacional Democracy” (in World Politics, n. XXI, 1969). La tesi è ripresa e proposta in italia da Gianfranco PASQUINO, “Il sistema politico italiano tra neoriformismo e democrazia consociativa”, in Il Mulino, luglio-agosto 1973. Il termine è impiegato nella sociologia politica nord-americana (”consociational democracy“), in modo particolare negli studi consacrati al fenomeno del “pluralismo segmentato”. Queste ricerche, incentrate su una sorta d’analisi degli aggregati macropolitici, hanno messo in luce le forme di regolazione ed equilibrio costituite tra “blocchi” ideologico-culturali contrapposti che permettono la stabilità politica e la sopravvivenza del sistema. Consociational Democracy, Political accomodation in segmented societies, Toronto, MacRae, 1974. In Italia la tematica è stata successivamente sviluppata da Luigi GRAZIANO in “Compromesso storico e democrazia consociativa. Verso una nuova democrazia?”, in AA.VV., La crisi italiana, Torino, Einaudi, 1979, vol. II; e poi da Alessandro PIZZORNO, in “Le difficoltà del consociativismo” in ID., Le radici della politica assoluta, Milano, 1993, pp.285-313. Alain Rouquié annovera questa forma politico-sociale alle situazioni di “democrazia non concorrenziale”: Alain ROUQUIE, “Analyse des élections non-concurrentielles” in Des élections pas comme les autres, PUF, 1986. Una realtà non concorrenziale era sicuramente il contesto italiano nel quale si è diffuso il ricorso all’impiego del termine “consociativismo” o “consociazione”, per indicare una pratica d’associazione alla spartizione e cogestione del potere estesa anche all’opposizione in assenza di possibilità d’alternanza. Il Pci come la Dc erano dei partiti capaci d’esprimere potenza sociale accumulata e capacità d’egemonia. La consociazione raggiunse il suo apice come corollario del “compromesso storico” ma poi sopravvisse alla sua crisi e si autonomizzò. Privata d’orpelli ideologici essa divenne una pura pratica di spartizione del potere (tra il 1975 e il 1991, il 93% dei progetti di legge furono approvati in concertazione nelle commissioni parlamentari, per accordo tra Dc e Pci, senza essere passati per le Camere) e delle risorse, pubbliche e occulte, a livello locale e nazionale (accesso comune al sistema delle tangenti come fonte di finanziamento indistinto della maggioranza e dell’opposizione).
7. Ci si riferisce a Palmiro Togliatti, Segretario generale del Komintern negli anni trenta, e del Pci dalla Liberazione alla sua morte (1964). L’idea di “governare anche dall’opposizione”, di realizzare un riformismo senza potere, cioè da una posizione politica subordinata, e che rappresentava in qualche modo il marchio di origine della Repubblica italiana, fu l’adattamento togliattiano allo schema bipolare che riproduceva una ripartizione delle influenze dentro la società.
8. La cultura di sinistra, grazie alle improvvise vocazioni “marxiste” provocate dalla caduta del fascismo e diluite nell’ecumenismo nazional-popolare di marca togliattiana, aveva raccolto l’eredità di gran parte dell’intellighenzia di formazione crociana o gentiliana, compresa tutta la covata frondista del fascismo d’ispirazione “bottaiana”. (Giuseppe Bottai era ministro della Cultura Popolare, minculpop, del regime fascista).
9. Questo nuovo soggetto “non rispetta nessuna delle regole dello sciopero conosciute, ne inventa anzi nuove. Come lo sciopero a “fischietto”, in cui a un segnale convenuto il lavoro viene interrotto senza preavviso (storicamente questo metodo di lotta è stato anche chiamato gatto selvaggio)”. In Nanni BALESTRINI, Primo MORONI, L’orda d’oro, Milano, Sugarco edizioni, 1988, p. 67.
10. Un governo monocolore democristiano presieduto da Fernando Tambroni, sorretto dall’appoggio esterno del Msi, ebbe la fiducia del Parlamento. La scelta da parte del Msi di tenere il suo congresso in una città della Resistenza come Genova serviva per misurare la reazione del paese a una apertura all’estrema destra. Fu un insurrezione. Dieci lavoratori uccisi in manifestazioni di strada; il rinvio del congresso del Msi, l’esplodere di manifestazioni in più città, la caduta del governo Tambroni e la sua sostituzione con il governo Fanfani, “leader” della sinistra democristiana, furono il risultato della mobilitazione popolare.
11. Per tre giorni e tre notti, il 7, 8, 9 luglio 1961, in un susseguirsi di scontri durissimi tra manifestanti e forze di polizia affluite in massa da diverse città e regioni limitrofe, la sede torinese della Uil fu accerchiata dai lavoratori che protestavano contro un accordo separato firmato da quel sindacato d’ispirazione socialdemocratica con la direzione Fiat nel tentativo di sabotare lo sciopero contrattuale che aveva bloccato l’intera città di Torino.
12. Questi mutamenti della composizione di classe furono osservati e analizzati con grande acutezza dalla scuola operaista, nata agli inizi degli anni 70. La scuola operaista ebbe il pregio di rivitalizzare e rinnovare l’analisi marxista della società italiana rattrappita sotto il peso dell’egemonia idealista diffusa dalla vulgata nazionalpopolare di scuola togliattiana. La culla dell’operaismo furono i Quaderni Rossi, rivista fondata a Torino da Raniero Panzieri, esponente della sinistra Psi, vicino alle posizioni di Rodolfo Morandi, già direttore di Mondo Operaio. Dopo i fatti di Piazza Statuto, all’interno dei Quaderni Rossi si produsse una rottura tra quanti ritenevano maturi i tempi per un intervento autonomo nelle lotte operaie e quanti invece intendevano continuare a svolgere una prevalente attività di ricerca sociologica (Panzieri, Alquati, Rieser). Nel 1964 nasceva Classe Operaia, mensile politico degli operai in lotta che conduceva un nuovo tipo di ricerca parallelo al “lavoro politico” nel tentativo di definire gli strumenti d’intervento contro il “piano capitalistico”. Classe Operaia, raccogliendo la precedente esperienza di Cronache Operaie, aveva unificato una serie di fogli d’intervento politico locale: Cronache Operaie di Quaderni Rossi e Gatto Selvaggio (Torino), Potere Operaio (Milano), Classe Operaia (Genova), Potere Operaio (Marghera-Venezia). All’interno di Classe Operaia presero forma tre tendenze che sfociarono in una decisiva rottura nel ‘66: la prima, che voleva collocare l’ipotesi operaista nel tessuto del Movimento operaio storico, dentro il Pci (Alberto Asor Rosa, Massimo Cacciari, Mario Tronti, Rita Di Leo). Posizione che sfociò all’inizio degli anni 70 nella teorizzazione dell’”autonomia del politico”; la seconda, a dominanza neo-leninista, che scelse l’opzione dell’intervento nel movimento reale, dando vita a “Potere Operaio” locale, in area veneto-emiliana, è nel ‘69 cofondatrice de La Classe e subito dopo di “Potere Operaio” nazionale. A Toni Negri, che aveva fatto l’esperienza dei Quaderni Rossi e di Classe Operaia, si aggiunsero Enzo Grillo e Gaspare De Caro, Luciano Ferrari Bravo, Sergio Bologna, Franco Piperno e Oreste Scalzone, e molti quadri operai, come Augusto Sbrogiò e Italo Finzi e tanti altri). Per un breve periodo vi fu un tentativo di coesistenza e ricerca teorica comune in Contropiano. La terza tendenza di matrice marxiano-libertaria, animata da Gianfranco Faina e [?]Dellacasa (che ruppero fin dal ‘64), Riccardo D’Este e Gianni Armaroli, diede vita a “l’Organizzazione Consiliare” e “Commontismo”. Fortemente influenzata dal consiliarismo, da “Socialisme ou Barbarie” e dall’Internazionale situazionista, fu al centro del ‘68 genovese, ebbe un peso importante a Torino ed ebbe uno sbocco organizzativo in Ludd-Consigli proletari.
13. Una sintesi corredata da documenti è presente in Nanni BALESTRINI, Primo MORONI, L’orda d’oro, cit. cap. VI, p. 177-190.
14. I primi Cub si formano verso la primavera ‘68 nella lotta contro le gabbie salariali, che dividevano la classe in zone territoriali e in categorie diverse, e nella rivendicazione della riforma del sistema pensionistico. Un altro elemento interessante è il nuovo tipo di rapporto politico costruito col movimento degli studenti che entrano a far parte dei Cub con pari dignità dei militanti operai. Gli studenti non restano più fuori dei cancelli ma diventano parte integrante della elaborazione della strategia di lotta anticapitalista. La fabbrica si apre all’esterno e l’esterno entra in fabbrica, producendo uno scambio di saperi e di esperienze che daranno luogo a un alto livello di maturità politica.
15. “Più salario e meno orario”, per ridurre lo sfruttamento.
16. In Italia, d’altra parte, non si realizzò mai un vero Welfare, un Sozial-Staat, un État providence, negli anni del “compromesso fordista” del dopoguerra.
17. Nanni BALESTRINI racconta, attraverso la testimonianza di uno di questi operai, come la loro generazione si renda padrona del proprio destino, sconvolgendo i metodi e le culture precedenti; vedi, di Balestrini, Noi vogliamo tutto!, Milano, Feltrinelli, 1971.
18. J.M. Keynes (1883-1946), economista inglese. La sua teoria, che ha contraddistinto tutta la fase espansiva dello sviluppo capitalistico dal dopoguerra fino alla metà degli anni 70, prevedeva il rilancio economico attraverso l’accrescimento della domanda effettiva, sostenuta con politiche statali d’investimento e finanziamento di lavori pubblici, redistribuzione e allargamento del reddito per incrementare il consumo interno e dunque la produzione. Il controllo del sistema bancario, della Cassa per il Mezzogiorno e di alcuni ministeri (Lavori pubblici, Partecipazioni statali, Agricoltura, Industria, Poste e Telecomunicazioni) forniva alla Democrazia cristiana e ai suoi alleati un immenso serbatoio di risorse per poter gestire l’elargizione di finanziamenti e redditi sulla base dello scambio occulto: accesso al reddito e alle risorse pubbliche in cambio di consenso elettorale e politico; patto con i ceti industriali del nord e i grossi gruppi monopolistici, cresciuti in un contesto di economia protetta e sovvenzionata.
19. Sergio BOLOGNA, La tribù delle talpe, Milano, Feltrinelli, 1978.
20. Idem.
21. A partire dal 1969 fino a oltre la metà degli anni 70, l’Italia è vittima di una serie di attentati dinamitardi, nelle stazioni, sui treni e nelle piazze. Citiamo qui quelli più cruenti: 12 dicembre 1969, una bomba esplode all’interno della sede di Milano della Banca Nazionale dell’Agricoltura, situata in piazza Fontana (16 morti e 88 feriti); 22 luglio 1970, Gioia Tauro, un treno, la Freccia del Sud, viene fatto deragliare (6 morti e 50 feriti); 31 maggio 1972, Peteano, un’autobomba esplode contro una pattuglia di carabinieri (3 morti e un ferito); 22 ottobre 1972, una catena di attentati è organizzata contro treni e linee ferroviarie per impedire la grande manifestazione operaia a Reggio Calabria, organizzata dalle confederazioni sindacali per riconquistare l’agibilità politica nella città controllata dalle bande fasciste protagoniste della rivolta municipale per “Reggio capoluogo”; 28 maggio 1974, un ordigno esplode in Piazza della Loggia a Brescia durante un comizio sindacale (8 morti e 94 feriti); 4 agosto 1974, San Benedetto val di Sambro, sul treno Italicus (linea Firenze-Bologna) esplode l’ennesima bomba (12 morti e 105 feriti); 2 agosto 1980, Bologna, stazione centrale, una bomba di enorme potenza distrugge la “sala d’attesa” della 2a classe: 85 morti, 177 feriti. Emerse subito il ruolo di depistaggio realizzato dai servizi e la copertura politica fornita dai governi. Nel corso dei venti anni successivi, decine e decine d’indagini giudiziarie non hanno mai fornito risultati soddisfacenti. La fine del conflitto bipolare ha consentito la riapertura di alcuni dossier, grazie a un accesso più libero alla documentazione riservata; è emerso così il ruolo primario giocato da alcuni ambienti Nato nell’ideazione e nella organizzazione della “strategia della tensione” finalizzata a una “stabilizzazione moderata” dell’Italia.
22. Slogan, inventato da Lotta continua, che individuava lo storico leader e notabile democristiano Amintore Fanfani come punto di riferimento di una svolta autoritaria.
23. Sergio BOLOGNA, La tribù delle talpe, cit.
24. Nell’aprile 1978 si svolse il congresso di fondazione di Democrazia proletaria.
25. Op. cit.
26. Dalla metafora di Plauto “homo homini lupus”, ripresa da Hobbes, alla citazione di Matteo, XL, 12, “il Regno dei Cieli soffre violenza, e i violenti se ne impossessano” – cosa che fa dire a Hobbes “il regno di Dio si ottiene con la violenza” (Leviatano, XV) – i riferimenti storico-letterari in materia sono numerosi. Per attenerci ai soli teorici della politica più conosciuti, ancora una volta Hobbes (Leviatano, XIII: “la guerra non consiste solamente nella battaglia e nel combattimento effettivo, ma in quello spazio di tempo in cui la volontà di affrontarsi in battaglia è sufficientemente concreta […] si deve tener conto nella natura della guerra della nozione di durata […] allo stesso modo la natura della guerra non consiste in un combattimento effettivo, ma in una disposizione concreta, che va in questo senso, fintanto che non c’è certezza del contrario”. Per Machiavelli, Marx, von Clausewitz (per il quale “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi”), Lenin e Schmitt, l’assenza di ostilità non è che una neutralizzazione provvisoria del conflitto. Per alcuni la guerra sussiste in modo permanente, come carattere della natura umana (da Machiavelli alla teoria delle pulsioni aggressive di Freud); per altri si manifesta – come regolatore ultimo dei rapporti sociali – in due forme: una latente, a bassa intensità (guerra di posizione); l’altra nella forma dichiarata (guerra classica) o del conflitto aperto (guerra sociale).
27. Secondo un calcolo fatto da Cesare BERMANI in, Il nemico interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), Roma, Odradek, 1997, pp. 308-313, nel periodo che va dal 1945 alla fine dell’80 sono stati uccisi dalla polizia nel corso di manifestazioni, scioperi e rivolte 200 dimostranti. 26 sono state le vittime subite da polizia e carabinieri, di cui ben 18 uccisi nell’insurrezione di Ragusa del gennaio 1945.
28. Gli anni che vanno dal 1977 al 1980 sono caratterizzati dai ripetuti divieti di manifestare che perdurano per lunghi mesi. Le manifestazioni pubbliche del “movimento” nella gran parte dei casi non sono autorizzate. Le autoconvocazioni hanno un carattere immediatamente illegale (si veda la morte di Giorgiana Masi, giovane militante femminista, uccisa il 12 maggio 1977 a Roma con un colpo sparato – come sostenuto da gran parte della stampa – da agenti di polizia in borghese). Nella memoria delle generazioni che hanno traversato quegli anni resta viva l’immagine della polizia dispiegata nelle strade e delle autoblindo che presidiavano le piazze.
29. “La violenza non appartiene alla patologia, ma alla fisiologia del sistema democratico-capitalistico reale (come a quella di ogni altro sistema e di ogni organismo vivente)”, Emanuele SEVERINO, Sistema traballante, violenza fisiologica (dopo gli attentati terroristici), Corriere della Sera, 3 marzo 1993.
 «Cara Rossanda, a proposito del tuo corsivo Perché non sono più garantista, alcune obiezioni.
«Cara Rossanda, a proposito del tuo corsivo Perché non sono più garantista, alcune obiezioni.




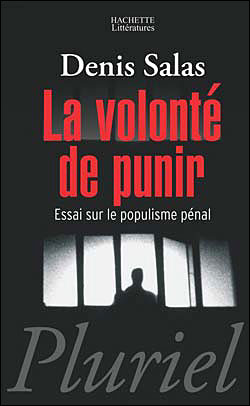
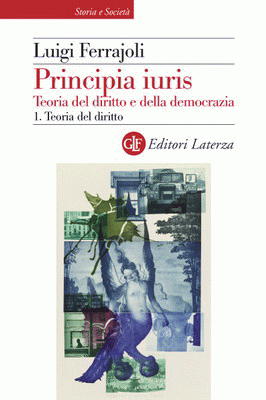



 domanda generata dalle rapide forme di sviluppo del capitalismo italiano. Il vecchio operaio professionale, a forte spessore ideologico, dotato di una memoria storica legata alla Resistenza, si fuse progressivamente con la nuova figura dell’«operaio massa». I nostri «arabi» alla Fiat erano loro, con la differenza che essi possedevano una carta d’identità italiana e non erano dunque sottomessi al ricatto dell’espulsione, e inoltre potevano comunicare alla catena di montaggio con lo stesso medium linguistico. Questa «rude razza pagana», massa arrabbiata di giovani meridionali sottratta al tradizionale controllo della Chiesa esercitato nelle campagne, incontrò la scuola della lotta di classe nelle fabbriche del nord e la tradizione del sovversivismo rivoluzionario della Resistenza. S’innescò così una miscela esplosiva(
domanda generata dalle rapide forme di sviluppo del capitalismo italiano. Il vecchio operaio professionale, a forte spessore ideologico, dotato di una memoria storica legata alla Resistenza, si fuse progressivamente con la nuova figura dell’«operaio massa». I nostri «arabi» alla Fiat erano loro, con la differenza che essi possedevano una carta d’identità italiana e non erano dunque sottomessi al ricatto dell’espulsione, e inoltre potevano comunicare alla catena di montaggio con lo stesso medium linguistico. Questa «rude razza pagana», massa arrabbiata di giovani meridionali sottratta al tradizionale controllo della Chiesa esercitato nelle campagne, incontrò la scuola della lotta di classe nelle fabbriche del nord e la tradizione del sovversivismo rivoluzionario della Resistenza. S’innescò così una miscela esplosiva(
 stagione degli anni 60, sotto la spinta di un clima internazionale caratterizzato dallo sviluppo di numerosi «movimenti di liberazione nazionale», anticolonialisti e antimperialisti, di fronte all’effervescenza teorica e ideologica legata alla nascita o alla ripresa di diverse scuole marxiste, aveva visto formarsi numerosi gruppi e organismi marxisti-leninisti, operaisti, trotzkisti, consiliaristi, situazionisti, bordighisti, anarchici e maoisti. Il ‘68 e sopratutto l’offensiva operaia del ‘69, danno vita a un nuovo «ceto politico» che si struttura nella decisione di fondare l’«organizzazione rivoluzionaria». Ha origine così un’inflazione di «partitini» in rivalità aperta sullo stesso terreno sociale e nello stesso spazio politico. Le ragioni della loro rapida ascesa e soprattutto della folgorante caduta sono molteplici e complesse; un nodo decisivo fu certamente quello che venne a costituirsi verso la metà degli anni 70. La radicalizzazione estrema delle lotte sociali aveva generato, per effetto anche del «compromesso storico», una unipolarizzazione dello spazio politico. Il ventaglio delle opzioni strategiche percorribili si era assai ridotto. La rottura violenta, l’approfondimento di un tragitto radicalmente sovversivo – linea che al tempo stesso teorizzava e assecondava una spinta sociale violenta, di rottura, proveniente dal basso, dalle fabbriche e dalle periferie urbane – fu il progetto, l’elemento di demarcazione e di selezione (che si manifestò in forme diverse e concorrenziali), scelto dalle formazioni che intendevano ancora proseguire un percorso politico autonomo, non subalterno e incisivo. Il Collettivo politico metropolitano (a partire dalla quale nasceranno le Br) sarà il primo a intraprendere in modo risolutivo questa strada; qualche anno dopo, sull’onda dell’occupazione di Mirafiori del 1973 sarà la volta di Potere operaio, che aveva già una importante struttura di «lavoro illegale» attiva fin dai primi momenti degli anni 70. Lotta continua, il gruppo con più forte séguito di massa, resta invece lacerata da un contrasto di fondo. Una linea che radicalizza lo scontro, sostenuta dalla frazione operaia e da parte del servizio d’ordine – attratti dalla scelta combattente – si oppone a quella del gruppo dirigente che, una volta superate le oscillazioni del ‘72-’73, spinge per trasformare il movimento in partito, teorizzando l’ingresso nell’area istituzionale. Lotta continua traverserà una lunga crisi che si concluderà con il suo scioglimento nell’autunno del 1976. I maoisti di Servire il popolo, l’organizzazione-sètta, una struttura tra le più burocratiche e verticali degli anni 70 (essa programmava la vita dei suoi militanti, la morale, persino i comportamenti sessuali), con un certo séguito proletario nel meridione, si sfalderà sotto l’insorgenza della «nuova soggettività militante»(
stagione degli anni 60, sotto la spinta di un clima internazionale caratterizzato dallo sviluppo di numerosi «movimenti di liberazione nazionale», anticolonialisti e antimperialisti, di fronte all’effervescenza teorica e ideologica legata alla nascita o alla ripresa di diverse scuole marxiste, aveva visto formarsi numerosi gruppi e organismi marxisti-leninisti, operaisti, trotzkisti, consiliaristi, situazionisti, bordighisti, anarchici e maoisti. Il ‘68 e sopratutto l’offensiva operaia del ‘69, danno vita a un nuovo «ceto politico» che si struttura nella decisione di fondare l’«organizzazione rivoluzionaria». Ha origine così un’inflazione di «partitini» in rivalità aperta sullo stesso terreno sociale e nello stesso spazio politico. Le ragioni della loro rapida ascesa e soprattutto della folgorante caduta sono molteplici e complesse; un nodo decisivo fu certamente quello che venne a costituirsi verso la metà degli anni 70. La radicalizzazione estrema delle lotte sociali aveva generato, per effetto anche del «compromesso storico», una unipolarizzazione dello spazio politico. Il ventaglio delle opzioni strategiche percorribili si era assai ridotto. La rottura violenta, l’approfondimento di un tragitto radicalmente sovversivo – linea che al tempo stesso teorizzava e assecondava una spinta sociale violenta, di rottura, proveniente dal basso, dalle fabbriche e dalle periferie urbane – fu il progetto, l’elemento di demarcazione e di selezione (che si manifestò in forme diverse e concorrenziali), scelto dalle formazioni che intendevano ancora proseguire un percorso politico autonomo, non subalterno e incisivo. Il Collettivo politico metropolitano (a partire dalla quale nasceranno le Br) sarà il primo a intraprendere in modo risolutivo questa strada; qualche anno dopo, sull’onda dell’occupazione di Mirafiori del 1973 sarà la volta di Potere operaio, che aveva già una importante struttura di «lavoro illegale» attiva fin dai primi momenti degli anni 70. Lotta continua, il gruppo con più forte séguito di massa, resta invece lacerata da un contrasto di fondo. Una linea che radicalizza lo scontro, sostenuta dalla frazione operaia e da parte del servizio d’ordine – attratti dalla scelta combattente – si oppone a quella del gruppo dirigente che, una volta superate le oscillazioni del ‘72-’73, spinge per trasformare il movimento in partito, teorizzando l’ingresso nell’area istituzionale. Lotta continua traverserà una lunga crisi che si concluderà con il suo scioglimento nell’autunno del 1976. I maoisti di Servire il popolo, l’organizzazione-sètta, una struttura tra le più burocratiche e verticali degli anni 70 (essa programmava la vita dei suoi militanti, la morale, persino i comportamenti sessuali), con un certo séguito proletario nel meridione, si sfalderà sotto l’insorgenza della «nuova soggettività militante»( dell’intera istituzione sociale, di ogni relazione di potere, avevano prodotto una situazione preinsurrezionale. La risposta alle aggressioni brutali della polizia aveva permesso di verificare la possibilità della violenza collettiva. A quel punto essa fu considerata come inevitabile e propria delle epoche rivoluzionarie. Per alcuni gruppi divenne l’atto costitutivo della propria azione politica. In ogni caso essa partecipò alla radicalizzazione delle forme di lotta. Potere contro potere, a lungo andare è la forza che decide. Non sarebbe necessario ritornare ai classici della teoria politica(
dell’intera istituzione sociale, di ogni relazione di potere, avevano prodotto una situazione preinsurrezionale. La risposta alle aggressioni brutali della polizia aveva permesso di verificare la possibilità della violenza collettiva. A quel punto essa fu considerata come inevitabile e propria delle epoche rivoluzionarie. Per alcuni gruppi divenne l’atto costitutivo della propria azione politica. In ogni caso essa partecipò alla radicalizzazione delle forme di lotta. Potere contro potere, a lungo andare è la forza che decide. Non sarebbe necessario ritornare ai classici della teoria politica(