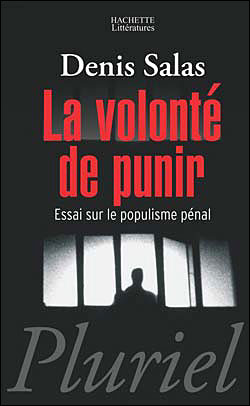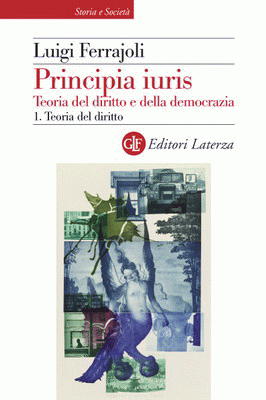«Basta con la parodia del perdono», è il titolo di un intervento di Claudio Magris apparso sul Corriere della sera del 9 settembre 2011. «Si tratta di una scelta della coscienza – spiega l’illustre germanista – che per definizione non può essere pubblica, messa in mostra davanti alle televisioni come accade sempre più di questi tempi».
L’altro importante assunto contenuto nell’articolo afferma che il funzionamento della macchina giudiziaria non può ruotare attorno alla presenza del perdono, esercitando clemenza se questo viene concesso oppure severità se viene a mancare. «E’ inutile coinvolgere i familiari delle vittime – conclude Magris – non spetta a loro fare giustizia».
Non possiamo che salutare positivamente questa presa di posizione da parte di una delle firme più prestigiose del maggiore quotidiano italiano. Tuttavia c’è qualcosa nell’argomentare del professore dell’università di Trieste che lascia trapelare una sottile perfidia.
L’intero ragionamento di Magris è sbilanciato sulla questione del perdono, lasciando in ombra il problema della vendetta. D’altronde il tema del perdonismo sembra essere una delle sue ossessioni: nell’arco degli ultimi 9 anni Magris ha scritto ben tre articoli sul Corriere della sera praticamente identici: il primo del 31 luglio 2002, «Il perdono così facile e vuoto», in risposta ad un intervento di Marrina Corradi sull’Avvenire; il secondo dal titolo «L’arte difficile di chiedere scusa», del 16 dicembre 2007, dove si fustigavano lo «spirito del tempo, il tic mediatico: tutti i risvolti di un atteggiamento mentale sempre più diffuso», legati appunto alla moda della perdonanza che va di pari passo con la repentence esibita in forma quasi narcisistica.
Questa asimmetria tra perdono e vendetta sembra voler suggerire che ci sia in giro una dilagare della clemenza, un eccesso di perdonanza che sta soffocando la giustizia. Ora il paradosso sta proprio nell’esatto contrario.
E’ vero che si parla fin troppo di perdono ovunque, come giustamente documenta Magris, ma lo si fa solo per negarlo. Il vero tema di oggi è infatti il vendettismo.
Quando si chiama in causa con tanta fretta, sciatteria e superficialità un sentimento religioso tanto delicato, profondo e complesso, qual’è il perdono, con tutte le implicazioni che esso racchiude anche nella sua economia narcisistica («Chi perdona si pone al di sopra del perdonato. Assurge ad una posizione etica che lo sormonta facendo mostra di una superiore gerarchia morale. L’odio e la vendetta al contrario pongono allo stesso livello del colpevole», ricorda lo stesso Magris in uno dei suoi articoli linkati), lo si fa per istigare sentimenti esattamente opposti.
L’analisi di Magris perde la sua consuetà sottigliezza e non s’accorge che la tematica del perdono è emersa pubblicamente come risvolto del pentimento, termine improprio, imbastardito, perché utilizzato per definire la condotta dei «collaboratori di giustizia».
Un cinico scambio realizzato in nome della ragion di Stato sul mercato della giustizia penale tra chi vende chiamate di correo, accuse contro terzi, de relato ed altre dichiarazioni utili a costruire ipotesi d’accusa e teoremi di colpevolezza e chi, in cambio, offre indulgenza penale e carceraria. Un comportamento che sul terreno strettamente morale in altre epoche veniva qualificato come delatorio ed ora è diventato invece prova di ravvedimento.
Le procedure istituzionali introdotte dalla legislazione premiale dell’emergenza che hanno codificato, in varie forme e gradi, la collaborazione e il ravvedimento (per intenderci l’ampio ventaglio che va dalla collaborazione piena e totale alla dissociazione), prevedevano per l’appunto “atti pubblici di repentance”: dai documenti alle interviste nelle quali si dovevano declamare il riconoscimento dei propri errori, la natura paradigmatica del male compiuto, agli incontri sollecitati e organizzati dentro le carceri, e via via in modo sempre più pubblico all’esterno, con quei familiari di persone colpite che si rendevano disponibili (perché mossi e in qualche modo strumentalizzati) dalla loro matrice cristiana.
Perdonismo e pentimento figli della ragion di Stato
Il nodo dunque non sta, come suggerisce semplicisticamente Magris, in una sorta di diabolica furberia degli individui sottoposti a condanna ma nel sistema penale speciale instaurato a partire dalla fine degli anni 70 e nella cultura giudiziaria che da allora ha formato migliaia di magistrati.
Il processo di privatizzazione della giustizia, la critica al sistema eccessivamente «reocentrico» del processo penale e dell’escuzione penale, sono i fenomeni che hanno rimesso al centro la vittima, o i suoi familiari, facendone i nuovi arbitri del sistema penale.
In realtà il processo a cui abbiamo assitito a partire dagli anni 90 del secolo scorso è ancora più perfido: il sistema giudiziario usa il paradigma vittimario per legittimarsi. Sulle spalle delle vittime, o dei loro familiari (e qui le parole di Magris, lì dove spiega che un familiare colpito non può essere considerato una proprietà come una macchina, sono esemplari) grava la ragione morale che giustifica l’inasprimento delle pene, la vessazione sui corpi dei rei.
Una delega dietro la quale si cela una comoda deresponsabilizzazione della magistratura. La controprova viene quando i familiari hanno chiesto di sottrarsi a questa trappola, (vedi l’atteggiamento di Sabina Rossa) chiedendo ai magistrati, alle leggi e alla Stato di fare integralmente la propria parte.
E’ lì che un sistema perfettamente congeniato salta.
Quando i familiari si sottraggono, non al perdonismo ma al vendettismo, d’improvviso perdono centralità. La magistratura non li ascolta più. Il re è nudo.
Recentemente una detenuta politica condannata all’ergastolo, e che nel frattempo aveva scontato tre decenni di carcere, ha ottenuto la liberazione condizionale dopo reiterati rifiuti da parte della magistratura di sorveglianza. La condizione posta perché l’accesso a questa misura fosse possibile non era una valutazione del percorso trentennale della detenuta, l’assenza di pericolosità sociale, le mutate condizioni storico-politiche, ma l’incontro con una vittima, una persona ferita nel corso di una delle azioni realizzate dall’organizzazione in cui aveva militato tra gli anni 70-80.
L’episodio è avvenuto in presenza di una “commissione conciliatrice” composta da funzionari ed esperti del ministero della Giustizia che operano nel campo della cosiddetta mediazione penale.
La scena descritta nella stessa ordinanza redatta dai giudici ha assunto toni da melodramma: i due che si parlano e si abbracciano davanti al giury che osserva soddisfatto. Ci mancava l’applauso e il brindisi riconciliatorio.
La teatralizzazione del perdono e delle scuse (o delle spiegazioni), la messa in scena di un qualcosa che, semmai ha un senso, non può che averlo in una sfera non pubblica, meno che mai sotto lo sguardo censorio dei professionisti della correzione.
Insomma una pantomima che si prende gioco dei sentimenti delle persone colpite e dei prigionieri sottoposti ad umilianti cerimonie di degradazione simbolica.
Questa, caro Magris, è la parodia del perdono ed è tutta opera dello Stato.
Basta con la parodia del perdono
Claudio Magris
Corriere della sera 9 settembre 2011
Si racconta che, durante una guerra civile in Messico, alcuni rivoltosi volessero fucilare un sacerdote, pretendendo però che questi, prima dell’esecuzione, li assolvesse dal peccato che stavano per commettere. Vero o falso, l’aneddoto indica quanto siano radicati nell’animo umano sia la, violenza sia il bisogno di sentirsi perdonati, innocenti, lavati dalla colpa – magari per accingersi poco dopo, col cuore tranquillo, a un’altra azione malvagia.
Anche le cose e i valori più sacri, come il perdono, possono diventare un’empia parodia, quando vengono ostentati con superficiale e oltraggiosa vacuità. Già anni fa alcuni giornalisti avevano sferzato una mania che dilagava negli organi di informazione: appena un tabaccaio, un benzinaio, un gioielliere o chi altro ancora veniva assassinato da un rapinatore, ci si precipitava a chiedere ai genitori o ai figli della vittima se perdonavano l’uccisore del loro caro, magari non ancora catturato o identificato.
La forza di perdonare, di non lasciarsi imprigionare e oscurare dall’odio e dalla vendetta, è un valore altissimo, rivela ima libertà pure dalle più sacrosante pulsioni emotive, che dà senso e dignità alla persona. Tuttavia il perdono è un fatto esistenziale e morale che riguarda soltanto la coscienza di un individuo e il rapporto fra una vittima e il suo persecutore. Non interessa l’opinione pubblica, non è e non dovrebbe essere una notizia e soprattutto non riguarda la legge né i rapporti fra il colpevole e la società.
Dinanzi a un omicidio, la legge non ha né da perdonare né da far vendette; il suo compito consiste nel ricostruire il fatto, qualificarlo giuridicamente, valutarne le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e comminare la pena. La giustizia non ha certo da considerare un assassino con maggior benevolenza perché è stato perdonato dai congiunti della sua vittima né con maggior severità perché questi ultimi chiedono vendetta. Far assistere ad esempio i parenti di un assassinato all’esecuzione dell’assassinò, come accade in alcuni degli Stati Uniti, declassa la giustizia a vendetta.
Ma c’è un’altra ragione che rende ambigua e regressiva questa smania – che ora sembra riprendere vigore, specie alla televisione – di chiedere alla gente, se perdona l’uccisore di un figlio, di un genitore, di un fratello. Si può perdonare solo in nome proprio, per torti fatti a noi, non ad altri, neppure se ci sono cari come la vita. Non siamo i proprietari dei nostri cari, non possiamo decidere per loro. Siamo padroni della nostra automobile: se qualcuno ce la sfascia possiamo – se lo crediamo – perdonarlo e rinunciare a chiedergli un risarcimento. Ma un figlio, una madre, una sorella, un amico non ci appartengono come una macchina; se qualcuno arreca loro violenza, li fa soffrire, li tortura o li uccide, possiamo – e dobbiamo – rinunciare a vendicarci direttamente e personalmente, ma non possiamo certo «perdonare» (che in qualche modo vuol dire assolvere) chi ha ucciso non noi, ma lui o lei.
Soltanto la vittima ha il diritto di perdonare, anche se talora non può più farlo perché la sua vita è stata spenta.
Il perdono di un omicidio che ha colpito la propria famiglia caratterizza le arcaiche società tribali e sopravvive nella società mafiosa, perché in quelle culture è la «famiglia» – in senso stretto o traslato – che conta, non il singolo individuo, il quale le appartiene ed è appunto considerato una sua proprietà. L’omicidio diviene allora un danno, ancorché ingente, subito dalla «famiglia» e, come tale, può essere perdonato mercé un adeguato risarcimento.
La civiltà – almeno la nostra – si fonda invece sul valore insopprimibile, irripetibile e insostituibile del singolo individuo, di ogni individuo; sul suo inalienabile diritto alla dignità e alla vita, la cui infrazione non può essere «perdonata» da nessun altro.
Chiedere, pubblicamente, a chi soffre la morte di una persona amata se perdona o no chi l’ha uccisa è una pacchiana sfacciataggine, che viola il senso della legge e offende l’autentica, non sbandierabile pietà del perdonare.
Link sul paradigma vittimario
De Luna: Andare oltre il paradigma vittimario
Paradigma vittimario e giustizia internazionale
Quando la memoria uccide la ricerca storica
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Una storia politica dell’amnistia
Storia e giornate della memoria
Il nuovo pantheon del martirologio tricolore
Uso penale del paradigma vittimario
La liberazione condizionale e la lettera scarlatta
Populismo penale e vittimismo
Retoriche vittimarie e talk show
Sabina rossa e gli ex-terroristi: siano liberi senza il sì di noi vittime (Corriere della sera)
Sabina Rossa, “Cari brigatisti confrontiamoci alla pari”
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili

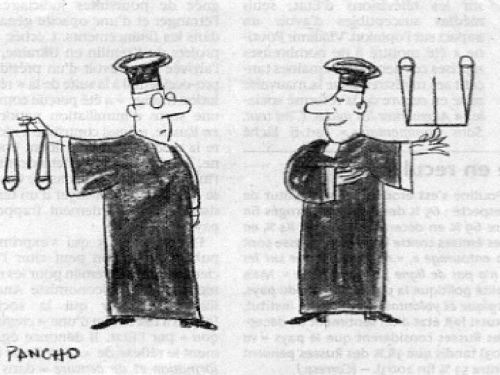



 Dal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.
Dal vecchio penso dunque sono cartesiano siamo passati al più prosaico ho paura dunque esisto. Sembra quasi d’essere tornati ad uno dei precetti dell’empirismo che riduceva l’essere alla sua capacità di percepire, esse est percipi. Secondo questa scuola filosofica la realtà non ha vita in sé, non prescinde dalla nostra capacità percettiva ma esiste soltanto per il mezzo della nostra conoscenza. La percezione non è dunque lo strumento che ci consente di entrare in relazione con la realtà circostante ma ciò che l’inventa, la costruisce, la crea. Da qui il passo molto breve verso una concezione meramente soggetivistica del mondo.