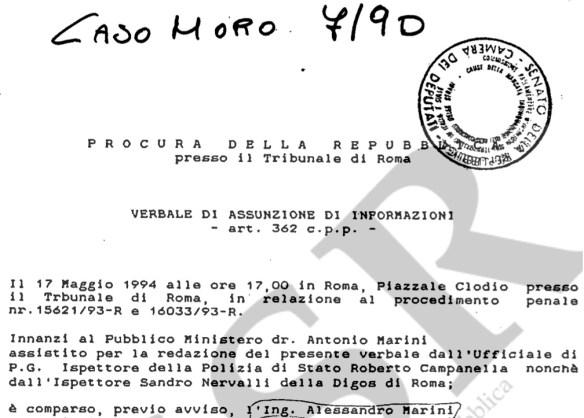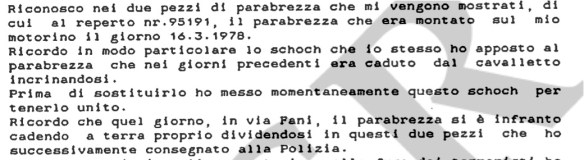«Noi non c’entriamo, la divisa non ha colpa». L’excusatio non petita del maresciallo dei carabinieri che portò alla madre di Stefano Cucchi la notizia del decesso del figlio suona oggi come una confessione manifesta, soprattutto dopo la pubblicazione della telefonata (potete ascoltare l’audio qui e leggere qui) in cui l’ex moglie di uno dei carabinieri che arrestò Cucchi (rimasto sempre coperto nel corso delle passate indagini) rinfaccia all’ex congiunto (che non pagava gli alimenti e la cui cifra umana si può ricavare dal tenore della telefonata. Questi tutori dell’ordine una volta tolta la divisa si sciolgono come maschere d’argilla) le sue confidenze su quel che accadde in caserma quella notte: «di quanto vi eravate divertiti a picchiare quel drogato di merda».
Il ruolo avuto dai carabinieri nella vicenda, seppure solo oggi sostanziato da elementi di prova che all’epoca non vennero cercati, non è una novità. La dinamica dei fatti emergeva abbastanza chiaramente già all’epoca quando l’autorità giudiziaria, a cui vennero affidate le indagini, supportata dall’allora ministro della Difesa La Russa, fece di tutto per tenere i militi dell’Arma fuori dall’inchiesta nonostante il ruolo da questi avuto nell’arresto e nella “gestione” del fermato durante un’intera notte. Ripubblichiamo la recensione al libro che Stefania Cucchi ha scritto insieme a Giovanni Bianconi, in cui si avanzava chiaramente questo scenario.
A Stefano, come recita la canzone di De André, non l’uccise la morte ma chi volle cercargli l’anima a forza di botte. Pestato brutalmente per farlo “cantare”, per estorcergli informazioni sullo spaccio, la rete di fornitori, il nascondiglio dove teneva la merce da vendere. Sottoposto ad una tortura spicciola, fatta da personale esaltato e incapace di applicare quella “economia dello sforzo” che si richiede in una tortura di livello profesionale, utilizzata in altre fasi e livelli di indagine. La scoperta fatta dai famigliari nei giorni successivi alla sua morte di una discreta quantità di stupefacienti nella casa dove Stefano abitava, sconosciuta ai carabinieri, rese evidente fin da allora il movente del brutale trattamento che gli venne riservato.
Gli indizzi c’erano già tutti, dal 118 chiamato quando Cucchi era ancora in una cella di sicurezza di una stazione dei carabinieri, alle condizioni fisiche in cui si trovava all’arrivo nelle celle dei sotterranei del tribunale di piazzale Clodio, ben prima del suo ingresso in carcere.
In questi anni abbiamo assistito ad uno scarica barile: l’apparato più forte ha scaricato la patata bollente su quello più debole, così la polizia penitenziaria si è ritrovata sul banco degli accusati; questi a loro volta hanno fatto di tutto per lasciare con il cerino in mano il personale medico-infermieristico del centro clinico penitenziario dell’ospedale Pertini.
Un ingranaggio dove ogni rotella dello Stato ha giocato la sua parte di responsabilità. E se oggi abbiamo la certezza che a pestare Cucchi furono dei carabinieri (non c’è solo l’audio registrato a D’Alessandro ma anche altre prove documentali, come la falsificazione di un registro, il ruolo giocato dal comandante della stazione dei CC, alcune ammissioni fatte su quel che accadde quella notte), nessun altro apparato ne esce pulito.
Tutti sono coinvolti per l’indifferenza, la superficialità, il cinismo, altre dosi di botte aggiunte alle precedenti e l’omertà dimostrata (basti ricordare le allusive rimostranze di un noto sindacato della penitenziaria che ben sapeva quali erano le condizioni di Cucchi al momento della consegna nelle loro mani… Ma alla penitenziaria conveniva denunciare i carabinieri che poi per ritorsione avrebbero potuto ficcare il naso in quel che avviene quotidianamente nelle carceri?).
La regola è un’altra: ogni apparato nasconde i suoi panni sporchi in famiglia. Si chiama etica dello Stato! Quella che piace tanto ai legalitari.
Il libro di Ilaria Cucchi sulla morte del fratello Stefano: «Nessuno deve più morire in un carcere o in una caserma». Ostacoli e retroscena su una verità che fa paura alle istituzioni. Vorrei dirti che non eri solo. Storia di Stefano mio fratello, Rizzoli 2010
Paolo Persichetti
Liberazione 22 ottobre 2010
«Noi non c’entriamo, la divisa non ha colpa». Si congeda con queste parole il maresciallo dei carabinieri che aveva portato alla madre di Stefano Cucchi la notizia del decesso del figlio, esattamente un anno fa nel reparto penitenziario dell’ospedale Sandro Pertini. Non una imbarazzata frase di circostanza ma l’annuncio di una programmatica impunità. L’episodio è rivelato da Stefania Cucchi nel libro scritto insieme al giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, Vorrei dirti che non eri solo. Storia di Stefano mio fratello, Rizzoli. Di frasi del genere in questa terribile storia che racconta l’oscenità del potere che si impossessa dei corpi, se ne trovano altre, come quella pronunciata da un’altro uomo in divisa davanti al reparto dove Cucchi è morto, «Ci sono tutte le carte a disposizione. Se volete potete controllare, noi siamo tranquilli». L’accesso alle carte sarà invece un percorso labirintico, per nulla spontaneo, dovuto unicamente all’attenzione politico-mediatica accesa sul caso dalla pubblicazione delle foto del corpo straziato di Stefano sul tavolo dell’obitorio e dalla caparbietà della famiglia costretta a rinunciare all proprio lutto privato. Le denunce pubbliche innescheranno una doppia inchiesta, parlamentare e amministrativa, arrivando lì dove l’indagine penale da sola non sarebbe mai giunta senza tuttavia dissolvere le molte ombre. L’autoassoluzione preventiva appartiene alle caratteristiche peculiari delle burocrazie repressive. E’ parte del patto tacito stipulato con le gerarchie in cambio della fedeltà e dei servizi prestati, spesso inconfessabili. Non a caso a sancire l’irresponsabilità è arrivato anche il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Franco Ionta, che a conclusione dell’inchiesta ministeriale affermava, «Gli accertamenti amministrativi hanno rilevato fin qui l’assenza di responsabilità da parte della polizia penitenziaria», nonostante l’indagine interna redatta dal numero due del Dap, Sebastiano Ardita, traesse ben altre considerazioni. «Quando ho potuto leggerla – afferma Ilaria Cucchi – mi sono resa conto che si stava tentando di celare perfino quanto scoperto dalle stesse istituzioni».  A fargli compagnia le dichiarazioni preventive del ministro della Difesa Ignazio La Russa in favore dell’Arma dei carabinieri, quando le indagini erano ancora al punto di partenza, e la sortita ignobile del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al lotta contro le tossicodipendenze, Carlo Giovanardi, per il quale Cucchi se l’era cercata. In questa gara all’esportazione delle responsabilità non è stata da meno neanche la Asl competente per territorio sull’ospedale Pertini, che appena dieci giorni dopo il trasferimento in via cautelare reintegrava il personale sanitario indagato. Eppure nei sei giorni che l’hanno separato dall’arresto fino all’ultimo respiro Stefano Cucchi non ha fatto altro che passare di mano da una divisa e l’altra attraverso caserme, camere di sicurezza, carceri, reparti penitenziari di ospedali. In realtà le divise e i camici, inquadrati da altre divise, nella sua morte c’entrano eccome. «In tutte le tappe che hanno visto Stefano Cucchi imbattersi nei vari servizi di diversi organi pubblici, emerge una incredibile continuativa mancata risposta alla effettiva tutela dei diritti», afferma il rapporto interno del Dap che riassume così il calvario del giovane: «Assenza di comprensione del disagio, mancata assistenza ai bisogni, trattazione burocratica della tragica vicenda personale e in alcuni casi assenza del comune senso di umanità, si sono susseguiti in un modo probabilmente non coordinato e con condotte indipendenti fra loro, ma con inesorabile consequenzailità». Il tutto condito da tante violenze, prima durante e dopo, testimoniate da un corpo fratturato e pieno di ematomi. A Cucchi, come recita la canzone di De André, non l’uccise la morte ma chi volle cercargli l’anima a forza di botte. Il libro è la testimonianza dolorosa del percorso di una famiglia legata a valori tradizionali, «religione, legge e ordine», che proprio per questo scopre il tradimento delle istituzioni in cui ha sempre creduto. Una presa di coscienza che fa dire a Ilaria, “sorella coraggio”, di aver sentito dire in giro che la morte del fratello fa parte di quegli incidenti «inevitabili conseguenze di pratiche e comportamenti che servono a tutelare la sicurezza della collettività. Forse anch’io, un tempo, mi sarei lasciata andare a cose simili ma oggi so che sono inaccettabili. Perché non ci può essere un motivo valido per cui un ragazzo debba morire in un carcere o in una caserma. Non deve accadere, né deve accadere che l’opinione pubblica lo giustifichi come uno sgradevole inconveniente». Ad Ilaria e alla famiglia diciamo una cosa sola: non vi lasceremo mai soli.
A fargli compagnia le dichiarazioni preventive del ministro della Difesa Ignazio La Russa in favore dell’Arma dei carabinieri, quando le indagini erano ancora al punto di partenza, e la sortita ignobile del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al lotta contro le tossicodipendenze, Carlo Giovanardi, per il quale Cucchi se l’era cercata. In questa gara all’esportazione delle responsabilità non è stata da meno neanche la Asl competente per territorio sull’ospedale Pertini, che appena dieci giorni dopo il trasferimento in via cautelare reintegrava il personale sanitario indagato. Eppure nei sei giorni che l’hanno separato dall’arresto fino all’ultimo respiro Stefano Cucchi non ha fatto altro che passare di mano da una divisa e l’altra attraverso caserme, camere di sicurezza, carceri, reparti penitenziari di ospedali. In realtà le divise e i camici, inquadrati da altre divise, nella sua morte c’entrano eccome. «In tutte le tappe che hanno visto Stefano Cucchi imbattersi nei vari servizi di diversi organi pubblici, emerge una incredibile continuativa mancata risposta alla effettiva tutela dei diritti», afferma il rapporto interno del Dap che riassume così il calvario del giovane: «Assenza di comprensione del disagio, mancata assistenza ai bisogni, trattazione burocratica della tragica vicenda personale e in alcuni casi assenza del comune senso di umanità, si sono susseguiti in un modo probabilmente non coordinato e con condotte indipendenti fra loro, ma con inesorabile consequenzailità». Il tutto condito da tante violenze, prima durante e dopo, testimoniate da un corpo fratturato e pieno di ematomi. A Cucchi, come recita la canzone di De André, non l’uccise la morte ma chi volle cercargli l’anima a forza di botte. Il libro è la testimonianza dolorosa del percorso di una famiglia legata a valori tradizionali, «religione, legge e ordine», che proprio per questo scopre il tradimento delle istituzioni in cui ha sempre creduto. Una presa di coscienza che fa dire a Ilaria, “sorella coraggio”, di aver sentito dire in giro che la morte del fratello fa parte di quegli incidenti «inevitabili conseguenze di pratiche e comportamenti che servono a tutelare la sicurezza della collettività. Forse anch’io, un tempo, mi sarei lasciata andare a cose simili ma oggi so che sono inaccettabili. Perché non ci può essere un motivo valido per cui un ragazzo debba morire in un carcere o in una caserma. Non deve accadere, né deve accadere che l’opinione pubblica lo giustifichi come uno sgradevole inconveniente». Ad Ilaria e alla famiglia diciamo una cosa sola: non vi lasceremo mai soli.
Sulla stessa vicenda
Ilaria Cucchi denuncia: “Nel processo veniamo trattati come fossimo imputati”
Morte violenta di Stefano Cucchi due nuovi testimoni accusano i carabinieri
Caso Cucchi, avanza l’offensiva di chi vuole allontanare la verità
Cucchi, anche la polizia penitenziaria si autoassolve
Stefano Cucchi: le foto delle torture inferte. Rispondi La Russa
Caso Cucchi, scontro sulle parole del teste che avrebbe assistito al pestaggio. E’ guerra tra apparati dello Stato sulla dinamica dei fatti
Erri De Luca risponde alle infami dichiarazioni di Carlo Giovanardi sulla morte di Stefano Cucchi
Caso Cucchi: Carlo Giovanardi, lo spacciatore di odio
Morte di Cucchi, c’e chi ha visto una parte del pestaggio nelle camere di sicurezza del tribunale
Stefano Cucchi, le foto shock
Stefano Cucchi, le ultime foto da vivo mostrano i segni del pestaggio. Le immagini prese dalla matricola del carcere di Regina Coeli
Manconi: “sulla morte di Stefano Cucchi due zone d’ombra”
Stefano Cucchi, quella morte misteriosa di un detenuto in ospedale
Stefano Cucchi morto nel Padiglione penitenziario del Pertini, due vertebre rotte e il viso sfigurato
Violenza di Stato non suona nuova
Caso Stefano Cucchi: “Il potere sui corpi è qualcosa di osceno”
Cucchi, il pestaggio provocò conseguenze mortali