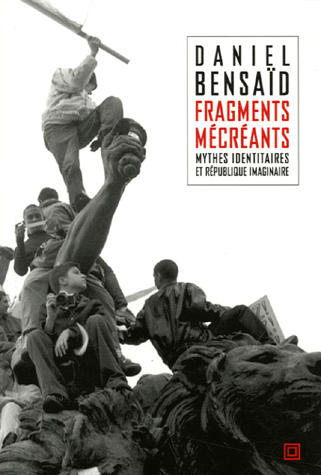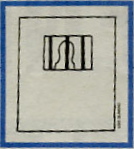Il teorico dello scontro di civiltà è morto all’età di 81 anni
Guido Caldiron
Liberazione 28 dicembre 2008
Samuel Huntington, il politologo americano autore de Lo scontro delle civiltà è morto alla vigilia di Natale nell’isola di Martha’s Vineyard nello stato del Massachusetts a 81 anni. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dall’Università di Harvard, l’ateneo dove aveva insegnato da quando aveva 23 anni. Nato ideologicamente nel gruppo degli allievi di Leo Strauss a cui si deve la nascita del movimento dei neoconservatori, Huntington aveva però preso progressivamente distanza dai neocon,  elaborando una propria visione delle relazioni internazionali che considera centrale “la cultura” dei popoli. Nell’era della globalizzazione trionfante, Huntington insinuava così il dubbio sulla reale possibilità di un “lieto fine” per i processi di mondializzazione e offriva un nuovo proflio ideologico alla rivoluzione conservatrice che si apprestava ad investire l’intero Occidente. «Alcuni occidentali hanno sostenuto che l’Occidente non ha alcun problema con l’Islam, ma solo con gli estremisti islamici violenti. Millequattrocento anni di storia dimostrano tuttavia il contrario. I rapporti tra Islam e cristianesimo sono stati spesso burrascosi. Per entrambi, la parte opposta ha sempre rappresentato “l’altro” (…) Le cause di questa costante conflittualità non vanno ricercate in feno meni transitori quali il fervore cristiano del XII secolo o il fondamentalismo musulmano del XX, bensì nella natura stessa di queste due religioni e delle civiltà su di esse fondate, nelle loro differenze e nelle loro similitudini». Perciò, «una guerra planetaria che coinvolga gli stati guida delle maggiori civiltà del mondo è altamente improbabile ma non impossibile. Un simile conflitto potrebbe scaturire dall’escalation di una guerra (locale) tra musulmani e non musulmani». Era il 1996 quando Samuel Phillips Huntington proponeva questa lettura delle future relazioni internazionali alla luce di una netta contrapposizione tra ciò che definiva come “Islam” e “Occidente”. L’11 settembre non c’era ancora stato, l’amministrazione statunitense – quella guidata da George W. Bush – non aveva ancora dichiarato la “guerra permanente al terrorismo”, il dibattito internazionale ruotava in larga misura intorno alle promesse annunciate dal pieno dispiegarsi dei processi di globalizzazione. Eppure, era proprio muovendo da un’analisi del “nuovo” mondo globalizzato, che questo docente di Harvard – stimato specialista di studi strategici e direttore del John T. Olin Institute for Strategic Studies – aveva pubblicato, già nel 1993, sulla rivista da lui fondata, Foreign Affairs, un articolo intitolato “The Clash of Civilizations?” che sarebbe poi stato sviluppato nell’omonimo saggio edito dall’importante editore Simon and Schuster e tradotto in tutto il mondo (la prima edizione italiana del libro uscì nel 1997 per Garzanti). Da allora, le tesi di Huntington che annunciavano come possibile, prossimo e in qualche misura inevitabile lo “scontro di civiltà” tra gli occidentali e i musulmani – i primi rappresentati come i depositari della filosofia dei diritti dell’uomo e i secondi più o meno come dei “barbari” – hanno non solo caratterizzato il dibattito politico e culturale internazionale, ma, come una sorta di terribile profezia, sono apparse come il drammatico annuncio di quanto poi si è concretamente verificato. Questo almeno in apparenza. In realtà, Lo scontro delle civiltà è diventato la bandiera dietro la quale buona parte delle culture di destra dell’Occidente hanno ridefinito la propria identità. Dalla dottrina neoconservatrice sbarcata alla Casa Bianca fin dalla prima elezione di Bush figlio alla guida degli Stati Uniti nel 2000, ai tanti paladini dell’identità occidentale apparsi negli ultimi anni in Europa, da Oriana Fallaci a Pym Fortuyn, solo per citare due esempi, tutti sembrano aver fatto proprie le parole di Huntington. Così, come sottolineato da Mondher Kilani, docente di Atropologia culturale dell’Università di Losanna, in Niente sarà più come prima (Medusa, 2002): «Sono parecchi i commentatori occidentali che, dopo l’11 settembre, hanno tenuto a
elaborando una propria visione delle relazioni internazionali che considera centrale “la cultura” dei popoli. Nell’era della globalizzazione trionfante, Huntington insinuava così il dubbio sulla reale possibilità di un “lieto fine” per i processi di mondializzazione e offriva un nuovo proflio ideologico alla rivoluzione conservatrice che si apprestava ad investire l’intero Occidente. «Alcuni occidentali hanno sostenuto che l’Occidente non ha alcun problema con l’Islam, ma solo con gli estremisti islamici violenti. Millequattrocento anni di storia dimostrano tuttavia il contrario. I rapporti tra Islam e cristianesimo sono stati spesso burrascosi. Per entrambi, la parte opposta ha sempre rappresentato “l’altro” (…) Le cause di questa costante conflittualità non vanno ricercate in feno meni transitori quali il fervore cristiano del XII secolo o il fondamentalismo musulmano del XX, bensì nella natura stessa di queste due religioni e delle civiltà su di esse fondate, nelle loro differenze e nelle loro similitudini». Perciò, «una guerra planetaria che coinvolga gli stati guida delle maggiori civiltà del mondo è altamente improbabile ma non impossibile. Un simile conflitto potrebbe scaturire dall’escalation di una guerra (locale) tra musulmani e non musulmani». Era il 1996 quando Samuel Phillips Huntington proponeva questa lettura delle future relazioni internazionali alla luce di una netta contrapposizione tra ciò che definiva come “Islam” e “Occidente”. L’11 settembre non c’era ancora stato, l’amministrazione statunitense – quella guidata da George W. Bush – non aveva ancora dichiarato la “guerra permanente al terrorismo”, il dibattito internazionale ruotava in larga misura intorno alle promesse annunciate dal pieno dispiegarsi dei processi di globalizzazione. Eppure, era proprio muovendo da un’analisi del “nuovo” mondo globalizzato, che questo docente di Harvard – stimato specialista di studi strategici e direttore del John T. Olin Institute for Strategic Studies – aveva pubblicato, già nel 1993, sulla rivista da lui fondata, Foreign Affairs, un articolo intitolato “The Clash of Civilizations?” che sarebbe poi stato sviluppato nell’omonimo saggio edito dall’importante editore Simon and Schuster e tradotto in tutto il mondo (la prima edizione italiana del libro uscì nel 1997 per Garzanti). Da allora, le tesi di Huntington che annunciavano come possibile, prossimo e in qualche misura inevitabile lo “scontro di civiltà” tra gli occidentali e i musulmani – i primi rappresentati come i depositari della filosofia dei diritti dell’uomo e i secondi più o meno come dei “barbari” – hanno non solo caratterizzato il dibattito politico e culturale internazionale, ma, come una sorta di terribile profezia, sono apparse come il drammatico annuncio di quanto poi si è concretamente verificato. Questo almeno in apparenza. In realtà, Lo scontro delle civiltà è diventato la bandiera dietro la quale buona parte delle culture di destra dell’Occidente hanno ridefinito la propria identità. Dalla dottrina neoconservatrice sbarcata alla Casa Bianca fin dalla prima elezione di Bush figlio alla guida degli Stati Uniti nel 2000, ai tanti paladini dell’identità occidentale apparsi negli ultimi anni in Europa, da Oriana Fallaci a Pym Fortuyn, solo per citare due esempi, tutti sembrano aver fatto proprie le parole di Huntington. Così, come sottolineato da Mondher Kilani, docente di Atropologia culturale dell’Università di Losanna, in Niente sarà più come prima (Medusa, 2002): «Sono parecchi i commentatori occidentali che, dopo l’11 settembre, hanno tenuto a  ricordare l’origine occidentale dei diritti dell’uomo, contribuendo così (…) a sostenere la profezia autorealizzantesi della tesi di Huntington sullo “scontro di civiltà”. Una tesi che, come è noto, ha la particolarità di scambiare la conseguenza (i conflitti e le contraddizioni che risultano da rapporti di forza storici e congiunturali) con la causa (una irriducibilità di valori tra l'”Occidente cristiano” e il “mondo arabo-musulmano”)». Le tesi di Huntington, un conservatore vicino ma non assimilabile tout-court all’ambiente neocon americano, hanno così finito per assumere il significato di una via d’uscita da destra di fronte alla crisi dello Stato-nazione e all’avvento dell’era globale. «La mia ipotesi – spiegava infatti l’autore di Lo scontro delle civiltà – è che la fonte di conflitto fondamentale nel mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell’umanità saranno legate alla cultura (…) I conflitti più importanti avranno luogo tra gruppi di diverse civiltà». Questo perché – aggiungeva Huntington – nel mondo post-Guerra fredda, la cultura è una forza al contempo disgregante e aggregante. Popolazioni divise dall’ideologia ma culturalmente omogenee vengono a unificarsi, come hanno fatto le due Germanie (…) Società unite dall’ideologia o da circostanze storiche ma appartenenti a differenti civiltà finiscono viceversa con lo sgretolarsi, com’è accaduto all’Unione Sovietica». La rinascita identitaria, le tendenze comunitaristiche, “la rivincita di Dio” – come lo stesso Huntington definiva il prepotente ritorno della religione nella politica e nella sfera pubblica di molte società – più che essere presentate come altrettante possibili derive assunte dall’umanità in una condizione di crisi, diventavano la risposta alle trasformazioni introdotte dalla globalizzazione. Al punto che lo scienziato politico di Harvard annunciava già all’epoca quelli che sarebbero stati i temi delle sue riflessioni successive, raccolti nel 2004 in La nuova America. Le sfide della società multiculturale (pubblicato in Italia da Garzanti nel 2005), un violento manifesto
ricordare l’origine occidentale dei diritti dell’uomo, contribuendo così (…) a sostenere la profezia autorealizzantesi della tesi di Huntington sullo “scontro di civiltà”. Una tesi che, come è noto, ha la particolarità di scambiare la conseguenza (i conflitti e le contraddizioni che risultano da rapporti di forza storici e congiunturali) con la causa (una irriducibilità di valori tra l'”Occidente cristiano” e il “mondo arabo-musulmano”)». Le tesi di Huntington, un conservatore vicino ma non assimilabile tout-court all’ambiente neocon americano, hanno così finito per assumere il significato di una via d’uscita da destra di fronte alla crisi dello Stato-nazione e all’avvento dell’era globale. «La mia ipotesi – spiegava infatti l’autore di Lo scontro delle civiltà – è che la fonte di conflitto fondamentale nel mondo in cui viviamo non sarà sostanzialmente né ideologica né economica. Le grandi divisioni dell’umanità saranno legate alla cultura (…) I conflitti più importanti avranno luogo tra gruppi di diverse civiltà». Questo perché – aggiungeva Huntington – nel mondo post-Guerra fredda, la cultura è una forza al contempo disgregante e aggregante. Popolazioni divise dall’ideologia ma culturalmente omogenee vengono a unificarsi, come hanno fatto le due Germanie (…) Società unite dall’ideologia o da circostanze storiche ma appartenenti a differenti civiltà finiscono viceversa con lo sgretolarsi, com’è accaduto all’Unione Sovietica». La rinascita identitaria, le tendenze comunitaristiche, “la rivincita di Dio” – come lo stesso Huntington definiva il prepotente ritorno della religione nella politica e nella sfera pubblica di molte società – più che essere presentate come altrettante possibili derive assunte dall’umanità in una condizione di crisi, diventavano la risposta alle trasformazioni introdotte dalla globalizzazione. Al punto che lo scienziato politico di Harvard annunciava già all’epoca quelli che sarebbero stati i temi delle sue riflessioni successive, raccolti nel 2004 in La nuova America. Le sfide della società multiculturale (pubblicato in Italia da Garzanti nel 2005), un violento manifesto 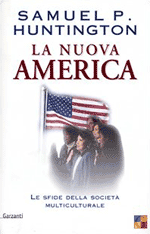 contro il modello del melting pot statunitense e in particolare contro l’emergere della presenza degli immigrati “latinos” negli Usa. «La cultura occidentale – si poteva leggere in Lo scontro delle civiltà – è minacciata da gruppi operanti all’interno delle stesse società occidentali. Una di queste minacce è costituita dagli immigrati provenienti da altre civiltà che rifiutano l’assimilazione e continuano a praticare e propagare valori, usanze e culture delle proprie società d’origine. Questo fenomeno prevale soprattutto tra i musulmani in Europa, che sono, comunque, una piccola minoranza, ma è presente anche, in minor misura, tra gli ispanici degli Stati Uniti, che invece sono una minoranza molto nutrita». Le “civiltà” poste da Huntington al centro della sua riflessione rappresentano perciò entità definite, stabili e connotate secondo criteri pressoché “etnici”, al punto che la frontiera che lui stesso fa correre tra occidentali e musulmani conosce poi il suo doppio all’interno di ogni società tra gli “autoctoni” e gli “stranieri”. «Il politologo di Harvard – spiega a questo riguardo Annamaria Rivera, etnologa dell’Università di Bari e autrice di La guerra dei simboli (Dedalo, 2005) – propone, attraverso nozioni totalizzanti come quella di civiltà, una configurazione dei rapporti di forza internazionali basata su rigide linee di frattura culturalreligiose. Nella “cattiva antropologia” di Huntington, le “civiltà” sono viste come universi compatti, autonomi, irriducibili potenzialmente o effettivamente ostili l’uno all’altro; i rapporti del
contro il modello del melting pot statunitense e in particolare contro l’emergere della presenza degli immigrati “latinos” negli Usa. «La cultura occidentale – si poteva leggere in Lo scontro delle civiltà – è minacciata da gruppi operanti all’interno delle stesse società occidentali. Una di queste minacce è costituita dagli immigrati provenienti da altre civiltà che rifiutano l’assimilazione e continuano a praticare e propagare valori, usanze e culture delle proprie società d’origine. Questo fenomeno prevale soprattutto tra i musulmani in Europa, che sono, comunque, una piccola minoranza, ma è presente anche, in minor misura, tra gli ispanici degli Stati Uniti, che invece sono una minoranza molto nutrita». Le “civiltà” poste da Huntington al centro della sua riflessione rappresentano perciò entità definite, stabili e connotate secondo criteri pressoché “etnici”, al punto che la frontiera che lui stesso fa correre tra occidentali e musulmani conosce poi il suo doppio all’interno di ogni società tra gli “autoctoni” e gli “stranieri”. «Il politologo di Harvard – spiega a questo riguardo Annamaria Rivera, etnologa dell’Università di Bari e autrice di La guerra dei simboli (Dedalo, 2005) – propone, attraverso nozioni totalizzanti come quella di civiltà, una configurazione dei rapporti di forza internazionali basata su rigide linee di frattura culturalreligiose. Nella “cattiva antropologia” di Huntington, le “civiltà” sono viste come universi compatti, autonomi, irriducibili potenzialmente o effettivamente ostili l’uno all’altro; i rapporti del  cosiddetto Occidente con altre aree, paesi e culture sono rappresentati nei termini dell’opposizione fra the West and the Rest». Sono “mondi chiusi”, impenetrabili, quelli che secondo Huntington sono destinati ad incrociarsi solo per l’inevitabile clash. In questo quadro, si può leggere ancora ne Lo scontro delle civiltà , «il vero problema per l’Occidente non è il fondamentalismo islamico, ma l’Islam in quanto tale, una civiltà diversa le cui popolazioni sono convinte della superiorità della propria cultura e ossessionate dallo scarso potere di cui dispongono. Il problema dell’Islam non è la Cia o il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ma l’Occidente (…) Sono questi gli ingredienti di base che alimentano la conflittualità tra Islam e Occidente». Perciò, come suggerisce il sociologo afro-britannico Paul Gilroy nel suo Dopo l’impero (Meltemi, 2006), «vecchie questioni coloniali tornano in gioco quando i conflitti geopolitici vengono declinati come una battaglia tra civiltà omogenee». Così Gilroy paragona il celebre libro di Huntington al Saggio sull’ineguaglianza delle razze pubblicato a metà dell’Ottocento dal conte de Gobineau e considerato come il testo fondante il razzismo moderno. «Nonostante le molte differenze – spiega il sociologo -, entrambi gli autori condividono la preoccupazione per le dinamiche di mutua repulsione delle civiltà e le disastrose conseguenze dei tentativi di incrocio. Gobineau identificò il pericolo mortale per le civiltà in ogni deviazione dalla “omogeneità necessaria alla loro vita” (…) Huntington specifica lo stesso tipo di problema, geopolitico e scientifico-razziale, sotto forma aforistica, nell’idioma contemporaneo del multiculturalismo e della globalità».
cosiddetto Occidente con altre aree, paesi e culture sono rappresentati nei termini dell’opposizione fra the West and the Rest». Sono “mondi chiusi”, impenetrabili, quelli che secondo Huntington sono destinati ad incrociarsi solo per l’inevitabile clash. In questo quadro, si può leggere ancora ne Lo scontro delle civiltà , «il vero problema per l’Occidente non è il fondamentalismo islamico, ma l’Islam in quanto tale, una civiltà diversa le cui popolazioni sono convinte della superiorità della propria cultura e ossessionate dallo scarso potere di cui dispongono. Il problema dell’Islam non è la Cia o il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ma l’Occidente (…) Sono questi gli ingredienti di base che alimentano la conflittualità tra Islam e Occidente». Perciò, come suggerisce il sociologo afro-britannico Paul Gilroy nel suo Dopo l’impero (Meltemi, 2006), «vecchie questioni coloniali tornano in gioco quando i conflitti geopolitici vengono declinati come una battaglia tra civiltà omogenee». Così Gilroy paragona il celebre libro di Huntington al Saggio sull’ineguaglianza delle razze pubblicato a metà dell’Ottocento dal conte de Gobineau e considerato come il testo fondante il razzismo moderno. «Nonostante le molte differenze – spiega il sociologo -, entrambi gli autori condividono la preoccupazione per le dinamiche di mutua repulsione delle civiltà e le disastrose conseguenze dei tentativi di incrocio. Gobineau identificò il pericolo mortale per le civiltà in ogni deviazione dalla “omogeneità necessaria alla loro vita” (…) Huntington specifica lo stesso tipo di problema, geopolitico e scientifico-razziale, sotto forma aforistica, nell’idioma contemporaneo del multiculturalismo e della globalità».