Libri – Alain Brossat, Scarcerare la società, Elèuthera 2003
Paolo Persichetti
N° 23 Luglio-Settembre 2005 Hortus Musicus
www.hortusmusicus.com
Sprigionare la scietà
Desincarcerer la société
 C’è un solo problema filosofico veramente serio, scriveva Camus: «il suicidio». Dal gennaio 2002 al luglio 2003 nelle carceri italiane si sono verificati 83 suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.
C’è un solo problema filosofico veramente serio, scriveva Camus: «il suicidio». Dal gennaio 2002 al luglio 2003 nelle carceri italiane si sono verificati 83 suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.
Nel sistema penitenziario, quelle che con un eufemismo sociologico vengono definite «nuove povertà» ammontano oramai a circa l’80% della popolazione reclusa. Che le prigioni fossero una purulenta sentina della società è stato scritto, detto e ribadito fino alla nausea. Un’ovvietà che suona come una vuota retorica dell’indignazione, non più udibile da chi vi è costretto a trascorrere periodi sempre più lunghi della propria esistenza. La durata della detenzione è aumentata del 50% negli ultimi quindici anni, il tasso di recidiva del 70%. L’area penale è esplosa nel corso del decennio Novanta, la popolazione carceraria è raddoppiata fino a superare le 57 mila unità, a cui vanno sommati quelli che usufruiscono delle misure alternative e scontano la loro pena nel cosiddetto «carcere diffuso» (arresti domiciliari, comunità terapeutiche, affidamento sociale in prova, semilibertà, lavoro esterno), per una somma complessiva che raggiunge le 100 mila persone, in un contesto che vede una media annua di 300 mila condanne penali.
Una parte della popolazione è predestinata a convivere con la reclusione. Guarda caso sempre la stessa: il 30% degli attuali rinchiusi sono stranieri, il 45% proviene dall’Italia meridionale. Il profilo classico è quello del giovane privo d’istruzione e con propensione alla tossicodipendenza. Chi viene dal Sud, non ha titoli di studio, appartiene ai ceti sociali più bassi. Chi arriva dai paesi d’emigrazione, vede aumentare, molto di più che nel passato, la probabilità di finire imprigionato. Il carcere rinvia ad uno degli aspetti più crudi della discriminazione di classe ed il richiamo alla legalità è la macchina ideologica che legittima e riproduce questa dominazione.
 Nuove tecnologie della pena
Nuove tecnologie della pena
Contrariamente a quanto sancito dall’art.27 della Costituzione, la pena non esercita alcuna funzione rieducativa. Mai auspicio è risultato più risibile. L’ambigua e rachitica normativa varata nei flebili anni dell’ammodernamento penitenziario di marca catto-comunista, la cosiddetta legge Gozzini, è di fatto disapplicata ed elusa. Quella riforma era viziata fin dalle origini da un’insanabile contraddizione interna, poiché l’apertura verso le nuove politiche penitenziarie, mirate al parziale reinserimento e alla ricostruzione sociale del sanzionato, seguì in parallelo il dispiegamento delle politiche differenziali dell’emergenza, trasfigurando il carcere in una sorta di commedia dantesca, dove l’inferno della differenziazione e della specialità sprofondava in gironi spettrali, all’infuori dei quali permanevano limbi, terre di nessuno, zone detentive che presagivano un possibile accesso negli Istituti purgatorio, dove la punizione s’alleviava lasciando intravedere la speranza di salire un domani in paradiso. Una scalata verso la redenzione, possibile solo dopo aver mostrato attiva cooperazione alla propria punizione, attraverso un dispositivo d’interiorizzazione della colpa che ha integrato alle tradizionali discipline di sorveglianza e controllo una nuova tecnologia fondata sull’adesione alla pena da parte del recluso. La politica carceraria non si è più accontentata di una puntigliosa presa in carico dei corpi (prehendere, prisio, prisum), ma ha scoperto «le virtù dell’uso mediatore della parola». Nel corso di alcuni incontri il detenuto è sollecitato a «fare il punto» sulla situazione, sull’evoluzione della percezione che ha dei suoi delitti e dei suoi crimini, sui suoi progetti per l’avvenire. Ad avvalersi di queste nuove strategie trattamentali sono stati quei reclusi in possesso di un maggiore capitale culturale, di una più alta perspicacia nell’uso della parola e di una superiore scaltrezza strategica, che consente loro di destreggiarsi con gli operatori trattamentali (educatori, psicologi, assistenti sociali) e il magistrato di sorveglianza, a scapito degli altri del tutto incapaci e abbandonati a se stessi, doppiamente discriminati da quegli handicap sociali e culturali che ne hanno facilitato prima l’ingresso in carcere e poi la reclusione perpetua, escludendoli una seconda volta con politiche trattamentali inaccessibili.
La successiva involuzione politica intervenuta nel corso del decennio Novanta ha reso questa critica ai balbettii del riformismo carcerario un lusso superfluo. Il sovraffollamento e le nuove politiche repressive hanno spolpato la Gozzini, introducendo nuove e sempre più articolate eccezioni, moltiplicando i «reati ostativi» (quelli inclusi nel 4 bis) per i quali le misure alternative, oltre ad essere ritardate, vengono rese praticamente impossibili. Gli anni dell’oppio giudiziario e della bulimia penale hanno riportato in auge il principio dell’incompressibilità della pena, una nenia che ha cullato le nuove generazioni di giudici di sorveglianza. E così il carcere è tornato a svolgere, anche nei discorsi degli specialisti della correzione, quella cruda funzione sociale per cui era nato.
Il «sentimento d’insicurezza»
Il carcere non redime, la prigione non corregge, serve solo a confinare dietro spesse mura di cinta problemi e contraddizioni che l’ipocrisia collettiva preferisce rimuovere. L’economia del castigo è ormai diventata una «tecnica d’invisibilizzazione dei problemi sociali». Siamo nuovamente di fronte a quell’assunto iniziale duramente combattuto negli anni Settanta: la modernità non ha saputo escogitare altre risposte al delitto diverse dall’internamento. Il carcere è via via emerso come la soluzione più semplice ed economica al disordine sociale diffuso. L’ideologia penitenziaria è così divenuta uno dei pilastri della cultura politica contemporanea che, non riuscendo più a far vivere la speranza, ha fatto della paura e dell’angoscia uno dei suoi repertori più redditizi, nutrendo la psicologia sociale con gli impulsi più bui dell’animo umano, divenuto ostaggio del risentimento e della vendetta. Questa corrente è descritta da Loïc Wacquant (Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité, Agone, Paris 2004). come un groviglio confuso di sentimenti che intrecciano la paura per l’avvenire, l’ossessione per il declino sociale e l’angoscia di non poter trasmettere il proprio status sociale ai figli, a causa di una competizione per titoli e posti sempre più incerta e sfrenata.
Questa insicurezza sociale e mentale, diffusa e multiforme, colpisce direttamente le famiglie delle classi popolari sprovviste del capitale culturale richiesto per accedere ai settori protetti del mercato del lavoro; essa tuttavia investe anche larghi strati delle classi medie, e i nuovi discorsi marziali dei politici e dei media sulla delinquenza la captano e la fissano sulla sola questione dell’insicurezza fisica o della minaccia criminale, ed in effetti più dell’insicurezza domina il «sentimento d’insicurezza», ovvero lo stato d’animo, la percezione sociale del disagio, divenuto uno degli indicatori statistici di maggior rilievo, capace di decidere della carriera di un ministro degli Interni e della Giustizia, o dei vertici delle forze dell’ordine. Trattandosi di una percezione sociale, ovvero di un sentimento, accade che essa sia spesso sprovvista di consistenza reale, ma risulti frutto di correnti irrazionali, di pulsioni orientate, solleticate da chi controlla i media e le fonti della comunicazione. A dominare è l’interpretazione pubblica più forte, il sentimento d’insicurezza più consono ai gruppi sociali che vedono il proprio punto di vista meglio rappresentato e veicolato.
La perdita di posti di lavoro, i licenziamenti, la disoccupazione e la precarizzazione dell’impiego, con i drammi e i disagi sociali ed esistenziali che ne conseguono per famiglie intere, non sono percepiti e assunti come aspetti di un sentimento d’insicurezza collettivo, ma vengono relegati a stati d’animo di ceti sociali specifici, colpevoli di rifiutare condizioni di lavoro che altrimenti permetterebbero di sostenere la concorrenza ed assicurare stabilità sociale e crescita economica. Non si tratta dunque di un’incertezza del futuro derivante da una nuova condizione di precarizzazione sociale, da un modello darwinista di società che dilaga, ma di un’ingiustificata volontà di conservare privilegi e vantaggi. Ecco che questa insicurezza scade a sentimento illegittimo, privo di quella dignità scientifica che gli consentirebbe d’essere rilevato dagli indicatori statistici, introducendo un dato nuovo nell’agenda politica. A suscitare allarme sono altri fenomeni, come le rapine selvagge nei villini del Nord-Est, gli attacchi nelle gioiellerie o nelle stazioni di benzina con pistole giocattolo, le rapine in banca con i taglierini. Accade così che il sentimento d’insicurezza, misurato unicamente su parametri di questa natura, risulti più elevato nelle zone urbane agiate, dove le infrazioni sono quasi inesistenti.
Appunto perché di sentimento si tratta, non d’insicurezza vera. Ma una volta propagato dai media, esso arriva a produrre un paradossale aumento dell’indice d’inquietudine persino nelle massaie dei quartieri popolari, non più preoccupate di tornare dal mercato con la busta della spesa vuota, ma di subire fantomatici assalti nelle cucine delle loro case popolari.

Da un regime di sensibilità all’altro
Si sente la perdita di un pensiero forte che sappia nuovamente rompere questa spirale, che sottoponga ad una critica spietata l’ideologia penale e rilanci un nuovo progetto politico capace d’affermare un modello di società dove l’idea della penalità non trovi più posto. «La questione non è sapere cosa fare del carcere, come migliorarlo, oppure come adeguare l’ordine penitenziario alle norme generali dello Stato di diritto, si tratta invece di domandarsi come sbarazzarsene e al più presto, perché è evidente che saremo senza dubbio considerati con repulsione e disprezzo dalle generazioni future», è quanto ci invita a fare il filosofo Alain Brossat nel suo stringato libretto, Pour en finir avec la prison, apparso in Francia nel 2002 e pubblicato nel 2003 in Italia da da Elèuthera col titolo Scarcerare la società.
L’invito a rimettere in discussione eredità di pensiero, abitudini filosofiche che pensavamo intoccabili, solleva questioni scomode e spigolose, ma forse è proprio da un diverso sguardo dei fondamenti che occorre ripartire. Ripercorrendo la genealogia della penalità, Brossat avanza una disincantata lettura dell’Illuminismo che nell’ambito del sistema delle pene si presenta con un decisivo momento di passaggio da un regime di sensibilità all’altro. Rielaborando la tesi di Norbert Elias sulla domesticazione della violenza, egli nota l’emergere di un’iperestesia sociale, ovvero l’apparizione di un «soggetto ipersensibile della nostra modernità» che non sopporta in primo luogo la propria sofferenza di fronte allo spettacolo della brutalità estrema e della crudeltà. Ciò spiegherebbe l’avvento di una sensibilità umana egocentrica più che altruista. Analisi che ci offre nuovi strumenti per comprendere meglio, per esempio, quella cosmesi linguistica che ha camuffato l’essenza di alcuni dei conflitti bellici degli ultimi anni. La «guerra etica» di Tony Blair, le ingerenze umanitarie armate, le operazioni di polizia internazionale, le occupazioni militari camuffate sotto formule come «peace making» e «peace keeping», le «bombe intelligenti», i bombardamenti «chirurgici», gli «effetti collaterali», il mito della «guerra pulita a costo zero», sono parte di un innovativo dizionario che intercetta l’inorridita sensibilità occidentale. Il paradosso di questa moderna impressionabilità sta nella presenza di un sentimento d’orrore che non mette fine alla violenza ma s’accontenta unicamente di renderla invisibile, e ciò non vale solo per le azioni ma ancor di più per il pensiero. Si è imposta insomma una paradossale indignazione selettiva che in materia penale, mostrando avversione per l’esplicita violenza dei supplizi, trae sollievo dall’internamento dei corpi sottratti alla vista, in questo modo votati all’oblio e «presto privati della pietà».
La messa in scena del supplizio
Più che celebrare una «litania del progresso», Michel Foucault, rintracciando le diverse tappe dei castighi e delle pene, dei supplizi e delle prigioni, mirava a mostrare come nella punizione fosse insita una «funzione sociale complessa» che oltrepassa il semplice ruolo repressivo. Non solo problema giuridico, dunque, conseguenza dell’applicazione del diritto, ma anche fatto pienamente politico. L’economia del castigo, secondo l’autore di Sorvegliare e punire, appartiene a quel vasto campo in cui intervengono le procedure di potere. I supplizi dell’ancien régime, più che ristabilire la giustizia, riparare un danno, avevano la funzione di riattivare il potere offrendo al popolo lo spettacolo della sofferenza. Il supplizio di Damiens, «il regicida», è uno degli esempi storici di cui ci è pervenuta traccia. Così descrive la vicenda Monsieur Alexandre André le Breton, greffier criminel du Parlement, ossia cancelliere penale della suprema corte giudiziaria, nel Précis historique annesso ai quattro volumi delle pièces originales et procedures du proces fait à Robert-François Damiens: correva l’anno 1757 e Parigi era traversata da una delle solite faide fra corona e vertici del potere togato. Mercoledì 5 gennaio, al buio, qualcuno «in fondo alle scale, presso la volta», ha sfiorato il re alla quinta costola, con un coltello; il danno è minimo, paragonabile alla puntura d’uno spillo, ma sul santo corpo del sovrano l’offesa diventa enorme. L’attentatore è Robert-François Damiens, disoccupato, già domestico in varie case, con discrete referenze e qualche anomalia. I precedenti segnalano un frenetico taciturno, curioso «frondeur» elucubrante, che parla da solo; consapevole «dell’effervescenza del suo sangue», cercava sollievo in abbondanti salassi. Parlando dell’imputato, Le Breton coniuga i verbi all’imperfetto perché «le scelerat» non appartiene più a questo mondo. Ha reso l’anima a Dio, lunedì 28 marzo, a «place de la Grève» (l’attuale place de l’Hotel de Ville), dopo un lunghissimo supplizio tecnicamente difettoso, come pare accada spesso ai pazienti condannati alla «peine d’être tirés à quattre chevaux». Non bastava la trazione dei cavalli a squartarlo, né vi sarebbero riusciti se, dopo un consulto medico, l’équipe patibolare, impugnati i coltelli, non avesse reciso qualche tendine. «Poiché accade d’ordinario che i tendini e i legamenti resistono e non cedono affatto, malgrado gli sforzi dei quattro cavalli, e anche nel caso d’un numero più grande, alla fine occorre recidere i legamenti alla giuntura delle ossa»; solo allora «i cavalli riescono a strappare via ciascuno un arto». Il supplizio durò soltanto «deux heures, lui vivant». L’arnese impiegato per l’aggressione non era idoneo a procurare ferite mortali. Scrive Franco Cordero, dal cui manuale di Procedura Penale abbiamo tratto queste citazioni: «Tra i fannulloni che frequentavano corridoi e aule giudiziarie del Palais, Damiens era diventato un fan dei signori in toga, campioni delle cosiddette “libertà gallicane”, insidiate dalla politica ministeriale; non ha complici e tanto meno mandanti, ma i Monsieurs (il cui consesso, in tali occasioni, include princes du sang e alti dignitari), indirettamente chiamati in causa, purgano i sospetti con una sentenza memorabile».

L’occultamento della pena e lo spettacolo del processo
A partire dal 18° secolo, declinata la religione della confessione ed emersa la laica fiducia nella prova, la reclusione sostituisce torture, mutilazioni, supplizi esemplari. Desacralizzata la giustizia, disincantata la procedura penale, scomparsi i delitti immaginari, raddrizzare e correggere, prima ancora di punire, diventano le parole d’ordine dell’illuminismo penale e del riformismo giudiziario. Le teorie del contratto sociale non concepiscono più il crimine come un attentato al corpo mistico del sovrano ma come una rottura del patto sociale. L’entità della punizione deve apparire allora commisurata all’infrazione commessa e soprattutto essere certa, perché possa esercitare un effetto dissuasivo.
Questa trasformazione conduce all’occultamento della punizione, alla cancellazione dello spettacolo punitivo. Il cerimoniale della pena entra nell’ombra, per diventare un’oscura pratica amministrativa, sostituita dalla pubblicità dirompente del processo e della sentenza, momenti in precedenza segreti. Il capovolgimento è radicale. Processo e condanna, prima ancora della pena, diventano lo stigma negativo che deve marcare il delinquente. L’esecuzione della sanzione sembra quasi un’ignominia supplementare che la giustizia ha vergogna di mostrare. Se ne tiene a distanza. La pena fuoriesce dal campo delle percezioni quotidiane per entrare in una dimensione astratta, sconosciuta, immaginata, non vista. L’efficacia è demandata alla sua ineluttabile fatalità, non più alla sua intensità percettibile. La certezza d’essere punito e non l’abominevole teatro, la «scène dégoûtante», viene a rappresentarne il monito. Il corpo non è più esposto ma interminabilmente recluso. «L’impressionabilità non è più legata all’effimera intensità del supplizio, alla sua illusoria esemplarità, ma fondata sulla durata». Ciò consente alla giustizia di non assumere più pubblicamente la parte di violenza che è insita nel suo esercizio. La punizione non appare più come tale perché le nuove tecniche mirano a rimettere in riga il deviante. Ma dietro la pretesa di «guarire», si rimuove in realtà l’aspetto più concreto dell’espiazione, ovvero il castigo.
L’apologetica carceraria
Nasce così un nuovo genere: l’apologetica carceraria, un edificante progetto votato al reinserimento della parte deviante della società. Con Beccaria e Bentham si dispiega un processo di razionalizzazione delle dottrine come dell’architettura punitiva non più fondato sulla degradazione dei corpi ma sulla correzione delle menti. «Non il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti»: è la citazione di un passaggio da Dei delitti e delle pene, che Brossat propone, notando come la filosofia penale illuminista inventi con la prigione una nuova fabbrica dell’inumano che viene a sostituirsi ai mattatoi del tormento, definendo il passaggio dal regime del supplizio sui corpi a quello del loro abbandono, dalla crudeltà all’insensibilità. Ma già un vecchio padre del liberalismo moderno, Benjamin Constant, metteva in guardia contro l’illusione umanitaria: «le punizioni che si sono volute sostituire alla pena di morte non sono che questa pena inflitta con minuzia, quasi sempre in maniera più lenta e dolorosa». Sparisce il boia ma aumentano i carcerieri. Finalmente nel carcere dell’Occidente moderno e opulento i detenuti non sperimentano più fame e stenti; al contrario deprimono, marciscono, si svuotano, s’immiseriscono, si suicidano appunto. Fanno della vita stessa una malattia. L’istituzione penitenziaria non uccide quasi più di propria mano, lascia uccidersi, mentre col dilagare del liberismo economico, dopo il decennio Ottanta, il numero degli incarcerati ha cominciato ad aumentare a dismisura, e le pene a lievitare senza freno. Il numero dei reati è cresciuto perché si è allargata la rosa dei comportamenti sanzionati. Il carcere si è riproposto come un’istituzione criminogena, una fabbrica della devianza che sottende la paranoica idea di una società in libertà condizionale.

Il paradigma vittimario
A questo punto Brossat segnala un’ulteriore configurazione della sensibilità, investita dal sopraggiungere del paradigma vittimario. Un processo di sostanziale neutralizzazione e depoliticizzazione della figura della vittima che, divenuta un’icona della martirologia statale, cancella «perdenti e vinti della storia». Dietro ciò emerge una nuova opinione umanitaria che, capovolgendo i presupposti della critica illuminista (circolazione libera delle idee in uno spazio pubblico autonomo dalla sfera statale e religiosa), si concepisce come baluardo avanzato della legge e dell’ordine invocando una nuova forma d’intolleranza. Ecco che senza più remore ed ipocrisie si torna ad affermare l’obiettivo unicamente afflittivo della pena. Proprio come riconosceva più di un secolo fa il sociologo Emile Durkheim: «la pena è rimasta un’opera di vendetta. Si dice che non facciamo soffrire il colpevole solo per farlo soffrire. Non è meno vero tuttavia che troviamo giusto che egli soffra», per questo non mancava di prescrivere che «la condizione penitenziaria deve essere più draconiana di quella dell’uomo libero più indigente».
La retribuzione simbolica
Il carcere non cambia. Resta il luogo in cui lo Stato regola con freddezza i suoi conti con le classi pericolose, in cui mostra senza emozioni né debolezze chi comanda, ricordando ai vinti quanto costa continuare a pretendere d’ignorare le regole del gioco. Questa sua essenza politica suggerisce allora di cambiare la nostra prospettiva d’osservazione e non guardare più alla prigione soltanto dal punto di vista dell’«opinione umanitaria», sulla base d’un approccio compassionevole che riversa la sua critica unicamente sulla sofferenza del detenuto, ma osservando il carcere come manifestazione della violenza dello Stato, luogo dell’eccezione sovrana. Esso svolge una decisiva funzione politica poiché riunisce la comunità contro colui che ha infranto le regole. La reclusione dunque rinforza il legame sociale, prepara la sicurezza futura. Ogni pena inflitta inscena una retribuzione, una restaurazione, rivestendo una funzione lenitiva per la coscienza collettiva colpita dal crimine. Non c’è riformismo penitenziario che abbia realmente insidiato questa filosofia. Allora di fronte all’abissale fallimento dell’umanesimo penale, Brossat invita a rigettare definitivamente l’inganno fondativo del carcere. La prigione non serve e la speranza che il diritto vi faccia un ingresso pieno e maturo – conclude – non ci condurrà comunque nell’era del «dopo carcere», ma solo in quella di un diritto incarcerato. Per l’intanto non è lo stato di diritto che si estende nelle prigioni ma il modello carcerale che avanza nella società, come i centri di permanenza temporanea e le nuove strutture di detenzione attenuata dimostrano.
Incarcerare il diritto o abolire il carcere?
Pensare che «per eliminare lo scandalo delle carceri sia sufficiente adeguare il loro regime interno alle norme generali dello Stato di diritto», pensare che sia sufficiente garantire il sia pur fondamentale livello minimo d’integrità e immunità della persona detenuta, per ritenere la prigione uno spazio finalmente «umanizzato» e giuridicamente corretto, oltre a rinviare ad una concezione puramente passiva dei diritti, intesi unicamente come pura tutela della persona, al pari di un organismo vegetale, muto e sprovvisto di pensiero proprio (come la flora tutelata dagli ambientalisti), mostra l’incomprensione assoluta degli effetti dell’internamento. L’ingresso in carcere provoca una degradazione giuridico-politica dell’internato, ridotto a semplice corpo. «La detenzione è la prova più radicale che ci sia di non appartenenza alla comunità civile». Il detenuto è privo di «diritti soggettivi», può rispondere con sfacciata sicumera, e tanto di timbro dell’amministrazione in calce, il vicedirettore di un istituto di pena ad un detenuto che gli chiede su quali fondamenti giuridici poggi il trattamento penitenziario che gli è riservato. Una condizione che rinvia a quella dell’ostracizzato, del bandito, dell’esiliato interno. È impensabile immaginare l’esercizio delle libertà politiche all’interno di un sistema disciplinare che considera la sanzione consustanziale, non solo alla privazione della libertà fisica, alla riduzione brutale delle possibilità di movimento, al «disciplinamento» dei corpi, al controllo dei sentimenti, delle emozioni, degli affetti, alla privazione di alcune funzioni essenziali della vita umana, ma anche al diritto di riunione e discussione.
Luogo concentrazionario per eccellenza, la prigione non prevede l’esistenza di uno «spazio pubblico» interno alla cinta muraria. Le sezioni sono strettamente separate tra loro, le celle restano chiuse per l’intera giornata, fatta eccezione per alcuni tipi d’istituti di pena. Non c’è libera circolazione, i soli luoghi d’incontro restano i passeggi durante le ore d’aria, le palestre (negli istituti che ne sono provvisti), le eventuali attività trattamentali, i luoghi di culto. La comunicazione sceglie allora flussi sotterranei, segue traiettorie carsiche, s’inabissa lungo percorsi discreti e riservati che cercano d’evitare gli occhi dell’amministrazione, servendosi dell’antico savoir-faire degli schiavi. In sostanza, l’ipotesi di una «vita attiva», per usare un’espressione arendtiana, o in altri termini, l’esercizio della cittadinanza, all’interno della quale l’individuo detenuto si trovi ad essere concepito anche come essere pensante, capace di produrre attività relazionali di tipo sociale, politico e culturale, non è in alcun momento preso in considerazione, anzi se possibile è osteggiato. Se la comunicazione tra detenuti non è formalmente vietata, salvo espliciti provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’intera macchina penitenziaria è costruita per impedirla, intercettarla, sopprimerla.
Quale può essere allora la via di fuga dall’ideologia penitenziaria? Sprigionare la società, vorremmo sentir rispondere. Ma quanti sono pronti a segare le sbarre che imprigionano la loro coscienza?
(Carcere di Mammagialla, 23 maggio 2005)
Link
Inferno carcere, un detenuto si suicida e un altro si cuce la bocca
Proteste nelle carceri: amnistia subito e abolizione delle leggi che fabbricano detenzione
Carceri, stipati come bestie: amnistia subito e abolizione delle leggi che fabbricano detenzione
Non si ferma la protesta nelle carceri italiane
Carceri è rivolta contro l’affollamento: “Amnistia”
Aumentano i detenuti mentre calano i delitti
Incarcerazioni facili, un problema italiano
Dopo le proteste torna in carcere, aggirate le garanzie processuali
Nel paese del carcere facile, il Corriere della Sera s’inventa l’ennesima polemica sulle scarcerazioni rapide
Ho paura dunque esisto
Giustizia o giustizialismo, dilemma nella sinistra
Il populismo penale una malattia democratica
Il governo della paura
Genesi del populismo penale e nuova ideologia vittimaria
Populismo penale, una declinazione del neoliberismo
L’indulto da sicurezza, il carcere solo insicurezza
Come si vive e si muore nelle carceri italiane
Prigioni i nuovi piani di privatizzazione del sistema carcerario
Carceri private il modello a stelle e strisce privatizzazioni e sfruttamento
Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto
Desincarcerer la société
Carcere, gli spettri del 41 bis



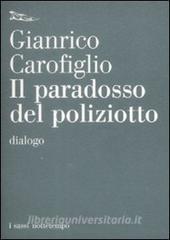 «Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».
«Il lavoro dell’investigatore, poliziotto o pubblico ministero, si colloca su una linea di confine. Da un lato ci sono delle regole, non necessariamente giuridiche, che spesso, in modo consapevole o inconsapevole, vengono violate. Ma senza le regole non c’è nessuna differenza fra guardia e ladro, tutto si riduce a una pura questione di rapporti di forza». Si tratta di uno dei passi finali del Paradosso del poliziotto, dialogo tra un giovane scrittore e un vecchio poliziotto, scritto da Gianrico Carofiglio, oggi senatore del Pd, magistrato in aspettativa e per molti anni pubblico ministero, ma soprattutto autore riconosciuto. Per Sellerio ha pubblicato I casi dell’avvocato Guerrieri, Testimone inconsapevole e L’Arte del dubbio, che potremmo definire un vero manuale sulla tecnica dell’interrogatorio. Forse in questo momento è una delle persone più adatte per aiutarci a capire cosa è successo a Stefano Cucchi, e soprattutto perché. Chi meglio di lui può sapere quel che può accadere nelle pieghe delle indagini, nel chiuso di un posto di polizia durante i momenti che seguono il fermo di un indiziato? Nel Paradosso del poliziotto fa raccontare al vecchio sbirro una scena che marca l’inizio della sua carriera, il pestaggio di un giovane appena arrestato: «quando entrai il ragazzo stava gridando, o forse piangeva. Attorno c’erano sei o sette colleghi, un paio in divisa delle volanti e tutti gli altri della mobile. Quello era seduto, ammanettato dietro la schiena. Gli davano schiaffi e pugni a turno e gli gridavano in faccia e nelle orecchie».

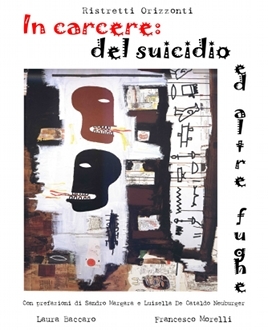

 C’è un solo problema filosofico veramente serio, scriveva Camus: «il suicidio». Dal gennaio 2002 al luglio 2003 nelle carceri italiane si sono verificati 83 suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.
C’è un solo problema filosofico veramente serio, scriveva Camus: «il suicidio». Dal gennaio 2002 al luglio 2003 nelle carceri italiane si sono verificati 83 suicidi e 25 tentati suicidi, altri 19 detenuti sono morti per cause non chiarite e 9 per overdose. Totale: 136 morti. E chi non si uccide si ammala: al 30 giugno 2003 – secondo una stima avanzata dal Forum nazionale per la tutela della salute dei detenuti e l’applicazione della riforma della medicina penitenziaria (Manifesto11 marzo 2005) – erano rinchiusi 14.507 tossicodipendenti, circa un terzo dell’intera popolazione carceraria. Tra questi, 1.737 in trattamento metadonico e 887 alcoldipendenti. Gli affetti da Hiv erano 1.473 (il 2,6% del totale), 5.000 i sieropositivi, 9.500 quelli colpiti da epatite cronica e 7.500 i reclusi con turbe psichiatriche. Gli istituti di pena sono oramai enormi lazzaretti, ospizi per derelitti, vaste discariche dove viene confinato ogni dolore e malessere sociale, nelle quali si ammassano umiliati e offesi, vite rottamate, sfigati senza speranza. Immigrati e neolumpen alienati dalla società dei consumi che promette quello stesso benessere che li esclude. Veri e propri sedotti e abbandonati dalle chimere di un capitalismo che li ha relegati ai margini.




 penitenziario si ostinano a definire – non senza un tocco di perfida ipocrisia – una normale cella penitenziaria. In gergo carcerario si chiama «cella liscia», il non plus ultra della punizione. Una cella completamente vuota, senza mobilio, senza branda, senza tubi, maniglie o qualsiasi altro oggetto o manufatto che possa svolgere funzione di appiglio. Senza finestra, con piccole feritoie al suo posto, oppure – l’immaginario del supplizio è pieno di fantasia – senza infissi, nude sbarre senza vetri e ante col freddo che d’inverno aggredisce i corpi non di rado lasciati nudi (col pretesto di non offrire vantaggi a chi avrebbe intenzione di suicidarsi), magari anche bagnati. Solo le quattro mura, il pavimento e il “blindo”, cioè una massiccia porta di ferro senza cancello che chiude la stanza. Per servizi igienici una turca piazzata in un angolo senza muretto, quando si è fortunati, altrimenti nemmeno quella. Un buco a terra oppure niente. Chi c’è finito, qualsiasi fosse il carcere dove si trovava, descrive il medesimo spettacolo rivoltante. Escrementi ovunque, urina rafferma, aria infetta, insetti. Una sentina della terra piena di graffiti tracciati con le unghie da chi in quel luogo ha trascorso dure quarantene per spurgare ataviche dipendenze dalle droghe, furie isteriche, crisi psichiatriche, oppure ha scontato ruvide punizioni. Quando finisci in un posto del genere dormi per terra, cioè su un tappeto di merda. Impari a non respirare col naso e ti stringi più che puoi, cerchi di farti piccolo, piccolo. Tutte le attuali sezioni d’isolamento dispongono ancora di una cella liscia. Eredità antica, dura a morire come quella del carcere di santa Maria Maggiore a Venezia, che, dopo il suicidio – lo scorso 6 marzo – di un marocchino di ventisei anni di nome Mohammed, ha attirato l’attenzione della magistratura. Così il nome di sei poliziotti della penitenziaria è finito nel registro degli indagati per il reato di «abuso di autorità contro persone arrestate o detenute» (698 cp). La magistratura vuole accertare se la cella liscia sia stata impiegata per ospitare momentaneamente i detenuti “nuovi giunti”, in attesa di essere assegnati in sezione, oppure se sia stata utilizzata come cella d’isolamento.
penitenziario si ostinano a definire – non senza un tocco di perfida ipocrisia – una normale cella penitenziaria. In gergo carcerario si chiama «cella liscia», il non plus ultra della punizione. Una cella completamente vuota, senza mobilio, senza branda, senza tubi, maniglie o qualsiasi altro oggetto o manufatto che possa svolgere funzione di appiglio. Senza finestra, con piccole feritoie al suo posto, oppure – l’immaginario del supplizio è pieno di fantasia – senza infissi, nude sbarre senza vetri e ante col freddo che d’inverno aggredisce i corpi non di rado lasciati nudi (col pretesto di non offrire vantaggi a chi avrebbe intenzione di suicidarsi), magari anche bagnati. Solo le quattro mura, il pavimento e il “blindo”, cioè una massiccia porta di ferro senza cancello che chiude la stanza. Per servizi igienici una turca piazzata in un angolo senza muretto, quando si è fortunati, altrimenti nemmeno quella. Un buco a terra oppure niente. Chi c’è finito, qualsiasi fosse il carcere dove si trovava, descrive il medesimo spettacolo rivoltante. Escrementi ovunque, urina rafferma, aria infetta, insetti. Una sentina della terra piena di graffiti tracciati con le unghie da chi in quel luogo ha trascorso dure quarantene per spurgare ataviche dipendenze dalle droghe, furie isteriche, crisi psichiatriche, oppure ha scontato ruvide punizioni. Quando finisci in un posto del genere dormi per terra, cioè su un tappeto di merda. Impari a non respirare col naso e ti stringi più che puoi, cerchi di farti piccolo, piccolo. Tutte le attuali sezioni d’isolamento dispongono ancora di una cella liscia. Eredità antica, dura a morire come quella del carcere di santa Maria Maggiore a Venezia, che, dopo il suicidio – lo scorso 6 marzo – di un marocchino di ventisei anni di nome Mohammed, ha attirato l’attenzione della magistratura. Così il nome di sei poliziotti della penitenziaria è finito nel registro degli indagati per il reato di «abuso di autorità contro persone arrestate o detenute» (698 cp). La magistratura vuole accertare se la cella liscia sia stata impiegata per ospitare momentaneamente i detenuti “nuovi giunti”, in attesa di essere assegnati in sezione, oppure se sia stata utilizzata come cella d’isolamento. condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.
condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.