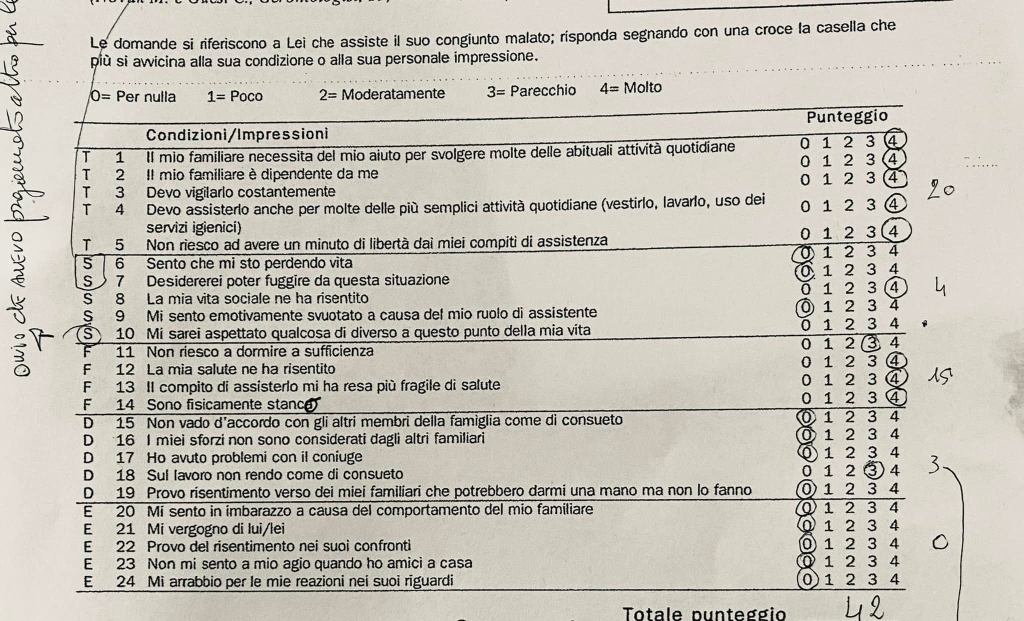Estratto dal libro La polizia della storia (pp. 173-176).
La vicenda venne raccontata per la prima volta nel giugno del 2017 dall’ex responsabile della sezione speciale antiterrorismo dei carabinieri di Roma, Domenico Di Petrillo, durante la sua audizione davanti alla seconda Commissione parlamentare che indagava sul sequestro Moro e poi riportata nel libro, scritto sempre dall’ex colonnello, Il lungo assedio al terrorismo nel diario operativo della Sezione speciale anticrimine Carabinieri di Roma, Melampo 2018. Fatto singolare la Commissione presieduta da Giuseppe Fioroni, impegnatissima nella ricerca di infiltrati, spie, agenti d’influenza dentro e attorno alle Brigate rosse durante il sequestro Moro, ignorò completamente le rivelazioni. Nessun approfondimento venne disposto: i suoi solerti consulenti, i magistrati Donadio e Salvini, l’ufficiale dei Cc Giraudo, impegnatissimi a sfornare piste, creare e inventare nessi con Servizi di mezzo mondo, mafie e ‘ndranghete varie, snobbarono l’informazione troppo imbarazzante. Eppure sarebbe stato utile accertare modalità, tempi e modi di questa interazione tra Antiterrorismo dei carabinieri e vertici del Partito comunista dell’epoca, conoscere come si svolse questa operazione di intelligence. Niente di tutto ciò. L’unica versione dei fatti ad oggi conosciuta è quella fornitaci dall’ex carabiniere che dice fino ad un certo punto, omette, confonde per tutelare la sua fonte. Fonte, nome in codice «Fontanone», che, a distanza di oltre quarant’anni, si guarda bene dal farsi avanti e raccontare al Paese quella esperienza di cui probabilmente deve provare vergogna se preferisce rimanere celato nelle pieghe del passato. Questa vicenda è raccontata anche nella docuserie che sta andando in onda su Sky in queste settimane Roma di piombo, diario di una lotta.
Nel volume la Polizia della storia potete trovare invece un capitolo interamente dedicato al lavoro di contrasto svolto dalle forze di polizia contro le Brigate rosse, dal titolo «L’uso di esche, infiltrati e rami verdi nell’azione di contrasto alle Brigate rosse» nel quale per la prima volta, documenti alla mano, si ricostruiscono i pochi casi in cui le forze di polizia riuscirono ad impiegare delatori e provocatori. Non emergono casi di infiltrazione di membri dei Servizi o delle Forze dell’ordine, frequente invece è l’uso di esche, in particolare dopo la discesa in campo diretta del Pci che fornì propri militanti, mentre il nome più noto è quello di Girotto. Risultano arruolati due delatori: uno storico proveniente dalla Brigata Ferretto in Veneto, che fu all’origine di numerosi arresti, il secondo di Curcio, della Mantovani, di Semeria; l’altro a Milano che provocò l’arresto di Fenzi e Moretti. Infine c’è la storia di «Fontanone» che permise di agganciare nei primi mesi del 1980, dopo due anni di indagini a vuoto, la colonna romana.
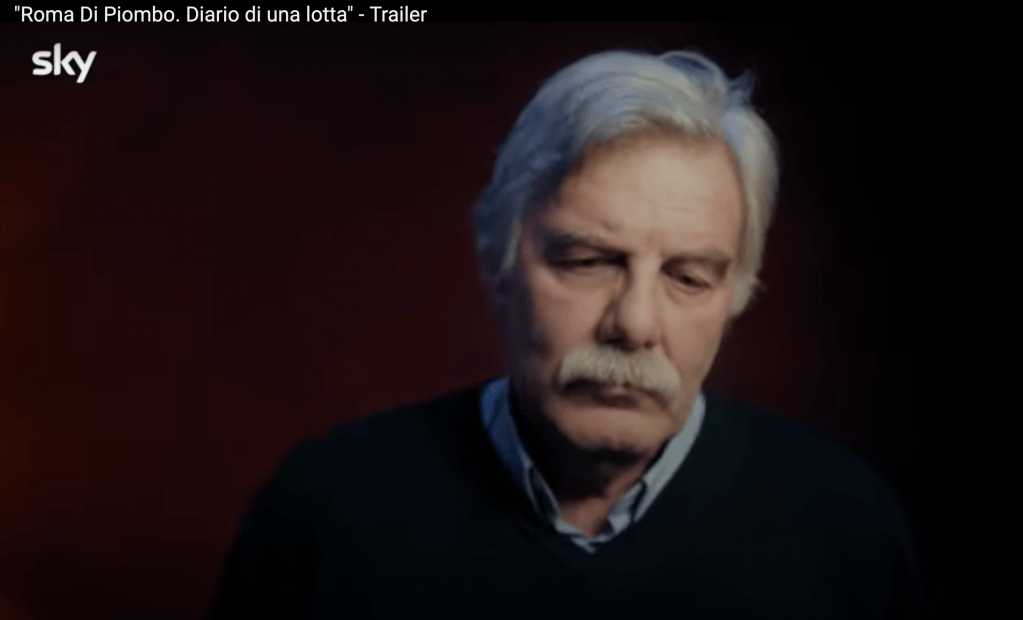
L’operazione Olocausto, il Pci infiltra un proprio militante
Dopo la morte di Guido Rossa il Pci decise di cambiare la propria strategia di contrasto alla lotta armata. Il sindacalista della Cgil era stato ucciso dalla colonna genovese delle Brigate rosse che gli contestava il lavoro informativo svolto all’interno dell’Italsider di Cornigliano per conto del Partito comunista italiano (1). I vertici del Pci non ritennero più sufficiente la semplice attività informativa e il controllo dei luoghi di lavoro più caldi, delle scuole e del territorio, condotta dal proprio apparato di sorveglianza: una struttura riservata coordinata a livello centrale dalla Sezione Affari dello Stato che si appoggiava sulle singole Federazioni. Attività che ormai, come era accaduto per Rossa, esponeva a rischi eccessivi i propri militanti. Una volta individuato Francesco Berardi, operaio dell’Italsider che distribuiva opuscoli e volantini delle Br all’interno della fabbrica, Rossa non esitò a denunciarlo ai carabinieri presso gli uffici della sorveglianza nonostante l’esitazione del Consiglio di fabbrica, dove alcuni non erano convinti di quel gesto e avrebbero voluto affrontare in modo diverso il problema. Nella cultura politica del mondo operaio era piuttosto innaturale un atto del genere, in «The Making of the English Working Class», Edward P. Thompson evoca il concetto di «opacità operaia» per descrivere la tendenza della comunità proletaria a opporre una coltre di riservatezza per tutelare quel che avveniva al proprio interno: forme di illegalità, sabotaggio ma anche divergenze che non venivano risolte chiedendo aiuto all’esterno (2). Rossa aveva infranto questo tradizionale scudo, ma lo aveva fatto seguendo alla lettera le indicazioni del suo partito. Un recente lavoro di Sergio Luzzato ci offre un suo ritratto che aiuta a comprendere meglio le ragioni di quel comportamento: un aspetto caratteriale intransigente, un passato giovanile votato all’alpinismo agonistico animato da ideali nicciani e superomisti. Rossa era stato paracadutista nella brigata Folgore e per una di quelle strane coincidenze della storia uno dei suoi addestratori era stato il “guastatore” Oreste Leonardi, il maresciallo divenuto fedele guardia del corpo di Aldo Moro, morto in via Fani. Anni dopo, la tragica morte del figlioletto muta profondamente il suo sguardo sulla vita, Rossa si avvicina all’impegno sociale, abbandona la precedente visione individualistica e competitiva del mondo anche se, probabilmente, non riuscì a liberarsi della vecchia traccia normativa (3).
La svolta arriva nel settembre 1979 – racconta Domenico Di Petrillo, per molti anni a capo della Sezione speciale anticrimine dei carabinieri di Roma – quando Ugo Pecchioli, il responsabile della sezione Affari dello Stato del Pci (una sorta di Ministero dell’Interno ombra del Partito comunista) comunica a Dalla Chiesa la disponibilità a infiltrare un militante del partito all’interno delle Brigate rosse con l’intento di destabilizzarle. L’unica condizione posta dai vertici di Botteghe Oscure – riferisce sempre Di Petrillo – «era che il militante da infiltrare fosse gestito da un ufficiale del Nord Italia per renderne il più possibile difficile l’individuazione». L’incarico venne affidato al Comandante della Sezione speciale anticrimine di Milano, Umberto Bonaventura, che incontrò per la prima volta la spia del Pci nei pressi della fontana del Gianicolo, circostanza che portò ad attribuirgli il nome in codice «Fontanone». In realtà, stando al racconto della vicenda – fatto sempre da Di Petrillo, prima nel corso della sua audizione del 19 giugno 2017 davanti alla Commissione Fioroni e successivamente in un volume pubblicato l’anno successivo che ripercorre l’attività della Sezione antiterrorismo di Roma, gli incontri con il candidato all’infiltrazione, «si concretizzano in una ricerca di come riuscire ad essere sicuri di approcciare le Brigate rosse. Facemmo vari tentativi che non andarono a buon fine, fino a che arrivammo ad individuare Piccioni, Ricciardi e da lì iniziò l’attività […] Però fu una ricerca, non fu una partenza con l’indicazione: “Andate lì”» (4). Di Petrillo fa capire che la spia non entrò mai nelle Br, ma si limitò a svolgere un lavoro di conoscenza e prossimità che consentì di individuare gli ambienti, i collettivi e i comitati politici romani che facevano da bacino di provenienza delle colonna romana: «Il nostro rapporto durò pochissimi mesi», scrive nel libro: «precisamente, sino a quando riuscimmo a individuare un’area dell’antagonismo romano, nella zona Sud della Capitale, caratterizzata dalla presenza di numerosi collettivi: le Br stavano cercando di indirizzare l’attività e di selezionare al loro interno militanti da arruolare nell’organizzazione» (5). Di Petrillo protegge ancora la fonte, è parco di informazioni e stende un po’ di cortina fumogena, ma è chiaro che l’infiltrazione nell’organico brigatista non ci fu, ma piuttosto un lavoro di perlustrazione ambientale, di individuazione dei riferimenti periferici dell’organizzazione, che conducessero a semplici «contatti» o «irregolari» da fotografare, agganciare e poi pedinare, cercando di ricostruire, appuntamento dopo appuntamento, la rete del gruppo. Di «Fontanone» si sa che era un insegnante, che riuscì a incontrare alcune persone ritenute vicine alle Brigate rosse, che questi incontri vennero fotografati e i volti dei suoi interlocutori immortalati fino a quando il pentito Patrizio Peci riconobbe l’immagine di uno di loro, fornendo l’input decisivo per indirizzare l’indagine verso la persona giusta: Francesco Piccioni, figura di peso della colonna romana, membro del fronte logistico nazionale che aveva partecipato nel dicembre 1979 alla riunione della Direzione strategica convocata in tutta fretta nella base genovese di via Fracchia. Dopo una intensa attività durata mesi Piccioni (Michele) fu catturato il 19 maggio 1980 nella base di via Silvani 7 a Roma, sede del «logistico» della colonna romana. Interessante è un ulteriore episodio: i carabinieri avevano in mano foto di diversi brigatisti immortalati durante queste attività di osservazione e pedinamento. Si trattava sicuramente di militanti che avevano una storia, erano conosciuti nei loro quartieri. «Mi rivolsi – ha spiegato Di Petrillo davanti alla Commissione Fioroni – «al Partito comunista, all’avvocato Tarsitano perché mi aiutasse a identificare queste persone. Ritagliai la foto di uno di questi che stava in via dei Fori Imperiali e dopo qualche giorno mi dette un appuntamento, andai alla Pigna [piazza Venezia, in prossimità dell’inizio di via delle Botteghe Oscure dove si trovava la sede nazionale del Pci] a incontrare Antonio Marini, un uomo del Pci, gli consegnai quel frammento di foto; dopo qualche giorno mi richiamò e mi diede il nome: Marcello Basili» (6). Si trattava di un militante vicino alla brigata di Torrespaccata che una volta arrestato iniziò a collaborare facendo catturare diversi suoi compagni.
Fu sistematica in quegli anni l’attività informativa del Pci a favore delle forze di polizia, «Dalla Chiesa – ha riferito il generale Bozzo – mi aveva incaricato di tenere i rapporti con il Pci. Dal Pci abbiamo avuto tutta la collaborazione possibile e immaginabile. Su questo non può esserci nemmeno un’ombra di dubbio. Io avevo rapporti con Lovrano Bisso, allora Segretario provinciale del Pci: ci aiutò in ogni modo» (7). Alcune testimonianze portano a ritenere che il flusso informativo avvenisse anche in direzione opposta, seppur in misura molto minore. Salvatore Ricciardi, dirigente della colonna romana scomparso il 9 aprile 2020, con una ricca storia politica nel movimento operaio romano, prima nel Psiup (1965), poi tra i fondatori del Cub ferrovieri di Roma, per poi aderire all Brigate rosse nel 1977, mi ha più volte raccontato che dall’interno del Pci romano, qualcuno che non gradiva affatto la scelta della «delazione politica di massa» condotta dai vertici del partito, fece pervenire copia dei nomi di attivisti ritenuti sospetti che erano stati passati alla Questura.
Note
- Testimonianza di Loriano Bisso, segretario provinciale del Pci genovese, in Giovanni Fasanella e Sabina Rossa, Guido Rossa mio padre, Bur, pp. 158-159: «[…] Quell’esperienza – si rivelò utile anche di fronte alla minaccia brigatista. Fu un lavoro particolarmente difficile e pericoloso. Per diverse ragioni. Innanzitutto le Brigate rosse avevano una struttura fortemente centralizzata e compartimentata, con una base di sostegno non particolarmente ampia. Quindi non erano facilmente penetrabili. Inoltre, i loro gruppi di fuoco, che applicavano la tattica del “mordi e fuggi”, erano assai efficaci; mentre le forze dell’ordine, pur disponendo di personale di livello, per tutta una fase diedero l’impressione di brancolare nel buio. Tutto questo rendeva assai spregiudicata l’azione delle Br. Per la natura delle difficoltà, quindi decidemmo di concentrare l’attenzione piuttosto su ciò che stava dietro alla produzione del materiale di propaganda brigatista. Vale a dire: chi scriveva volantini e documenti, dove si stampavano, chi li trasportava, come entravano in fabbrica, chi li distribuiva. E poi, su un piano più strettamente politico, dovevamo capire quale grado di consenso quei documenti fossero in grado di suscitare fra i lavoratori. Posso dire questo, che il lavoro di Guido Rossa ci portò assai vicino all’individuazione di gran parte della catena di produzione della propaganda brigatista. Il contributo di tuo padre fu davvero eccellente. Mi aveva parlato di Berardi già alcuni mesi prima di quel 25 ottobre 1978. Lo aveva già individuato e lo teneva d’occhio».
- E.P. Thompson, Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, il Saggiatore, Milano 1968.
- S. Luzzato, Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa, Einaudi 2021.
- D. Di Petrillo, audizione davanti alla Commissione Moro 2, 19 giugno 2017.
- D. Di Petrillo, Il lungo assedio. La lotta al terrorismo nel diario operativo della sezione speciale anticrimine dei carabinieri di Roma, Melampo, Milano 2018, p. 115-116.
- D. Di Petrillo, CM2, 19 giugno 2017.
- G. Fasanella, S. Rossa, Guido Rossa mio padre, Bur, Milano p. 141.