Secondo Sofri l’uccisione di Calabresi si distinguerebbe dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70-80 perché aveva un contenuto morale che alla lotta armata per il comunismo mancava
Risponde Scalzone che difficilmente una vendetta, un atto di giustizialismo politico, può rivendicare una superiorità morale
Caro Sofri, uccidere Calabresi fu giustizialismo politico
di Oreste Scalzone
Liberazione 2 ottobre 2008

12 dicembre 1969 terrore di Stato, banca popolare di piazza Fontana dopo la strage
L’incontro patrocinato dal segretario dell’Onu in occasione del Memory day in favore delle «vittime del terrorismo» ha fatto saltare i nervi ad Adriano Sofri. In nome di una indistinta nozione della figura di vittima si è tenuta nelle scorse settimane una cerimonia attorno alla quale sono state raccolte vicende molto diverse tra loro, distanti e persino opposte nello spazio, nel tempo, financo nella loro fenomenologia, morfologia e eziogenesi, come i morti delle Twin Towers, gli scolari trucidati a Beslan, i morti delle stragi di piazza Fontana o l’uccisione del commissario di polizia Luigi Calabresi, per fare solo alcuni esempi.

Il commissario di polizia Luigi Calabresi
Condannato per quest’ultimo episodio, ma da sempre proclamatosi innocente, Sofri non ha sopportato l’accostamento. “Io terrorista, alla stregua dei sequestratori di Beslan? No, non ci sto!”. È stato questo il senso della sua indignata reazione per un qualcosa che esplicitamente ferisce il suo onore. Sofri ha giustamente contestato che un episodio come l’uccisione di Calabresi, arrivato al culmine di una sequenza che vide la morte dell’innocente Giuseppe Pinelli e la montatura contro gli anarchici con l’incriminazione di Pietro Valpreda, possa essere messo sullo stesso piano della strage di piazza Fontana, accorpato addirittura a massacri di bambini e deportazioni a volte vicine al genocidio. Sul Foglio del 13 settembre ha sollevato la pietra dello scandalo affrontando la semantica di una delle parole più stregate al mondo: «terrorismo». Termine tra i più compromessi, multiuso, impiegato essenzialmente per delegittimare, mostrificare, demonizzare l’avversario piuttosto che per definire un particolare uso della violenza. Occasione per questo di un infinito autismo comunicativo. Si potrebbe forse obiettare che non ha molto senso rincorrere sul terreno della stigmatizzazione linguistica chi bombarda o ordina martellamenti d’artiglieria e poi rivendica virtuose illibatezze, senza mancare di dare del terrorista ai ragazzini col cappuccio che lanciano sassi, rompono qualche vetrina o riempiono i muri di tag. Da alcuni anni una direttiva europea considera terrorismo il pirataggio informatico o la semplice occupazione illegale di piazze e edifici pubblici. Di fronte a ciò, è lecito chiedersi se si possa passare la vita lasciandosi ipnotizzare nel tentativo di raddrizzare i torti semantici, di (ri)prendersi la ragione rispetto a un intreccio infinito di mascalzonate statali d’ogni tipo…? Forse a questo punto l’unica cosa possibile è fare un’operazione di radicale Jugitzu semantico, come quella realizzata dai movimenti afro-americani, quando decisero di svuotare l’aggressività coloniale e razzista dello stigma negro appropriandosi essi stessi di quella definizione.

Giuseppe Pinelli, anarchico ucciso nella questura di Milano
La parola terrorismo nasce sulla base di una autodefinizione del rivoluzionarismo statalista-borghese nel drittofilo del diritto di resistenza e del «diritto-dovere a insorgere con le armi alla mano contro il despota e l’usurpatore». Teorie, come quella del tirannicidio, finemente elaborate dai gesuiti spagnoli del 600, Birenbaum e altri, per argomentare la legittimità dell’attentato contro la persona dell’imperatore, se questi entrava in conflitto con l’autorità papale. Dottrine poi riprese con fedeltà mimetica da quello che potremmo chiamare legittimismo del futuro prossimo venturo, di parte repubblicana; e poi di nuovo, alla rovescia, dal legittimismo tradizionalista anti-repubblicano. Termini, dunque, di doppia matrice, cattolica apostolica romana prima e poi – nella teologia politica, con perfetta spinta alla ritorsione mimetica – giacobina. Tanto che potremmo parlare con pertinenza di concetto catto-giacobino.
Che una traccia di filiazione con questa matrice ci sia anche nei vendicatori anarchici – dopo Felice Orsini e gli attentatori della «propaganda attraverso il gesto», i Gaetano Bresci, i Giovanni Passannante, i Sante Caserio, non deve stupire più di tanto. La stessa relazione conduce alle azioni dei populisti, gli amici del popolo, i Narodniki dell’attentato a Stoljpin; o ancora ai nazionalisti – e, se vogliamo distinguere il nazionalismo conculcato e irredentistico da quello già al potere, nazionalitarî; e ancora più in generale ai movimenti caratterizzati da ideologia-passione identitaria nutrita di martirio. La realtà è che le idee delle classi dominanti costituiscono un reticolo concettuale da cui non ci si libera sollevandosi per il codino, come il barone di Munchausen…

Pietro Valpreda, anarchico vittima della montatura giudiziaria
Per contro, non a caso il termine è ereditato senza complessi dal filone della sinistra della socialdemocrazia russa, i bolscevichi, e dal loro successivo costituirsi in Komintern. Quasi inevitabile riscontro degli effetti suscitati dalla contraffazione, oltreché lavorista e statalista, teorizzata da Ferdinand Lassalle. Nel programma di Gotha si stabiliva infatti una retrospettica filiazione non certo con l’Associazione internazionale dei lavoratori e la Comune di Parigi, ma proprio col giacobinismo, con certi passaggi dottrinari, in particolare di Robespierre e Saint-Just.
D’altronde Trotsky non ha complessi quando risponde con l’opuscolo Terrorismo e comunismo al pamphlet Comunismo e terrorismo di Kautsky. Nei resoconti delle sessioni del Komintern si dà documentazione dei dibattiti sull’opportunità di ricorrere in talune circostanze a combinazioni e dosaggi di terrore come ingrediente dell’azione. In alcuni suoi passi Lenin argomenta la necessità di instaurare forme di terrore poliziesco, anche come antidoto e argine a una violenza spontanea insorgente, che altrimenti avrebbe fatto scorrere fiumi di sangue ancor più grandi (vengono in mente in questo caso Bronte, la repressione spietata gestita da Bixio, e altrove le osservazioni di Foucault – nel Dialogo con i maoisti e in Microfisica del potere – sulla violenza rivoluzionaria che quando si istituzionalizza in tribunali e carceri si trasmuta nel suo contrario).
Ma queste cose Adriano Sofri le conosce meglio di me. Cionondimeno si è lasciato andare ad una stucchevole danza del ventre rivendicando non l’esistenza di una differenza (quella sì, fondata su una diversità di strategie e tattiche nell’uso della violenza politica, oltreché sugli obbiettivi), ma la presenza di una superiorità morale, di una qualità che distinguerebbe la vicenda Calabresi dai successivi atti di lotta armata avvenuti nel corso degli anni 70. A suo avviso il movente dell’indignazione – che per civetteria definisce «privata», ma che vuolsi chiamare civile – sarebbe stata moralmente superiore – e per questo esente dall’infamia d’essere una pratica ritenuta terrorista – a qualsivoglia altra motivazione politica, come quella legata alla pedagogia della «lotta armata per il comunismo». Egli sembra suggerire una definizione della categoria di terrorismo a partire dal movente, per cui l’omicidio ingenerato da indignazione civile ne sarebbe esente e dopo ripetute contorsioni, correzioni, rettificazioni e sfumature via, via aggiunte, arriva anche a precisare quanto da sempre sostenuto dal marchese di Lapalisse: esiste una violenza che non è violenza politica (vedi la strage di Erba), e una violenza politica che non è terrorismo (Corriere della sera del 16 settembre).
Addirittura per rafforzare il suo ragionamento cerca appoggi nelle parole dei giudici che lo hanno condannato, interpretando la mancata applicazione dell’aggravante per «fini di terrorismo ed eversione dell’ordine costituzionale» come il riconoscimento, anche da parte della magistratura, della natura «privata» e non eversivo-terroristica dell’omicidio Calabresi. Argomento, questo, ribadito con ancora maggiore nettezza da Giuliano Ferrara sul Foglio del 22 settembre: «Chi ha ucciso il commissario non aveva un piano terroristico per attaccare il cuore dello Stato, bensì vendicare la morte dell’anarchico Pinelli. Sono due cose completamente diverse, il terrorismo e l’assassinio di Luigi Calabresi».

volantino
Errore davvero macroscopico, visto che le leggi speciali dell’emergenza sono state varate sette anni dopo l’attentato, e che dunque la magistratura non poteva qualificare retroattivamente l’uccisione di Calabresi come un atto di sovversione dell’ordinamento costituzionale (come d’altronde avvenne anche per il sequestro Sossi e altri episodi analoghi fino al rapimento Moro), o applicare l’articolo 280 del codice penale, riscritto sempre nel 1979, (attentato con finalità di terrorismo o eversione), piuttosto che il generico 575, omicidio di diritto comune.
Come se non bastasse, nel tentare un parallelo Sofri non trova di meglio che richiamare una delle azioni gappiste più importanti della Resistenza: l’uccisione di Giovanni Gentile. Un episodio che nulla ha di “esclusivo” ma che si iscrive nella strategia della lotta armata urbana condotta dai Gap. Insomma se uno dei requisiti del terrorismo è quello di avere una strategia, e dunque una sua riproducibilità nella azioni – come pare voler suggerire Sofri –, quello dei Gap era terrorismo anti-nazifascista, né più né meno, come si è ritenuto che fosse – a partire da un certo momento in poi – per Prima linea e le Brigare rosse.
Toccherà agli storici futuri stabilire se la lotta armata degli anni 70 lo fu davvero, perché dal punto di vista del diritto non esiste una definizione universalmente riconosciuta, a meno che non si voglia prendere per buona quella offerta dai testi dell’Fbi o del Pentagono. Ciò che invece suscita sconcerto è il fatto che una vendetta, come l’uccisione di Calabresi, qualcosa che si apparenta ad una supplenza soggettiva della giustizia statale, all’epoca per giunta rifiutata da Sofri stesso, una sentenza di morte applicata sulla base di una colpevolezza stabilita sulla scorta di una vox populi, senza nemmeno la farsa di un processo popolare e addirittura considerata oggi un “errore giudiziario”, come lo stesso Sofri scrive, possa essere ritenuta un gesto più nobile degli attentati successivi.
Quello che già allora molti di noi ritennero una forma di giustizierismo politico ci fa orrore, tanto più quando in quell’episodio si arriva ad intravedere un segno del torvo giustizialismo impregnato del paradigma della colpa che sarebbe arrivato 36 anni dopo.
Scriveva Lissagaray, il comunardo che riuscì a scrivere una storia al presente della Comune di Parigi: «Chi diffonde tra il popolo false leggende rivoluzionarie, e lo diletta di storie cantanti, è altrettanto nocivo che il geografo che indirizzi ai naviganti delle carte nautiche che mentono».
Link
Neanche il rapimento Sossi fu giudicato terrorismo
 prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra
prigione dopo trent’ anni di reclusione. Quell’ uomo, l’ ex brigatista Vincenzo Guagliardo, è invece ancora dentro anche perché non ha voluto pubblicizzare l’incontro con la figlia di Rossa, né s’ è rivolto ad altre vittime ritenendo che fosse la forma migliore per rispettarle. E oggi Sabina Rossa, dopo il faccia a faccia con Guagliardo e altri ex militanti delle Brigate rosse fa un passo in più. Da deputato del Partito democratico, la figlia del sindacalista ucciso dalle Br ha presentato un disegno di legge per sostituire il «sicuro ravvedimento» richiesto dal codice penale per concedere la liberazione condizionale (e che per molti giudici, compresi quelli di Guagliardo, si misura proprio dal contatto tra carnefici e vittime) con una formula diversa: può uscire dal carcere prima del fine pena, e nel caso degli ergastolani dopo 26 anni, chi ha tenuto «un comportamento tale da far ritenere concluso positivamente il percorso rieducativo di cui all’ articolo 27 comma 3 della Costituzione». Niente più indagini psicologiche alla ricerca dei sintomi del «ravvedimento», quindi. E niente più valutazione del rapporto tra gli assassini e i parenti di chi è stato assassinato. «Le vittime non hanno bisogno di vedersi affidare il peso del destino di coloro che li ha colpiti – spiega la Rossa -. Se questi contatti avvengono, non devono essere sbattuti in tribunale per dimostrare qualcosa. Devono restare in un altro ambito, non diventare metro di giudizio per decidere se un detenuto merita di uscire oppure no». La liberazione condizionale è diventata materia delicata da quando hanno cominciato a chiederla gli ex terroristi, di sinistra e di destra, che non hanno usufruito degli sconti di pena concessi a pentiti e dissociati. Si tratta di ergastolani, condannati per omicidi, che compiuti i 26 anni di cella presentano istanza per tornare a una vita regolare fuori dalle galere, di solito quando già godono della semilibertà (all’ esterno di giorno e dentro di notte). La legge attuale prevede, appunto, che sia certificato il «sicuro ravvedimento», ma Sabina Rossa lo considera un requisito «troppo aleatorio». Per alcuni giudici, un fattore discriminante è stato proprio il comportamento del condannato nei rapporti con i familiari delle persone uccise; cioè se avesse o meno «dimostrato solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole». E’ successo così che chi aveva preso contatti con i parenti delle vittime, di solito attraverso delle lettere inviate tramite gli avvocati, è stato considerato «ravveduto» ed ha lasciato il carcere definitivamente, mentre chi non l’ ha fatto s’ è visto negare questa possibilità. Nel caso di Guagliardo, il giudice ha detto no proprio in assenza di quei contatti, nonostante l’ incontro con Sabina Rossa fosse già avvenuto. Ma l’ ex br non ne ha parlato, sostenendo di considerare il silenzio «la forma di mediazione più consona alla tragicità della quale si è macchiato». Ora Sabina Rossa, protagonista di questa vicenda in qualità di figlia dell’ uomo ucciso da Guagliardo, ritiene che «una simile interpretazione della norma, che chiama in causa direttamente le vittime del reato e o loro familiari, si presti a grandi difficoltà applicative e lasci grande spazio a disomogeneità legate all’ intrinseca difficoltà di lettura profonda della relazione tra  condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili».
condannato e vittima». Anche perché ogni magistrato decide come crede, e in passato sono state liberati pure ex terroristi che non si sono mai rivolti ai parenti dei loro «bersagli». Di qui la proposta di modificare la legge, e di ancorare l’ eventuale scarcerazione a criteri più oggettivi e meno discrezionali. «Senza andare a scandagliare l’ animo delle persone», dice ancora la deputata del Pd, che attribuisce a questa iniziativa un significato più ampio. «Vorrei che fosse – spiega – un ulteriore passo verso il superamento dei cosiddetti “anni di piombo”, che non può avvenire mettendo una pietra sul passato o attraverso il silenzio. Le leggi premiali hanno messo in libertà degli assassini senza che scontassero una vera pena, mentre c’ è chi dopo trent’ anni è ancora in carcere pur non avendo più nulla a che fare con la persona che fu. E’ un paradosso, che sarebbe bene superare con misure meno discrezionali possibili».









 Gli spettri del 41 bis
Gli spettri del 41 bis L’unico svago concesso viene dall’agognato carrello dell’infermeria che scandisce la giornata distribuendo tre volte al giorno stupefacenti ricreazioni chimiche a base di benzodiazepine. Gli «invisibili», come fantasmi, ogni tanto battono un colpo, anzi dei colpi sui cancelli blindati. Quelle periodiche battiture ci ricordano che il loro è un mondo di vivi che non rinuncia a resistere.
L’unico svago concesso viene dall’agognato carrello dell’infermeria che scandisce la giornata distribuendo tre volte al giorno stupefacenti ricreazioni chimiche a base di benzodiazepine. Gli «invisibili», come fantasmi, ogni tanto battono un colpo, anzi dei colpi sui cancelli blindati. Quelle periodiche battiture ci ricordano che il loro è un mondo di vivi che non rinuncia a resistere. dispositivi giudiziari e penitenziari della emergenza, sempre più limitanti e costrittivi delle libertà individuali e collettive, restino radicati nel tempo, mentre le tipologie di applicazione hanno vocazione a variare. Ieri è toccato ai «terroristi», oggi ai mafiosi, persino ceto politico e imprenditori ne hanno saggiato gli effetti. E domani?
dispositivi giudiziari e penitenziari della emergenza, sempre più limitanti e costrittivi delle libertà individuali e collettive, restino radicati nel tempo, mentre le tipologie di applicazione hanno vocazione a variare. Ieri è toccato ai «terroristi», oggi ai mafiosi, persino ceto politico e imprenditori ne hanno saggiato gli effetti. E domani?


 inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che
inevitabilmente, abbassa la soglia della paura nel momento in cui sottopone i cittadini americani a una pressione sempre più forte. Le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale. Inoltre, la parte di popolazione sotto custodia penale per aver commesso reati è cresciuta al di là di ogni legge storica. Alla fine del XX secolo, un numero senza precedenti di americani era confinato in prigioni statali o di contea, in centri di detenzione e luoghi di custodia all’interno delle scuole. La declinazione razziale di questa incarcerazione ha visibilmente invertito aspetti chiave della rivoluzione dei diritti civili. Per la prima volta dall’abolizione della schiavitù, un gruppo definito di americani vive, su basi più o meno permanenti, in una condizione giuridica di non-libertà – in virtù di una singola condanna all’ergastolo, di ripetute incarcerazioni, oppure delle conseguenze di lungo termine di una condanna penale; non solo, ma tra questi una sconcertante percentuale discende dagli schiavi liberati. Governare questa porzione di popolazione attraverso il sistema penale non ha garantito quelle condizioni di sicurezza che  potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.
potrebbero ispirare un maggiore investimento delle inner cities (cinture urbane, Ndr), ma, al contrario, ha ulteriormente stigmatizzato comunità già assediate dalla concentrazione della povertà. Come è prevedibile, sono i poveri, sovrarappresentati in entrambi i gruppi, a condividere questo destino; ma anche la vita quotidiana delle famiglie middle class è stata trasformata, non tanto dalla criminalità in sé, quanto dalla “paura della criminalità”. Nelle famiglie appartenenti alla middle class, decisioni quali dove vivere, dove lavorare e dove mandare a scuola i figli sono prese sempre più spesso in base al rischio percepito di criminalità. Nella misura in cui le istituzioni che sono al servizio della middle class si concentrano sulla gestione della paura della criminalità, la nostra nei confronti degli altri e quella degli altri nei nostri confronti, gli effetti si moltiplicano. Il punto non è che la middle class sia più colpita dal governo attraverso la criminalità di quanto lo siano i poveri; piuttosto, è considerare tanto il sistema di giustizia penale incentrato sulla comunità povere quanto il settore privato degli ambienti securizzati middle class alla stregua di specifiche modalità di classe, tra loro interagenti, del governo attraverso la criminalità. Tanto l’emergere delle gated communities (complessi residenziali chiusi all’accesso dei non residenti, Ndr) quanto il moltiplicarsi di smisurati Suv (sport utility vehicles) riflettono la priorità accordata dalle famiglie middle class alla sicurezza e al mantenimento della distanza, contro un rischio di criminalità associato ai poveri urbani. Ma come i critici dello sprawl (progressiva estensione delle città oltre il perimetro urbano, Ndr) hanno iniziato a documentare, un’insistenza così pesante sulla fortificazione rende queste comunità ancora più dipendenti da una polizia aggressiva e dallo stato penale per la tutela delle norme di civiltà. Infatti, il nuovo ambiente securizzato tende ad alimentare alcune routine circoscritte, ma quando si presentano situazioni inedite, esso tende a creare ciò che gli economisti chiamano (in modo appropriato, nel nostro caso) “dilemma del prigioniero”: vale a dire un gioco in cui i giocatori non possono collaborare, e possono avere la meglio solo se si fanno predatori per primi. L’ultimo che resta fuori perde (anche se sta tornando al suo Suv o nella sua gated community). In un ambiente di questo tipo, è lecito aspettarsi che querele e procedimenti penali intervengano sempre più a ristabilire il controllo sociale in assenza di fiducia.
 migranti e richiedenti asilo. D’altro canto, con la crescente interdipendenza tra paesi e popoli, e con la coabitazione ‘coatta’ tra questi ultimi, la presenza dell’altro si rende visibile e finisce per creare insicurezza. Ecco un paradosso. L’insicurezza creata dai mercati riguarda tutti, o per lo meno le maggioranze, in termini di paura rispetto al futuro, vulnerabilità nei confronti del datore di lavoro, impotenza verso i processi decisionali. Ma una simile paura, che Bakhtin definirebbe ‘cosmica’, rivolta com’è a un potere inafferrabile e debordante, viene tradotta in sgomento indirizzato a minoranze visibili. Se lo Stato non può più difenderci dall’economnia, se non è più in grado di guidarla ma solo di obberdirle, allora dovrà difenderci da altre fonti di insicurezza. A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Il populismo non aspira al sostegno dell’opinione pubblica in generale, ma solo di quel settore della società che si crede sfavorito e danneggiato dalla presenza e dalle attività di altri gruppi. Questi ultimi, ritenuti immeritevoli di quanto posseggono, vengono indicati come responsabli dell’emarginazione di chi non vuole far altro che condurre un’esistenza ordinaria e silenziosa. Michael Howard, ministro britannico conservatore, in una dichiarazione rilasciata nel 1993, espresse con chiarezza questo pensiero: la maggioranza silenziosa è diventata rumorosa, perché il sistema della giustizia criminale fa ormai troppo per i criminali e troppo poco per la protezione del pubblico. Secondo una definizione comune, sono populisti i politici che concepiscono politiche penali punitive le quali sembrano rispecchiare gli umori popolari. Il populismo penale che si diffonde oggi, in realtà, nasconde altro. Assistiamo allo spettacolo dell’affluenza privata e dello squallore pubblico. Avvertiamo che i legami sociali si indeboliscono e sappiamo che solo questi legami possono contribuire, almeno parzialmente, a ostacolare gli appetiti individuali
migranti e richiedenti asilo. D’altro canto, con la crescente interdipendenza tra paesi e popoli, e con la coabitazione ‘coatta’ tra questi ultimi, la presenza dell’altro si rende visibile e finisce per creare insicurezza. Ecco un paradosso. L’insicurezza creata dai mercati riguarda tutti, o per lo meno le maggioranze, in termini di paura rispetto al futuro, vulnerabilità nei confronti del datore di lavoro, impotenza verso i processi decisionali. Ma una simile paura, che Bakhtin definirebbe ‘cosmica’, rivolta com’è a un potere inafferrabile e debordante, viene tradotta in sgomento indirizzato a minoranze visibili. Se lo Stato non può più difenderci dall’economnia, se non è più in grado di guidarla ma solo di obberdirle, allora dovrà difenderci da altre fonti di insicurezza. A uno Stato snello, che rinuncia alle tradizionali funzioni protettive, si chiede allora l’essenziale: la difesa del proprio corpo e dei propri possedimenti, anziché la difesa da un’economia che li minaccia. Il populismo penale è legato allo snellimento dello Stato e alla domanda crescente di difesa personale anziché sociale. Il termine populismo, d’altro canto, va riferito al risentimento di gruppi che si credono trascurati o abbandonati dall’autorità. Questo risentimento, però, si traduce in ostilità verso altri gruppi o individui ritenuti complici della condizione di abbandono avvertita. Il populismo non aspira al sostegno dell’opinione pubblica in generale, ma solo di quel settore della società che si crede sfavorito e danneggiato dalla presenza e dalle attività di altri gruppi. Questi ultimi, ritenuti immeritevoli di quanto posseggono, vengono indicati come responsabli dell’emarginazione di chi non vuole far altro che condurre un’esistenza ordinaria e silenziosa. Michael Howard, ministro britannico conservatore, in una dichiarazione rilasciata nel 1993, espresse con chiarezza questo pensiero: la maggioranza silenziosa è diventata rumorosa, perché il sistema della giustizia criminale fa ormai troppo per i criminali e troppo poco per la protezione del pubblico. Secondo una definizione comune, sono populisti i politici che concepiscono politiche penali punitive le quali sembrano rispecchiare gli umori popolari. Il populismo penale che si diffonde oggi, in realtà, nasconde altro. Assistiamo allo spettacolo dell’affluenza privata e dello squallore pubblico. Avvertiamo che i legami sociali si indeboliscono e sappiamo che solo questi legami possono contribuire, almeno parzialmente, a ostacolare gli appetiti individuali  eccessivi. La paura dell’altro, in questo contesto, è paura del tipo di sistema che abbiamo creato, è consapevolezza che sappiamo rispondere al crimine, ma non siamo in grado di rispondere alle sue cause. In una situazione di ineguaglianza crescente, con una polarizzazione della ricchezza che torna a livelli ottocenteschi, si teme che il crimine sia destinato a diffondersi e ad assumere i connotati della disperazione. Si teme l’ineguaglianza, non il crimine. Il populismo penale, infine, può avere una propria funzione latente. Se la severità penale, nei primi decenni della rivoluzione industriale, intendeva disciplinare le orde di spossessati al lavoro di fabbrica, nell’epoca corrente una simile severità può educare chi conduce vita precaria ad accettare la propria insicurezza e interiorizzare il proprio scarso valore sociale e umano. La pena, allora, contribuirà alla riduzione delle aspettative, convincendo chi ne è colpito della propria inutilità. Il populismo penale, in breve, è il compagno ideale della crescita economica, basata spesso sulla produzione dell’inutile che rende alcuni gruppi di esseri umani inutili. Ho detto in apertura che, nell’esaminare i paesi individualmente, si notano differenze non secondarie. Guardando all’Italia, ad esempio, credo che il populismo penale si avvalga di uno sfondo culturale e politico davvero singolare. Con una vita pubblica ormai priva di qualsiasi missione etica, e un’élite che moltiplica le manifestazioni della propria illegalità, il populismo non è il trasferimento in politica del risentimento popolare o delle intuizioni che vengono dalla strada, ma è l’insulto, l’aggressione, la depredazione che alcuni temono di poter subire per strada.
eccessivi. La paura dell’altro, in questo contesto, è paura del tipo di sistema che abbiamo creato, è consapevolezza che sappiamo rispondere al crimine, ma non siamo in grado di rispondere alle sue cause. In una situazione di ineguaglianza crescente, con una polarizzazione della ricchezza che torna a livelli ottocenteschi, si teme che il crimine sia destinato a diffondersi e ad assumere i connotati della disperazione. Si teme l’ineguaglianza, non il crimine. Il populismo penale, infine, può avere una propria funzione latente. Se la severità penale, nei primi decenni della rivoluzione industriale, intendeva disciplinare le orde di spossessati al lavoro di fabbrica, nell’epoca corrente una simile severità può educare chi conduce vita precaria ad accettare la propria insicurezza e interiorizzare il proprio scarso valore sociale e umano. La pena, allora, contribuirà alla riduzione delle aspettative, convincendo chi ne è colpito della propria inutilità. Il populismo penale, in breve, è il compagno ideale della crescita economica, basata spesso sulla produzione dell’inutile che rende alcuni gruppi di esseri umani inutili. Ho detto in apertura che, nell’esaminare i paesi individualmente, si notano differenze non secondarie. Guardando all’Italia, ad esempio, credo che il populismo penale si avvalga di uno sfondo culturale e politico davvero singolare. Con una vita pubblica ormai priva di qualsiasi missione etica, e un’élite che moltiplica le manifestazioni della propria illegalità, il populismo non è il trasferimento in politica del risentimento popolare o delle intuizioni che vengono dalla strada, ma è l’insulto, l’aggressione, la depredazione che alcuni temono di poter subire per strada.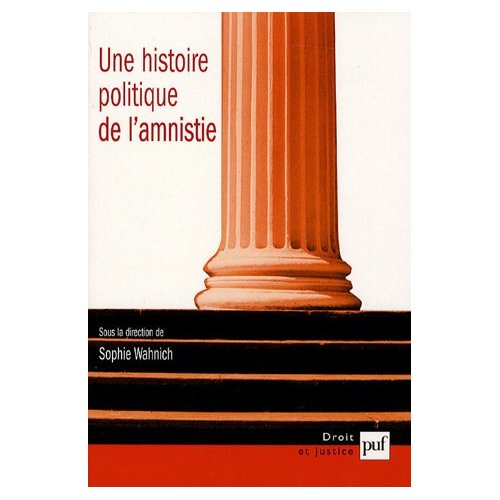 Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.
Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.