Estratti dal libro Esilio e castigo, Paolo Persichetti, La città del sole edizioni 2005
Retroscena di una inchiesta e manipolazioni attorno alle indagini condotte dal “gruppo di lavoro sull’omicidio di Marco Biagi” e dalla procura di Bologna
Capitolo VII – “Blu come un camoscio” /Seconda parte
Questo accecamento colpevolista è all’origine di un grottesco episodio d’omonimia. Il 23 gennaio 2003, Giovagnoli invia la Digos nell’abitazione di un’attivista romana, già attenzionata in precedenti indagini e confusa con la sorella di uno dei suoi amici perquisiti. Nessuno in procura e in questura si era preoccupato di verificare la reale consanguineità tra i due. La semplice omonimia bastava agli inquirenti, a cui non sembrava vero di aver finalmente trovato il “contatto” tra Persichetti e ambienti ritenuti “filoeversivi”, così da poter avvalorare lo sgangherato teorema della centrale francese. Ovviamente la perquisizione non darà alcun esito, perché i due non si conoscevano affatto. Se gli investigatori avessero controllato meglio, invece di lasciarsi sopraffare dall’abusiva correlazione fra due cognomi identici, si sarebbero accorti dell’errore maldestro.
La vera sorella dell’amico di Persichetti si chiamava Nicoletta, come era facile rilevare anche dall’agendina telefonica a lui sequestrata, e non Paola, coma la donna perquisita. Ennesima dimostrazione dei metodi approssimativi di un’inchiesta incapace d’accertamenti banali, quanto essenziali, per evitare scambi di persona. Ancora una volta, però, l’errore era figlio di postulati che non solo sfuggivano a qualsiasi verifica, ma addirittura si avvalevano di farneticanti invenzioni e contraffazioni della realtà. Solo grazie all’indagine difensiva condotta dall’avvocato Francesco Romeo, nel giugno 2003, verranno finalmente depositate agli atti sedici testimonianze che dettagliano ad abundantiam i suoi movimenti e le sue attività nel periodo incriminato. Le annotazioni presenti nell’agenda trovano così ampi riscontri a cui si aggiungeranno anche nuove circostanze, come la “cena politica” del 19 marzo al Marais, o gli appunti forniti da alcuni studenti sulla lezione tenuta il 14 marzo. Insomma, un piccolo campione, selezionato unicamente per esigenze di sinteticità, di quanto la procura avrebbe potuto raccogliere se solo avesse avuto l’intenzione di accertare la verità e non di fabbricare un colpevole. Ma ormai a Bologna sono obnubilati. Non possono tornare indietro. Tengono stretta la preda che hanno inventato. Ogni loro passo successivo è viziato dalla necessità di legittimare il postulato iniziale. C’è una compresenza di elementi diversi tra investigatori e magistrati che dà luogo a un impasto surreale, una sinergia che non funziona e che risponde a strani imput.
Il gruppo di lavoro su Marco Biagi è un coacervo estemporaneo d’incompetenze e limiti che si sommano l’un l’altro. Lo dirige l’ex capo della mobile veneziana, un funzionario assolutamente digiuno d’inchieste sui gruppi sovversivi, senza background culturale sul fenomeno. Non conosce le storie di quei movimenti, le loro filiazioni, le differenze culturali, confonde le sigle, sottovaluta le scissioni, ignora la discontinuità decisiva del decennio 90. Per lui e per gli altri “mobilieri” un ex brigatista vale l’altro, le sigle si equivalgono, pure quelle scomparse da più di un decennio. Le resuscitano, attribuiscono intenzioni, riscrivono biografie e identità pur di far coincidere la realtà con i loro pregiudizi e la loro ignoranza. Quelli delle Digos non sono da meno. Anche loro sono malmessi dopo che alla fine degli anni 80 il fenomeno della lotta armata si è estinto. Molte “memorie storiche” sono andate in pensione, i nuovi non hanno esperienza, si sono fatti le ossa con l’hooliganismo degli stadi e qualche centro sociale. Non sanno leggere i documenti, altrimenti saprebbero quello che gli autori dei nuovi attentati ribadiscono da tre anni in tutte le salse: siamo gli Ncc, più qualche altro raccolto per strada, abbiamo ripreso la bandiera delle Br-Pcc di cui intendiamo proseguire il percorso interrotto – la cosiddetta “continuità oggettiva” – e le Br-Pcc a cui guardiamo non sono quelle della «ritirara strategica»(1) dell’82, ma quelle della prima posizione fuoriuscite dalla rottura organizzativa dell’84-85. In un manoscritto di dodici pagine a circolazione interna e nel quale si delinea in piena franchezza il bilancio fallimentare del «rilancio» della lotta armata avvenuto con l’azione D’Antona, documento citato dal Corriere della sera del 18 maggio 2004 e ritrovato dalla Digos nel dicembre 2003, all’interno del deposito che le «nuove Br» avevano predisposto in tutta fretta in via Montecuccoli a Roma, dopo il conflitto a fuoco del marzo precedente sul treno Roma-Arezzo, si può leggere: «Noi storicamente non siamo le Br-Pcc ma gli Ncc[…] le Br-Pcc appartengono al proletariato, sono state il suo strumento politico-organizzativo e la classe vi si riconosce, per cui anche la non appartenenza politico-organizzativa dà un diritto-dovere di riprenderne il cammino».
Quelli delle Digos non sono da meno. Anche loro sono malmessi dopo che alla fine degli anni 80 il fenomeno della lotta armata si è estinto. Molte “memorie storiche” sono andate in pensione, i nuovi non hanno esperienza, si sono fatti le ossa con l’hooliganismo degli stadi e qualche centro sociale. Non sanno leggere i documenti, altrimenti saprebbero quello che gli autori dei nuovi attentati ribadiscono da tre anni in tutte le salse: siamo gli Ncc, più qualche altro raccolto per strada, abbiamo ripreso la bandiera delle Br-Pcc di cui intendiamo proseguire il percorso interrotto – la cosiddetta “continuità oggettiva” – e le Br-Pcc a cui guardiamo non sono quelle della «ritirara strategica»(1) dell’82, ma quelle della prima posizione fuoriuscite dalla rottura organizzativa dell’84-85. In un manoscritto di dodici pagine a circolazione interna e nel quale si delinea in piena franchezza il bilancio fallimentare del «rilancio» della lotta armata avvenuto con l’azione D’Antona, documento citato dal Corriere della sera del 18 maggio 2004 e ritrovato dalla Digos nel dicembre 2003, all’interno del deposito che le «nuove Br» avevano predisposto in tutta fretta in via Montecuccoli a Roma, dopo il conflitto a fuoco del marzo precedente sul treno Roma-Arezzo, si può leggere: «Noi storicamente non siamo le Br-Pcc ma gli Ncc[…] le Br-Pcc appartengono al proletariato, sono state il suo strumento politico-organizzativo e la classe vi si riconosce, per cui anche la non appartenenza politico-organizzativa dà un diritto-dovere di riprenderne il cammino».
A Bologna, Vittorio Rizzi spiega ad un giornalista che lo intervista in posizione genuflessa (Repubblica del 26 ottobre 2003) che l’inchiesta è ripartita dalla «indagine di sistema», come prescrive il manuale del piccolo detective. In sostanza «riapri i faldoni, rileggi una per una le carte, verifichi vecchie intuizioni, misuri se una connessione logica valida ieri lo sia ancora oggi o se il tempo non l’abbia contraddetta. Rileggi tutto. Ma proprio tutto» ma non capisci nulla perché non hai le basi, perché non è come acchiappare spacciatori, rapinatori, mafiosi, prosseneti o mariti che menano alle mogli. Insomma postulano che tutto venga dal passato, che qualcuno tiri le fila, magari da lontano, protetto in qualche santuario e invece i “nuovi” sono lì, sotto il loro naso che girano indisturbati da tre anni. E così ripescano vecchi fascicoli, si interessano a “latitanti” che potrebbero tranquillamente incontrare in strada, nei posti di lavoro, in ritrovi pubblici se solo facessero un salto a Parigi. Rileggono impolverati dossier, incollano A 4 sui muri, giocano ai rebus e ai quiz ma dimenticano di consultare le emeroteche, le videoteche, le librerie, dove informazioni sui rifugiati e i loro interventi pubblici non mancano di certo. È vero, non sono topi di biblioteca. Loro guardano i film di Starki e Hutch. Hanno il grilletto facile e sfondano le porte. Non pensano, menano… quando gli riesce, come a Genova. E così focalizzano l’attenzione su Persichetti. È un quarantenne, condannato per un processo della fine degli anni 80. Uno degli ultimi, dunque per forza deve sapere qualcosa. Poco importa che non abbia mai avuto nulla a che vedere con le Br-Pcc nella sua traiettoria giudiziaria. Potrebbe aver mutato idea. Le posizioni politiche si cambiano come le maglie delle squadre di calcio, pensano i “mobilieri”. E poi Persichetti è scappato in Francia, vuol dire che aveva cattive intenzioni e non che volesse risparmiarsi vent’anni di galera. situazione non ci sono solo degli investigatori che al massimo potrebbero rimpiazzare i Dupont presenti nei fumetti di Tintin, c’è anche un magistrato molto particolare, che è lì, se è vero quel che ha scritto Il Messaggero del 31 ottobre 2003: «Con il dolore e la rabbia di chi si è visto portare via un carissimo amico[…]. Un’amicizia di tanti anni, quelli della giovinezza, del matrimonio e della nascita dei figli, che Marco Biagi e Paolo Giovagnoli hanno visto crescere e diventare grandi insieme fino a quella tragica sera». Se ciò trovasse conferma – e l’assenza di ogni smentita suona come silenzio-assenso (2) – ci troveremmo di fronte a una insostenibile sovrapposizione di ruoli tra funzioni della pubblica accusa e interessi della parte civile. Verrebbe offuscata la fiducia nella serenità interiore del magistrato e atroce sarebbe la sensazione di vedere il diritto penale ridotto a escrescenza della Sharia islamica, la procura di Bologna in un avamposto talebano.
Ormai l’indagine contro Persichetti ha assunto un valore identitario e recedere, quando si è andati troppo oltre nell’ipotesi accusatoria, equivarrebbe a riconoscere un errore dalla portata troppo grande: il fallimento del teorema che lega vecchie e nuove Br e nega ogni discontinuità. Non mollare vuol dire dunque attaccarsi a ciò che resta: al portacomputer. Ed è qui che assistiamo a un evento miracoloso, l’improvvisa modificazione cromatica dello zaino che ne stempera il pigmento. D’altronde l’Italia è il paese delle madonne che lacrimano sangue, degli eczemi che si trasformano in stigmate. Perché stupirsi se anche la miscredente Bologna viene finalmente toccata dal segno divino?
Ad aggravare la situazione non ci sono solo degli investigatori che al massimo potrebbero rimpiazzare i Dupont presenti nei fumetti di Tintin, c’è anche un magistrato molto particolare, che è lì, se è vero quel che ha scritto Il Messaggero del 31 ottobre 2003: «Con il dolore e la rabbia di chi si è visto portare via un carissimo amico[…]. Un’amicizia di tanti anni, quelli della giovinezza, del matrimonio e della nascita dei figli, che Marco Biagi e Paolo Giovagnoli hanno visto crescere e diventare grandi insieme fino a quella tragica sera». Se ciò trovasse conferma – e l’assenza di ogni smentita suona come silenzio-assenso (2) – ci troveremmo di fronte a una insostenibile sovrapposizione di ruoli tra funzioni della pubblica accusa e interessi della parte civile. Verrebbe offuscata la fiducia nella serenità interiore del magistrato e atroce sarebbe la sensazione di vedere il diritto penale ridotto a escrescenza della Sharia islamica, la procura di Bologna in un avamposto talebano. Ormai l’indagine contro Persichetti ha assunto un valore identitario e recedere, quando si è andati troppo oltre nell’ipotesi accusatoria, equivarrebbe a riconoscere un errore dalla portata troppo grande: il fallimento del teorema che lega vecchie e nuove Br e nega ogni discontinuità. Non mollare vuol dire dunque attaccarsi a ciò che resta: al portacomputer. Ed è qui che assistiamo a un evento miracoloso, l’improvvisa modificazione cromatica dello zaino che ne stempera il pigmento. D’altronde l’Italia è il paese delle madonne che lacrimano sangue, degli eczemi che si trasformano in stigmate. Perché stupirsi se anche la miscredente Bologna viene finalmente toccata dal segno divino?
Una sprovveduta quarantenne con l’hobby delle passeggiate canine si trova così travolta in una storia troppo grande per le sue fragili spalle. Questa volta sono i carabinieri che entrano in azione quasi a voler bilanciare la loro assenza fino ad ora riscontrata nelle indagini. Un po’ di luci della ribalta spettano anche a loro. Chiamano la teste, la pressano, gli suggeriscono delle risposte, la condizionano. Se la lavorano insomma. E per lei è difficile dire di no. Tentenna, è esitante, non ricorda bene, ma alla fine finisce per sottoscrivere sempre la versione che l’Arma ha già confezionato. In una deposizione del 23 marzo 2002, di pochi giorni successiva all’attentato, quando la memoria era ancora fresca e i ricordi non ancora inquinati da pressioni successive, aveva raccontato di «uno zainetto color camoscio» portato in spalla da un individuo sospetto.
Il 30 novembre, sette mesi dopo, viene messa davanti a quattro borse, tra cui quella di Persichetti trafugata dalla procura romana. La messa in scena orchestrata è perfetta. Non c’è un solo zaino chiaro tra tutti quelli esposti. Addirittura una delle borse ha una forma allungata (come quelle sportive) con la cintola a tracolla. Un altro zaino è bicolore. Restano, in effetti, due sacchi in tinta unita. Uno è nero, l’altro è quello bleu marine di Persichetti. Siamo di fronte a quella che in gergo viene definita “tecnica a imbuto”, concepita per incanalare testi sovente fragili e sprovveduti, ansiosi di testimoniare il loro dovere di cittadini, ossequiosi delle istituzioni, e nella fattispecie delle uniformi. Nonostante gli sforzi predisposti per sollevarla dal peso del dubbio, la nostra testimone resta estremamente titubante. Sentiamola:
«Posso dire che il ricordo dello zaino che la persona portava a spalle non è molto nitido, comunque nella forma e nel colore può avvicinarsi ai primi due zaini che mi avete mostrato contrassegnati dai n° 1 e 2 [quello nero e quello blu di Persichetti, NdA].
Sicuramente il colore dello zaino non era molto scuro [e certo aveva parlato di color camoscio, nda] e per questo può avvicinarsi al secondo zaino, contrassegnato dal n° 2 [quello di Persichetti, NdA].»
Ma sì, perché non averci pensato prima? Il blu è meno scuro del nero, per questo può tranquillamente definirsi un colore chiaro. Di questo passo anche la notte più buia sarà splendente come il sole a mezzogiorno. Giovagnoli, riassumendo l’episodio nel rapporto inviato al GIP per chiedere il rigetto dell’istanza di dissequestro presentata dalla difesa nell’aprile 2003, scrive con imperturbabile candore: «La teste il 30-11-2002 ha riconosciuto lo zaino sopraindicato come quello portato dalla persona da lei notata nei pressi della casa del professor Biagi».
Vero, come un camoscio blu.

Tra gli inquirenti più daltonici spicca Vittorio Rizzi, “tutto chiacchiere e telefonini”, attuale capo della Mobile romana

Daltonico d’eccellenza: Paolo Giovagnoli
Link
Esilio e castigo, retroscena di una estradizione-1
La polizia del pensiero – Alain Brossat
Bologna, l’indagine occulta su Persichetti e il caso Biagi
Paolo Giovagnoli, quando il pm faceva le autoriduzioni
Paolo Giovagnoli, lo smemorato di Bologna
Storia della dottrina Mitterrand
Negato il permesso all’ex Br Paolo Persichetti per il libro che ha scritto
Note
1) Nei primi mesi del 1982, dopo il fallimento del sequestro del generale statunitense James Lee Dozier, le torture inflitte ai militanti catturati e le ondate di arresti che seguirono, quel che resta delle gruppo dirigente delle Br-Pcc lancia la proposta di una «ritirata strategica» che, prendendo atto delle dure sconfitte militari subite, avrebbe dovuto avviare una riflessione sulle prospettive della lotta armata e sulla necessità di ritornare ad un rapporto più interno con i propri settori sociali di riferimento.
2) In effetti, a conclusione dell’arringa pronunciata durante il processo in corte d’assise, Paolo Giovagnoli abbandonandosi ad alcuni istanti d’emozione ha ricordato questa amicizia.
2/ fine
 Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che ho scelto per nascere una calda giornata di agosto dentro una prigione speciale, in pieno articolo 90. Solo chi ha vissuto questa esperienza può capire l’immane volontà che serve per essere madre, dare al mondo e crescere una figlia tra le sbarre di un carcere. Solo chi è consapevole di questa prova può capire quanto questa scelta non sia una fuga nel personale, una soluzione egoista ma che sia la rappresentazione fisica di un pagina voltata. Questo è stato il suo modo per affermare che iniziava un nuovo percorso di vita, un diverso impegno sociale. Ed è anche grazie a questo nuovo stato di cose che otto anni dopo le è stato
Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che ho scelto per nascere una calda giornata di agosto dentro una prigione speciale, in pieno articolo 90. Solo chi ha vissuto questa esperienza può capire l’immane volontà che serve per essere madre, dare al mondo e crescere una figlia tra le sbarre di un carcere. Solo chi è consapevole di questa prova può capire quanto questa scelta non sia una fuga nel personale, una soluzione egoista ma che sia la rappresentazione fisica di un pagina voltata. Questo è stato il suo modo per affermare che iniziava un nuovo percorso di vita, un diverso impegno sociale. Ed è anche grazie a questo nuovo stato di cose che otto anni dopo le è stato  permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.
permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.
 all’ergastolo legata alla sua militanza nelle Brigate rosse durante gli anni 70. La notizia è stata battuta dalle agenzie lunedì in tarda serata.
Le parole degli Stati sono come le foglie morte che si lasciano trascinare dalla direzione del vento. Non più parole date ma parole vuote. Questo deve aver pensato Marina quando lunedì mattina si è vista notificare il decreto nella matricola del carcere di Fresnes.
La firma è arrivata dopo che per mesi le autorità parigine non facevano più mistero dell’imbarazzo che aveva suscitato la vicenda nelle stanze del governo. Di fronte alla Chambre e alla corte di Cassazione, che nei mesi scorsi hanno concesso il loro parere favorevole sulla conformità giuridica della richiesta d’estradizione, si era dissolto il maldestro tentativo con il quale l’allora presidente del consiglio Prodi e il suo guardasigilli Mastella avevano tentato di accreditare la cattura di una pericolosa latitante in attività. Altri non avevano esitato a richiamare il principio della certezza della pena, di quelle che almeno non sono andate prescritte nel frattempo. Evidentemente si percepiva un deficit di legittimità a distanza di tanti decenni. Per questo si è scelto di aggiornare le richieste d’estradizione ricorrendo ad ogni tipo d’espediente: congelando la personalità dei militanti di un tempo, avvalorando l’idea che l’essere non sia più un divenire ma un semplice essere stato, cristallizzato e fossilizzato.
Marina Petrella, invece, lavorava da anni per i servizi sociali del comune d’Argenteuil, si era risposata e aveva dato alla luce una seconda figlia che oggi ha 11 anni. Inoltre non era fuggita dall’Italia come una clandestina, ma aveva lasciato il paese quando si era arenata l’ipotesi di una soluzione politica per le “insorgenze” degli anni 70. Aveva già scontato otto anni di carcere, partorito e allattato la sua prima figlia nella sezione speciale del carcere femminile di Rebibbia.
La reticenza con la quale i consiglieri giuridici del governo francese avevano cominciato a guardare questo dossier si era rafforzata dopo l’improvviso crollo delle sue condizioni di salute. Ricoverata ad aprile nell’ospedale psichiatrico di VilleJuif (sud di Parigi), su richiesta urgente della direzione del carcere, a seguito di un grave stato
all’ergastolo legata alla sua militanza nelle Brigate rosse durante gli anni 70. La notizia è stata battuta dalle agenzie lunedì in tarda serata.
Le parole degli Stati sono come le foglie morte che si lasciano trascinare dalla direzione del vento. Non più parole date ma parole vuote. Questo deve aver pensato Marina quando lunedì mattina si è vista notificare il decreto nella matricola del carcere di Fresnes.
La firma è arrivata dopo che per mesi le autorità parigine non facevano più mistero dell’imbarazzo che aveva suscitato la vicenda nelle stanze del governo. Di fronte alla Chambre e alla corte di Cassazione, che nei mesi scorsi hanno concesso il loro parere favorevole sulla conformità giuridica della richiesta d’estradizione, si era dissolto il maldestro tentativo con il quale l’allora presidente del consiglio Prodi e il suo guardasigilli Mastella avevano tentato di accreditare la cattura di una pericolosa latitante in attività. Altri non avevano esitato a richiamare il principio della certezza della pena, di quelle che almeno non sono andate prescritte nel frattempo. Evidentemente si percepiva un deficit di legittimità a distanza di tanti decenni. Per questo si è scelto di aggiornare le richieste d’estradizione ricorrendo ad ogni tipo d’espediente: congelando la personalità dei militanti di un tempo, avvalorando l’idea che l’essere non sia più un divenire ma un semplice essere stato, cristallizzato e fossilizzato.
Marina Petrella, invece, lavorava da anni per i servizi sociali del comune d’Argenteuil, si era risposata e aveva dato alla luce una seconda figlia che oggi ha 11 anni. Inoltre non era fuggita dall’Italia come una clandestina, ma aveva lasciato il paese quando si era arenata l’ipotesi di una soluzione politica per le “insorgenze” degli anni 70. Aveva già scontato otto anni di carcere, partorito e allattato la sua prima figlia nella sezione speciale del carcere femminile di Rebibbia.
La reticenza con la quale i consiglieri giuridici del governo francese avevano cominciato a guardare questo dossier si era rafforzata dopo l’improvviso crollo delle sue condizioni di salute. Ricoverata ad aprile nell’ospedale psichiatrico di VilleJuif (sud di Parigi), su richiesta urgente della direzione del carcere, a seguito di un grave stato  di degradazione psico-fisica constatato dagli stessi periti nominati dal governo, Petrella è rimasta otto settimane in completo isolamento, in una “cella liscia” (assolutamente spoglia). Per tutto questo tempo non ha avuto contatti con l’esterno (divieto di colloqui con i familiari e di ricevere corrispondenza), salvo le visite del suo avvocato, Irène Terrel.
Le sollecitazioni politiche arrivate dall’Italia, dopo l’insediamento della Destra vittoriosa nelle elezioni del 13 aprile hanno probabilmente convinto le autorità francesi che era venuto il momento d’abbandonare ogni perplessità. Il suo avvocato ha già depositato un ricorso sospensivo della esecuzione dell’estradizione di fronte al Consiglio di Stato che fa leva sulla violazione del principio di irretroattività giuridica. In passato le autorità di Parigi avevano più volte rifiutato di attivare la procedura d’estradizione nei suoi confronti, e dunque ne avevano legittimato la presenza sul suolo francese del tutto consapevolmente. Altro punto sollevato è quello del tempo irragionevole intercorso tra i fatti addebitati e l’esecuzione penale della sentenza, oltre 30 anni di distanza.
Ma nel frattempo le condizioni psicologiche della Petrella si sono ulteriormente aggravate. Dimessa il 31 maggio per esser ricondotta in carcere, la direzione dell’istituto di pena ne ha chiesto un nuovo immediato ricovero. Tutti i medici che l’hanno visitata concordano, spiega sempre la Terrel, che si è di fronte ad una “grave tendenza suicidaria” provocata da una “caduta di spirito vitale”, una sorta di sciopero della vita di fronte alla prospettiva dell’ergastolo. I periti hanno constatato uno stato psicologico “posseduto dall’immagine del seppellimento”, dall’insopportabile idea di una morte senza lutto che si presenterebbe ogni settimana di fronte alle proprie figlie venute a rendergli visita. Quelle figlie che senza possibilità di scelta vedono la loro vita incagliata all’unico passato giudiziario e penale che non passa, momento imprescrittibile di una storia d’Italia che ha volentieri sotterrato e tuttora ingoia nell’oblio eccidi, massacri, ruberie. Un paese che ha dato forma ad un singolare paradosso: non ha conservato la memoria degli anni 70 ma è stata incapace d’oblio. Alla memoria storica svuotata dei fatti sociali ha sostituito la memoria giudiziaria, all’oblio penale ha sovrapposto l’oblio dei fatti sociali.
L’applicazione della clausola umanitaria, viene sottolineato nel ricorso, postilla acclusa in calce per volontà dello stesso Stato francese alla convenzione sulle estradizioni del 1957 che ha vigenza legale sul periodo in cui sono stati commessi i fatti contestati, rimane dunque l’extrema ratio di questa vicenda. I famigliari dei rifugiati italiani ed i diversi collettivi di sostegno hanno indetto una manifestazione per oggi in una piazza parigina a supporto di questa richiesta. Certo è che di quella dottrina Mitterrand che aveva tentato di offrire all’Italia delle forme d’uscita dalla spirale del confronto violento, leggendo quel che accadeva come un lacerante conflitto sociale, una latente condizione di guerra civile e non una immotivata e cieca violenza, è rimasto ben poco. Alla fine la zattera dei rifugiati, riparo precario d’esistenze sospese, è rimasta senza approdo davanti al porto della sua Itaca immaginaria.
di degradazione psico-fisica constatato dagli stessi periti nominati dal governo, Petrella è rimasta otto settimane in completo isolamento, in una “cella liscia” (assolutamente spoglia). Per tutto questo tempo non ha avuto contatti con l’esterno (divieto di colloqui con i familiari e di ricevere corrispondenza), salvo le visite del suo avvocato, Irène Terrel.
Le sollecitazioni politiche arrivate dall’Italia, dopo l’insediamento della Destra vittoriosa nelle elezioni del 13 aprile hanno probabilmente convinto le autorità francesi che era venuto il momento d’abbandonare ogni perplessità. Il suo avvocato ha già depositato un ricorso sospensivo della esecuzione dell’estradizione di fronte al Consiglio di Stato che fa leva sulla violazione del principio di irretroattività giuridica. In passato le autorità di Parigi avevano più volte rifiutato di attivare la procedura d’estradizione nei suoi confronti, e dunque ne avevano legittimato la presenza sul suolo francese del tutto consapevolmente. Altro punto sollevato è quello del tempo irragionevole intercorso tra i fatti addebitati e l’esecuzione penale della sentenza, oltre 30 anni di distanza.
Ma nel frattempo le condizioni psicologiche della Petrella si sono ulteriormente aggravate. Dimessa il 31 maggio per esser ricondotta in carcere, la direzione dell’istituto di pena ne ha chiesto un nuovo immediato ricovero. Tutti i medici che l’hanno visitata concordano, spiega sempre la Terrel, che si è di fronte ad una “grave tendenza suicidaria” provocata da una “caduta di spirito vitale”, una sorta di sciopero della vita di fronte alla prospettiva dell’ergastolo. I periti hanno constatato uno stato psicologico “posseduto dall’immagine del seppellimento”, dall’insopportabile idea di una morte senza lutto che si presenterebbe ogni settimana di fronte alle proprie figlie venute a rendergli visita. Quelle figlie che senza possibilità di scelta vedono la loro vita incagliata all’unico passato giudiziario e penale che non passa, momento imprescrittibile di una storia d’Italia che ha volentieri sotterrato e tuttora ingoia nell’oblio eccidi, massacri, ruberie. Un paese che ha dato forma ad un singolare paradosso: non ha conservato la memoria degli anni 70 ma è stata incapace d’oblio. Alla memoria storica svuotata dei fatti sociali ha sostituito la memoria giudiziaria, all’oblio penale ha sovrapposto l’oblio dei fatti sociali.
L’applicazione della clausola umanitaria, viene sottolineato nel ricorso, postilla acclusa in calce per volontà dello stesso Stato francese alla convenzione sulle estradizioni del 1957 che ha vigenza legale sul periodo in cui sono stati commessi i fatti contestati, rimane dunque l’extrema ratio di questa vicenda. I famigliari dei rifugiati italiani ed i diversi collettivi di sostegno hanno indetto una manifestazione per oggi in una piazza parigina a supporto di questa richiesta. Certo è che di quella dottrina Mitterrand che aveva tentato di offrire all’Italia delle forme d’uscita dalla spirale del confronto violento, leggendo quel che accadeva come un lacerante conflitto sociale, una latente condizione di guerra civile e non una immotivata e cieca violenza, è rimasto ben poco. Alla fine la zattera dei rifugiati, riparo precario d’esistenze sospese, è rimasta senza approdo davanti al porto della sua Itaca immaginaria. un circo Barnum e, come in un mattinale della questura, s’inventa pure un fantomatico dibattito tra ‘uscisti’ ed ‘entristi’ della lotta armata. Soprattutto prende di petto Oreste Scalzone, che dopo trent’anni ha avuto reati e condanna prescritti. Il suo è un minestrone di parole che ammucchiano colore, gossip, dicerie, fandonie, pregiudizi. Ce l’ha persino col loro modo di parlare. L’argot inevitabile d’ogni migrante che ha dovuto apprendere la nuova lingua per necessità. Ma poi aggiunge che alcuni tra loro pubblicano libri, fanno ricerca universitaria, aprono librerie e negozietti, senza rendersi conto della contraddizione. Ha da ridire anche sul fatto che non vestono Prada e si meraviglia di come si possa campare ventisei anni di espedienti, cioè di precariato. Domanda interessante, questa, che dovrebbe rivolgere ai cantori nostrani della deregolamentazione del mercato del lavoro.
un circo Barnum e, come in un mattinale della questura, s’inventa pure un fantomatico dibattito tra ‘uscisti’ ed ‘entristi’ della lotta armata. Soprattutto prende di petto Oreste Scalzone, che dopo trent’anni ha avuto reati e condanna prescritti. Il suo è un minestrone di parole che ammucchiano colore, gossip, dicerie, fandonie, pregiudizi. Ce l’ha persino col loro modo di parlare. L’argot inevitabile d’ogni migrante che ha dovuto apprendere la nuova lingua per necessità. Ma poi aggiunge che alcuni tra loro pubblicano libri, fanno ricerca universitaria, aprono librerie e negozietti, senza rendersi conto della contraddizione. Ha da ridire anche sul fatto che non vestono Prada e si meraviglia di come si possa campare ventisei anni di espedienti, cioè di precariato. Domanda interessante, questa, che dovrebbe rivolgere ai cantori nostrani della deregolamentazione del mercato del lavoro. Chi vede Parigi dagli appartamenti dei grandi boulevards, e guadagna con un solo articolo il corrispettivo di quattro stipendi da operaio e otto da precario nei call center, è preso d’angoscia di fronte ad una simile prospettiva e percepisce i marciapiedi delle città, il caldo maleodorante del suo reticolo sotterraneo di vie ferrate, come un’insidia dura e ingenerosa. Dante parlava dell’esilio con parole molto amare: «tu lascerai ogni cosa diletta/ […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Sarà che ognuno fa le sue esperienze, saranno le diavolerie della tecnologia, ma a Parigi ci sono tanti ascensori e infinite scale mobili e poi ad esser salato è il burro, non il pane. Insomma, se la città la vivi dai sottotetti dei quartieri popolari e multietnici, quella durezza diventa generosità, solidarietà, complicità naturale, intreccio di vite che arrivano da mille angoli del pianeta, ognuna con la sua valigia di storie. Scalzone, e altri come lui, tutto questo l’hanno vissuto sempre al presente, senza nostalgie, senza rimpianti e con le radici che ormai crescevano all’insù.
Chi vede Parigi dagli appartamenti dei grandi boulevards, e guadagna con un solo articolo il corrispettivo di quattro stipendi da operaio e otto da precario nei call center, è preso d’angoscia di fronte ad una simile prospettiva e percepisce i marciapiedi delle città, il caldo maleodorante del suo reticolo sotterraneo di vie ferrate, come un’insidia dura e ingenerosa. Dante parlava dell’esilio con parole molto amare: «tu lascerai ogni cosa diletta/ […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Sarà che ognuno fa le sue esperienze, saranno le diavolerie della tecnologia, ma a Parigi ci sono tanti ascensori e infinite scale mobili e poi ad esser salato è il burro, non il pane. Insomma, se la città la vivi dai sottotetti dei quartieri popolari e multietnici, quella durezza diventa generosità, solidarietà, complicità naturale, intreccio di vite che arrivano da mille angoli del pianeta, ognuna con la sua valigia di storie. Scalzone, e altri come lui, tutto questo l’hanno vissuto sempre al presente, senza nostalgie, senza rimpianti e con le radici che ormai crescevano all’insù.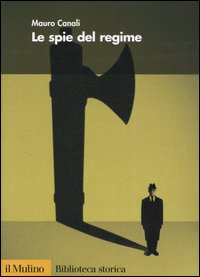 Immorale è il viaggio quando si rimane stranieri, ha scritto tempo fa Claudio Magris. E stranieri i fuoriusciti non lo sono mai stati. La nostalgia è stata quella degli altri, come racconta Milan Kundera, anche lui un tempo esiliato. Nóstos e Àlgos sono parole greche che indicano «ritorno» e «sofferenza». Nostalgia è dunque la tristezza che provoca l’impossibilità di tornare. Ma in altre lingue l’etimologia è diversa e trae origine dal latino ignorare. In questo caso, la nostalgia si esprime come «sofferenza per l’ignoranza» di non sapere quel che accade lontano da noi. Ma Scalzone, in tutti questi anni, non ha avuto il tempo di rimpiangere e ignorare proprio nulla, come Ulisse nell’alcova di Calipso. Coinvolto tra mille incontri e scoperte in tutte le battaglie della nuova modernità liquida, come la chiama Zygmunt Bauman: migranti, senza tetto, giovani delle banlieues, precari, altermondialisti, scioperi come quello generale del ’95, mentre a casa sua facevano tappa musicisti, poeti, teatranti e giramondo, scappati e scampati da magistrature, eserciti e polizie di mezzo mondo, compreso qualche fascista gravemente ammalato e un democristiano ricercato. Per farsi aprire bastava esibire come passaporto un mandato di cattura.
Immorale è il viaggio quando si rimane stranieri, ha scritto tempo fa Claudio Magris. E stranieri i fuoriusciti non lo sono mai stati. La nostalgia è stata quella degli altri, come racconta Milan Kundera, anche lui un tempo esiliato. Nóstos e Àlgos sono parole greche che indicano «ritorno» e «sofferenza». Nostalgia è dunque la tristezza che provoca l’impossibilità di tornare. Ma in altre lingue l’etimologia è diversa e trae origine dal latino ignorare. In questo caso, la nostalgia si esprime come «sofferenza per l’ignoranza» di non sapere quel che accade lontano da noi. Ma Scalzone, in tutti questi anni, non ha avuto il tempo di rimpiangere e ignorare proprio nulla, come Ulisse nell’alcova di Calipso. Coinvolto tra mille incontri e scoperte in tutte le battaglie della nuova modernità liquida, come la chiama Zygmunt Bauman: migranti, senza tetto, giovani delle banlieues, precari, altermondialisti, scioperi come quello generale del ’95, mentre a casa sua facevano tappa musicisti, poeti, teatranti e giramondo, scappati e scampati da magistrature, eserciti e polizie di mezzo mondo, compreso qualche fascista gravemente ammalato e un democristiano ricercato. Per farsi aprire bastava esibire come passaporto un mandato di cattura.  I nostalgici sono rimasti in Italia, alcuni perché hanno fatto degli anni ’70 l’oggetto del loro incarognito risentimento, come Sergio Segio. Uno che si racconta avvinto da un ineluttabile destino. «Non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo», scrive in un libro dove inanella una serie impressionante di goffe citazioni scapigliate, iscrivendosi nel «novero dei destinati alla sconfitta che non scelgono l’esilio ma di andare fino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Convinzione che lo porta a rivendicare una sorta di primazìa etica: l’aver prima commesso l’errore giusto ed in seguito aver ripudiato nel modo più giusto la giustezza dell’errore passato. Prova d’eccellenza assoluta, che giustificherebbe il suo irrefrenabile desiderio d’accedere allo status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista.
I nostalgici sono rimasti in Italia, alcuni perché hanno fatto degli anni ’70 l’oggetto del loro incarognito risentimento, come Sergio Segio. Uno che si racconta avvinto da un ineluttabile destino. «Non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo», scrive in un libro dove inanella una serie impressionante di goffe citazioni scapigliate, iscrivendosi nel «novero dei destinati alla sconfitta che non scelgono l’esilio ma di andare fino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Convinzione che lo porta a rivendicare una sorta di primazìa etica: l’aver prima commesso l’errore giusto ed in seguito aver ripudiato nel modo più giusto la giustezza dell’errore passato. Prova d’eccellenza assoluta, che giustificherebbe il suo irrefrenabile desiderio d’accedere allo status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista.
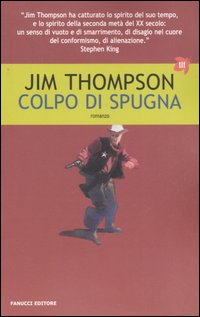 rappresenta da oltre vent’anni un’anticipazione del possibile, ciò che avrebbe potuto essere il futuro italiano se fosse stata varata una soluzione politica per gli anni ’70. Una smentita cocente per gli imprenditori dell’emergenza, un esempio da cancellare con ferocia e motivo d’incontenibile livore per chi tra dissociazioni e pentimenti, in cambio di laute ricompense premiali, non perde occasione di salire in cattedra e recitare l’autocritica degli altri.
rappresenta da oltre vent’anni un’anticipazione del possibile, ciò che avrebbe potuto essere il futuro italiano se fosse stata varata una soluzione politica per gli anni ’70. Una smentita cocente per gli imprenditori dell’emergenza, un esempio da cancellare con ferocia e motivo d’incontenibile livore per chi tra dissociazioni e pentimenti, in cambio di laute ricompense premiali, non perde occasione di salire in cattedra e recitare l’autocritica degli altri. Fu così che all’alba del giorno seguente venni scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori di ogni trasparenza, concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Quella furtiva consegna celava una flagrante violazione della legalità internazionale: una persona non può essere estradata per dei fatti posteriori a quelli indicati nel decreto, in assenza di una nuova richiesta e previa verifica del suo fondamento. Pur di avallare il teorema della centrale francese le autorità hanno agito aggirando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione europea sulle estradizioni.
Fu così che all’alba del giorno seguente venni scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori di ogni trasparenza, concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Quella furtiva consegna celava una flagrante violazione della legalità internazionale: una persona non può essere estradata per dei fatti posteriori a quelli indicati nel decreto, in assenza di una nuova richiesta e previa verifica del suo fondamento. Pur di avallare il teorema della centrale francese le autorità hanno agito aggirando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione europea sulle estradizioni.
 I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.
I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.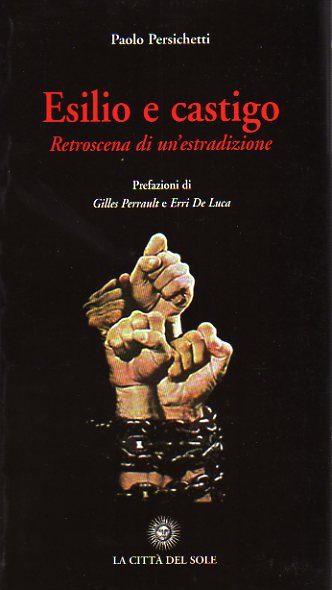




 mépris de la parole donnée au nom de la France par François Mitterrand puis par Lionel Jospin. Il a été livré la nuit même à la justice italienne pour purger une condamnation à 17 ans de prison sans aucun recours ni procédure d’appel. Aujourd’hui détenu à Viterbo, Paolo Persichetti développe dans ce livre, à partir de son cas personnel, une critique ravageuse de la procédure pénale italienne et de la collusion entre les déraisons d’Etat dont il est devenu l’otage. À travers la démystification de la « démocratie judiciaire » et son analyse de la « judiciarisation » de l’espace public, il conduit une réflexion de fond sur les refoulements et les pathologies d’une société italienne, hantée par ses années de plomb et refusant obstinément de tourner la page par une mesure d’amnistie.
mépris de la parole donnée au nom de la France par François Mitterrand puis par Lionel Jospin. Il a été livré la nuit même à la justice italienne pour purger une condamnation à 17 ans de prison sans aucun recours ni procédure d’appel. Aujourd’hui détenu à Viterbo, Paolo Persichetti développe dans ce livre, à partir de son cas personnel, une critique ravageuse de la procédure pénale italienne et de la collusion entre les déraisons d’Etat dont il est devenu l’otage. À travers la démystification de la « démocratie judiciaire » et son analyse de la « judiciarisation » de l’espace public, il conduit une réflexion de fond sur les refoulements et les pathologies d’une société italienne, hantée par ses années de plomb et refusant obstinément de tourner la page par une mesure d’amnistie.