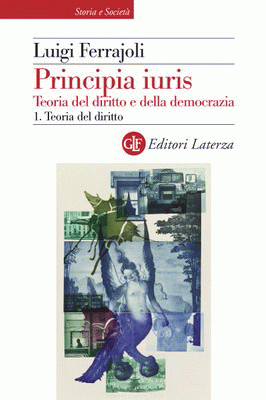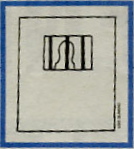Stupro Caffarella, nuove analisi: «Il dna non è dei romeni arrestati». Intanto uno dei due, Karol Racs denuncia maltrattamenti appena arrestato a Livorno e poi in Questura a Roma
Anita Cenci
Liberazione 6 marzo 2009
I nuovi test sulla comparazione del Dna, realizzati dal laboratorio dell’università di Roma diretto dalla professoressa Carla Vecchiotti, hanno confermato ancora una volta che le tracce biologiche rinvenute dopo lo stupro della Caffarella non appartengono a Alexandru Isztoika e Karol Racs, i due cittadini romeni accusati della brutale violenza.
Le situazione si aggrava per la squadra mobile e la procura di Roma che l’altro ieri hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale, in sostanza, fanno quadrato attorno alle indagini fino ad ora svolte. Per il questore Giuseppe Caruso, che ha parlato anche a nome dei magistrati, «l’impianto accusatorio non cambia di una virgola».
Ma dire che nulla cambia giacché tutto si è svolto secondo le regole, non aggiunge prove a quelle che già mancano. Per giunta questa ricostruzione è contestata dai due imputati, che hanno dichiarato ai parlamentari in visita nelle loro celle di aver subito violenze perché confessassero. «La notte che sono venuti a prendermi – ha raccontato Racs -, sono entrati i poliziotti romeni e mi hanno riempito di botte. Poi sono arrivati quelli italiani, e giù altre botte. Mi hanno trasferito a Roma, e gli investigatori mi hanno picchiato di nuovo». All’arrivo in carcere pare che fosse accompagnato da un verbale di pronto soccorso ed fosse pieno di contusioni.
Ora, nonostante il doppio esame del Dna li abbia scagionati, i due rimarranno comunque sotto custodia cautelare. Anche se lunedì prossimo il tribunale del riesame dovesse accogliere per entrambi la richiesta di scarcerazione avanzata dagli avvocati, procura e questura avrebbero comunque trovato il modo di mantenerli in detenzione.
Dal 5 marzo scorso, infatti, Racs è incriminato anche per la violenza sessuale compiuta su una donna, la sera del 21 gennaio in via Andersen, al Quartaccio. Il bassino stempiato che è entrato nella vicenda della Caffarella solo perché tirato in ballo dal suo connazionale, si è ritrovato travolto da una catena di sospetti nonostante la giovane vittima della violenza e il suo fidanzatino avessero inizialmente indicato un’altra persona e fornito un identikit completamente diverso dalla sua figura. Un micidiale dispositivo inquisitorio dove l’accusa ha trovato forza unicamente perché supportata da una seconda e così via. Una di quelle situazioni kafkiane in cui le smentite, piuttosto che indurre un po’ di buon senso, indispettiscono ancora di più chi muove le accuse. Il rischio è che la verità venga sacrificata di fronte alla necessità di tutelare la credibilità dell’autorità.
Intanto un nuovo colpo alle indagini è arrivato anche dalla donna di 41 anni, vittima dello stupro del Quartaccio, che ieri non ha confermato l’identificazione avvenuta durante l’incidente probatorio. «Era buio, avevano il cappuccio», ha detto la donna al Messaggero . La sensazione è che anche in questo caso Racs non c’entri nulla, ma sia stato coinvolto a causa di una potente suggestione mediatica che l’ha trasformato in un mostro da sbattere in prima pagina.
Più complicata è la posizione di Isztoika, il «biondino», a causa della sua confessione. Secondo gli investigatori non vi sarebbe nessun conflitto tra le «parole» e le «risultanze» scientifiche oggettive (il Dna), perché Isztoika avrebbe dimostrato di conoscere dettagli ancora ignoti alle indagini prima di esser ascoltato e solo successivamente verificate.
Per la polizia, anche se non fosse l’autore diretto del fatto, sarebbe comunque a conoscenza di come si è svolto e di chi l’avrebbe commesso. Per questo sarebbe pronta per lui, e per Racs, una nuova imputazione di favoreggiamento, oltre che di calunnia (per aver detto di aver subito violenze) e autocalunnia (per essersi accusato dello stupro).
Isztoika invece ribadisce che la confessione gli è stata estorta e il suo contenuto suggerito in dettaglio dai poliziotti romeni. Resta da capire se davvero egli abbia riferito circostanze ignote fino a quel momento. Lo varebbe fatto durante la videoregistrazione? Oppure prima? Vanno verificate anche le dichiarazioni di Racs, riportate da alcuni quotidiani, e nella quali spiega le confessione del suo coimputato perché: «terrorizzato da due romeni molto potenti, forse coinvolti nella vicenda».
Insomma le voci si accavallano e gli inquirenti, dietro la difesa delle loro indagini, sembrano in realtà confusi. Un cappotto con tracce di sangue, “dimenticato” nel bar dove i due fidanzatini erano stati soccorsi, è stato recuperato per essere sottoposto ad analisi. La sequenza del Dna di uno degli aggressori avrebbe trovato una parziale corrispondenza con quella di un altro cittadino romeno, in carcere nel suo paese da mesi.
Nel frattempo l’ingrato mondo della politica, quei partigiani della tolleranza zero che avevano in precedenza osannato gli investigatori, ora scaricano su di loro il flop di una politica “razzista” della sicurezza che crea invece insicurezza, perché la gente ha capito che alla fine i veri stupratori sono fuori. Il sindaco Alemanno, che si era precipitato ad indicare negli immigrati delle est i naturali colpevoli, ora dice che non vuole innocenti in carcere. Indagini e politica, un intreccio fatale. In questura avranno capito la lezione?
È sempre giallo sui due rumeni arrestati
Il Dna non c’è, ma per gli inquirenti: «L’accusa regge»
Stefano Galieni
Liberazione 5 marzo 2009
La Procura della Repubblica di Roma e la questura, con un comunicato congiunto, hanno confermato l’impianto accusatorio nei confronti dei due cittadini rumeni accusati dello stupro ai danni di una ragazzina, la sera del 14 febbraio a Roma. Il fatto che dai primi riscontri il Dna dei due risulti incompatibile e che le prove a carico sembrino sgretolarsi giorno dopo giorno, non sembra portare verso la ricerca di altre piste per assicurare alla giustizia i responsabili di questo odioso delitto. Mihai Muntean è segretario generale del Partito dei rumeni in Italia (8.000 iscritti che in questo periodo stanno aumentando considerevolmente), con contatti in tutti i Comuni in cui è forte la concentrazione rumena. Si sente nell’occhio del ciclone e non accetta che la sua comunità passi per essere composta da delinquenti e stupratori. «L’accanimento è iniziato con l’atroce omicidio della signora Reggiani – racconta – I reati sono diventati un pretesto per accanirsi contro una comunità composta per la maggior parte da lavoratori che pagano le tasse e vogliono vivere in pace, rispettando le leggi. Ma si è deciso di fare campagna politica e informativa facendo leva sulla sensibilità delle persone, arrivando a confermare l’equazione immigrato=delinquente». Mihai denuncia come su questo si sia costruito un “capitale elettorale” e si sia creata una tensione difficile da smorzare, in cui crescono il sospetto e la paura reciproca, ma anche veri e propri gravi e mai sufficientemente condannati episodi di xenofobia e di razzismo: «Hanno incendiato negozi gestiti da rumeni, sono stati picchiati cittadini inermi e si è arrivati ad emanare un decreto assurdo come quello sulle ronde che a mio avviso rappresentano una vera e propria dichiarazione di impotenza e di fallimento da parte dello stato». Sono in molti nella sua comunità a denunciare l’inutilità e la pericolosità delle ronde nate su questa isteria generale, sono molti a dire che aumentano il senso di criminalizzazione di una intera comunità, ad accorgersi di come le istituzioni che dovrebbero rassicurare l’opinione pubblica, scelgano di sostituire le forze dell’ordine demandate alla prevenzione e alla repressione dei reati con dei pensionati. E’ infuriata anche Halina Harja, giornalista di “Realitatea tv”, una emittente in lingua molto seguita in Italia: «Non mi sembra normale o giusto organizzare una conferenza stampa, come ha fatto la questura di Roma, all’inizio e non alla chiusura delle indagini, sbattendo i “mostri rumeni in prima pagina”. Si è violata la fondamentale presunzione di innocenza, potevano aspettare l’esito degli esami e dei riscontri. Ma non è la prima volta che accade: nel settembre del 2007 due fratelli rumeni vennero arrestati per lo stupro di una donna a Torino. Dopo tre mesi di carcere sono stati prosciolti, anche allora l’esame del Dna provò che erano innocenti. La corte di appello ha condannato lo Stato italiano ad un risarcimento per ingiusta detenzione dei due, ma questa notizia è finita in un trafiletto nascosto fra le tante notizie mentre all’atto dell’arresto i giornali avevano parlato ampiamente del caso». Tanto Mihai quanto Halina sono allarmati degli effetti concreti di questa campagna mediatica e politica contro i rumeni: dicono che diventa sempre più difficile per i propri concittadini trovare casa in affitto, un lavoro, mantenere relazioni stabili con gli italiani con cui invece c’è storicamente una vicinanza storica, culturale e linguistica. Oltre 200 anni fa si andava in Romania per cercare fortuna e molti italiani rimasero lì, tanto che i discendenti sono considerati minoranza linguistica a cui garantire diritti fra cui un deputato in parlamento. Ma questo si dimentica, come si dimenticano, è ancora Mihai a ricordarlo, i tanti e biunivoci rapporti di partenariato economico: imprenditori italiani che hanno delocalizzato la propria produzione in Romania, e imprenditori rumeni che si stanno affermando in Italia. Ma questi non fanno notizia, di loro non si parla. Colpa anche del fatto che la comunità rumena è ancora frammentata e cerca scarsamente di essere presente sia politicamente che per riacquisire spazio nell’informazione. «Io mi chiedo perché siamo arrivati ad una legge fatta di due pesi e due misure – domanda retoricamente Sebastian Zlotea, del Prc – Certi reati vanno puniti con severità estrema indipendentemente dal paese di provenienza di chi li commette. Ma in Italia non solo questo non vale più, ma se è un mio connazionale a commettere un reato perché la responsabilità deve ricadere sull’intera comunità?». I tre concordano sulla necessità che la comunità rumena sia maggiormente presente nella politica e nella società, anche visto l’avvicinarsi di scadenze elettorali. Ma intanto oggi ci potrebbero essere due innocenti in galera e due stupratori liberi, non importa di quale nazionalità, in grado di ripetere il reato.
Link
Quartaccio-Caffarella, l’uso politico dello stupro 1
È razzismo parlare di Dna romeno 2
L’inchiesta sprofonda 3
Quando il teorema vince sulle prove 4
Non esiste il cromosoma romeno 6
L’accanimento giudiziario 7
La difesa di Racs denuncia maltrattamenti 8
Parlano i conoscenti di Racs 9
Non sono colpevoli ma restano in carcere 10
Racs non c’entra 11
Negativi i test del Dna fatti in Romania 12
Stupro della Caffarella 13
Stupro del Quartaccio, scarcerato Racs 14
Cosa si nasconde dietro la confessione di Loyos? 15
Racs innocente e senza lavoro 16
La fabbrica dei mostri 17
Loyos picchiato dalla polizia per confessare il falso 18