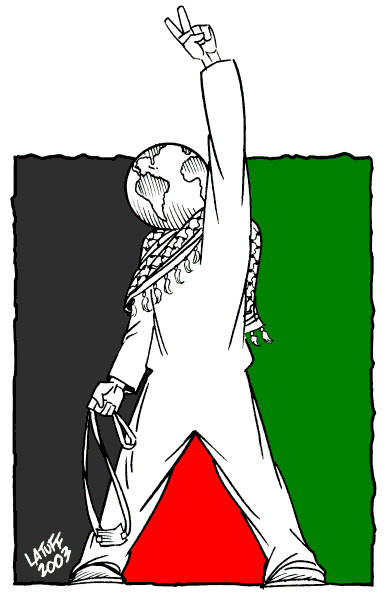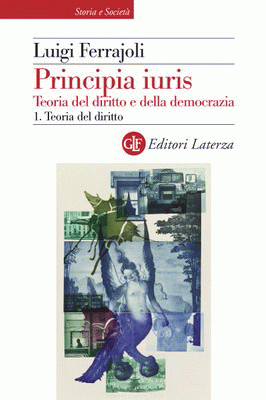Il Riesame: non sono i colpevoli, revocati gli arresti ma i due romeni restano in carcere per altri reati: Racs per lo stupro di Primavalle, Loyos per calunnia
Anita Cenci
Liberazione 11 marzo 2009
Alla fine di una lunga camera di consiglio, il tribunale del riesame di Roma ha revocato nella serata di ieri la custodia cautelare per Alexandru Loyos Isztoika e Karol Racz, i due cittadini romeni accusati dello stupro di un’adolescente e dell’aggressione del fidanzatino la sera del 14 febbraio scorso nel parco romano della Caffarella. Nel dispositivo si legge che il collegio, presieduto da Francesco Taurisano, «annulla l’ordinanza in epigrafe disponendo l’immediata liberazione degli indagati se non detenuti per altro». I due, però, restano ancora in carcere. Investigatori e inquirenti di fronte ai primi scricchiolii dell’inchiesta si erano subito premuniti predisponendo un castello d’accuse supplementare che consentisse comunque la permanenza in stato di detenzione dei due. Racz perché sospettato di un’altra violenza sessuale, avvenuta il 21 gennaio al Quartaccio, un altro quartiere della capitale. Accusa che a questo punto è destinata a crollare. Anche qui, infatti, la mancata identificazione del suo dna nei reperti biologici della violenza non consente di sostenere a lungo un’accusa fondata unicamente su riconoscimento dalle caratteristiche molto fragili, e che non risponde nemmeno alla descrizione dell’aggressore fatta dalla vittima.
Loyos, il biondino, invece si è visto notificare, pochi minuti dopo la decisione del riesame, un’ordinanza di custodia cautelare per calunnia e autocalunnia. Provvedimento emesso dal gip Guglielmo Muntoni, su richiesta del pm Vincenzo Barba (lo stesso che ha diretto le indagini sulla Caffarella) per le affermazioni contenute nella confessione e poi nella ritrattazione. Secondo l’articolo 368 del codice penale, infatti, «Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato», incorre nel reato di calunnia.
Crolla così l’impianto accusatorio messo in piedi dalla questura e fin troppo acriticamente sostenuto dalla procura che aveva chiesto nell’udienza di lunedì la conferma dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip Valerio Savio il 20 febbraio. Accolte invece le tesi esposte dalla difesa dei due stranieri. Le motivazioni del riesame non sono state ancora rese note ma è presumibile che il collegio abbia fondato la propria decisione in base alle risultanze fornite dalle analisi del dna fatte dalla polizia scientifica. I reperti raccolti avevano rilevato la presenza di due profili diversi dall’impronta genetica dei due romeni arrestati. L’evidenza scientifica ha dunque premiato sui riconoscimenti foto-segnaletici, da sempre incerti e suggestionabili e sulle parole, quando queste non sono supportate da riscontri esterni verificati. In effetti, l’adolescente era molto ferma nel riconoscimento del “biondino”, anche se in un primo momento aveva indicato un’altra persona, quel Ciprian Chiosci, il “monco”, subito scagionato dalla polizia romena (pare sia un suo informatore) e sul quale sono poi tornati a gravitare nuovi sospetti. “Identificazione” smentita dal dna.
Gli investigatori hanno cercato in tutti i modi di confermare la presenza sul teatro della violenza dei due romeni, anche solo come semplici spettatori, pali, favoreggiatori, avanzando l’ipotesi della «banda di balordi». Ma anche qui, fino ad ora, si sono dovuti scontrare con il muro delle evidenze probatorie: i dati scientifici raccolti non comprovano altre presenze oltre a quella delle due vittime e dei due aggressori. Allo stesso modo le testimonianze dei due ragazzi, e quella del superteste, il medico tirato fuori come un asso nella manica durante il riesame, ribadiscono che sul luogo sono state viste soltanto «due persone», che seppure vengono identificate nelle foto segnaletiche, non assomigliano alle descrizioni fornite negli identikit. Un classico delle inchieste in cui la presenza di un forte intervento mediatico inquina le immagini dei sospetti, le proietta fino a moltiplicarne le apparizioni in ogni angolo di strada.
Inevitabilmente l’inchiesta dovrà ripartire da capo e soprattutto dovranno chiarirsi alcuni aspetti ancora oscuri: cosa è accaduto in questura nelle prime ore dell’arresto dei due romeni?
Racz è stato refertato all’ingresso in carcere. Ha chiari segni di percosse che la polizia giustifica con il “tentativo di resistenza” messo in atto. Isztoika nel verbale della ritrattazione sostiene di essere stato pestato dalla polizia romena affinché si autoaccusasse dello stupro. Infine quella conferenza stampa trionfalistica in questura, quelle interviste sui giornali che tiravano la volata al governo, che in quelle ore si accingeva a varare un nuovo pacchetto sicurezza con tanto di ronde, restano una pagina vergognosa compiuta, ancora una volta, sul corpo di una giovane donna.
Link
Quartaccio-Caffarella, l’uso politico dello stupro 1
È razzismo parlare di Dna romeno 2
L’inchiesta sprofonda 3
Quando il teorema vince sulle prove 4
Tante botte per trovare prove che non ci sono 5
Non esiste il cromosoma romeno 6
L’accanimento giudiziario 7
La difesa di Racs denuncia maltrattamenti 8
Parlano i conoscenti di Racs 9
Racs non c’entra 11
Negativi i test del Dna fatti in Romania 12
Stupro della Caffarella 13
Stupro del Quartaccio, scarcerato Racs 14
Cosa si nasconde dietro la confessione di Loyos? 15
Racs innocente e senza lavoro 16
La fabbrica dei mostri 17
Loyos picchiato dalla polizia per confessare il falso 18

 persone hanno manifestato ieri pomeriggio in tutta la Francia per chiedere la fine della sanguinosa aggressione militare dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza. A Parigi, all’arrivo del corteo in piazza dell’Opéra, i reparti mobili hanno fatto uso di granate lacrimogene per disperdere i manifestanti che tentavano di forzare i cancelli esterni dell’Opéra Garnier. Preoccupato per l’accentuarsi delle tensioni intercomunitarie, il primo ministro francese, François Fillon, aveva annunciato nella serata di venerdì, al termine di una riunione ministeriale dedicata al razzismo e all’antisemitismo, che tutte le manifestazioni di sostegno alla popolazione di Gaza sarebbero state strettamente sorvegliate per impedire ogni forma di «incitamento all’odio raziale e alla violenza razzista e antisemita». Scalpore hanno suscitato in Olanda gli slogan paranazisti («Hamas, Hamas, porta gli ebrei nelle camere a gas»)
persone hanno manifestato ieri pomeriggio in tutta la Francia per chiedere la fine della sanguinosa aggressione militare dell’esercito israeliano nella striscia di Gaza. A Parigi, all’arrivo del corteo in piazza dell’Opéra, i reparti mobili hanno fatto uso di granate lacrimogene per disperdere i manifestanti che tentavano di forzare i cancelli esterni dell’Opéra Garnier. Preoccupato per l’accentuarsi delle tensioni intercomunitarie, il primo ministro francese, François Fillon, aveva annunciato nella serata di venerdì, al termine di una riunione ministeriale dedicata al razzismo e all’antisemitismo, che tutte le manifestazioni di sostegno alla popolazione di Gaza sarebbero state strettamente sorvegliate per impedire ogni forma di «incitamento all’odio raziale e alla violenza razzista e antisemita». Scalpore hanno suscitato in Olanda gli slogan paranazisti («Hamas, Hamas, porta gli ebrei nelle camere a gas»)  gridati durante un corteo di sostegno alla popolazione palestinese nella città di Rotterdam. Hassen Chalghoumi, imam di Drancy, snodo ferroviario situato a nord di Parigi da dove partivano durante la repubblica di Vichy i treni diretti nei campi di concentramento, conosciuto per il suo impegno in favore del dialogo con la comunità ebraica, ha subito un attentato incendiario e pesanti intimidazioni. Aggressioni di studenti di origine magrebina sono avvenuti di fronte alla scuole di Parigi da parte di militanti della Led (Lega di difesa ebraica). L’importazione del conflitto israelo-palestinese sta allarmando molte cancellerie europee. Il timore è che l’offensiva militare di Tel Aviv torni a infiammare nuovamente le banlieues, abitate in prevalenza da popolazioni d’origine immigrata, di seconda e terza generazione, provenienti da paesi arabi. Si spiegano così, almeno in parte, le recenti iniziative diplomatiche promosse dal presidente francese Nicolas Sarkozy e dirette a favorire una tregua. Dall’inizio dei sanguinosi bombardamenti, imponenti manifestazioni hanno attraversato le città francesi, spesso contrassegnate da incidenti e scontri violenti con la polizia. Secondo il ministero degli Interni il 10 gennaio scorso oltre
gridati durante un corteo di sostegno alla popolazione palestinese nella città di Rotterdam. Hassen Chalghoumi, imam di Drancy, snodo ferroviario situato a nord di Parigi da dove partivano durante la repubblica di Vichy i treni diretti nei campi di concentramento, conosciuto per il suo impegno in favore del dialogo con la comunità ebraica, ha subito un attentato incendiario e pesanti intimidazioni. Aggressioni di studenti di origine magrebina sono avvenuti di fronte alla scuole di Parigi da parte di militanti della Led (Lega di difesa ebraica). L’importazione del conflitto israelo-palestinese sta allarmando molte cancellerie europee. Il timore è che l’offensiva militare di Tel Aviv torni a infiammare nuovamente le banlieues, abitate in prevalenza da popolazioni d’origine immigrata, di seconda e terza generazione, provenienti da paesi arabi. Si spiegano così, almeno in parte, le recenti iniziative diplomatiche promosse dal presidente francese Nicolas Sarkozy e dirette a favorire una tregua. Dall’inizio dei sanguinosi bombardamenti, imponenti manifestazioni hanno attraversato le città francesi, spesso contrassegnate da incidenti e scontri violenti con la polizia. Secondo il ministero degli Interni il 10 gennaio scorso oltre