Paolo Persichetti: La justice italienne ne sera pas tendre avec Marina Petrella
par Maguy Day
Mediapart 17 luglio 2008
Premier réfugié italien à être extradé en 2002 après onze ans passés en France en toute légalité, Paolo Persichetti, ancien militant de l’Union des communistes combattants (Udcc), était enseignant en sciences politiques à Paris VIII quand il fut enlevé et extradé en 2002, sur décision du gouvernement Raffarin, au mépris de la parole donnée au nom de la France par François Mitterrand puis par Lionel Jospin depuis le milieu des années 1980.
Que pensez-vous des déclarations de Nicolas Sarkozy selon lequel «dans le droit italien, et le droit ça compte, pour avoir le droit au pardon et à la grâce il faut se repentir, que Mme Petrella réfléchisse à ça» (Propos de Nicolas Sarkozy à Strasbourg le 10 juillet 2008)?
Je m’étonne qu’un pays comme la France si attaché à la laïcité, et qui a légiféré sur les signes religieux ostentatoires dans l’espace scolaire, utilise, par la voix de son président, le terme de pardon, à connotation éthico-religieuse. Une notion qui devrait rester confinée au domaine privé et au for intérieur de chaque individu. Quant aux termes «demande de pardon», «expression de regrets» ou encore «repentir» en Italie, ils ont acquis un sens et une portée particulière qu’il est important d’expliciter. Dans la loi italienne, le «ravvedimento», synonyme de «repenti», est prévu uniquement en cas de liberté conditionnelle. Il n’est pas requis pour les autres mesures d’aménagement des peines telles que les permissions, la semi-liberté ou les remises de peines. De toute façon, et uniquement en cas de libération conditionnelle, les juges cherchent à établir s’il y a eu un parcours de «rééducation du passé déviant» avec absence de dangerosité sociale. Ainsi ce type de «repentir» n’entre même pas en ligne de compte pour la concession d’une grâce. Selon une jurisprudence de la cour de
cassation, le «pardon» ne doit en aucun cas être une posture psychologique ou idéologique du condamné. Il est en revanche lié à son comportement durant l’exécution de sa peine dans la mesure où il fournit la preuve d’une critique de ces choix de vie passés. Le «repentir» et le «pardon» renvoient dans les religions monothéistes à de longs processus de «contrition» personnelle. La transformation de cette pratique en «marché des indulgences» et des «péchés de simonie» fut un des thèmes théologiques qui provoquèrent la réforme de Martin Luther au XVe siècle. Or l’Italie comme la France semblent vouloir suivre cette voie. Pourtant, le droit moderne est issu d’une nette séparation entre responsabilité et culpabilité. Il s’attache à des comportement factuels externes, mesurables et vérifiables par tous, comme celui de Marina Petrella ces 27 dernières années.
Et surtout, désormais en Italie, le terme «repenti» a pris une tout autre signification après l’élaboration des lois spéciales en 1979, usurpant celle jusqu’alors utilisée. En 1979, un mécanisme de réduction de peine expressément lié à une collaboration procédurale est apparu dans le système pénal italien, appelé «collaboration judiciaire» qui est en fait une «acquisition d’impunité». Cet accord permet à un homme de se transformer en délateur rejetant la responsabilité pénale sur d’autres qu’il accuse et qui eux refusent ce marché. Il est arrivé à de multiples reprises que des prisonniers ou des réfugiés italiens expriment leurs condoléances pour la souffrance infligée, sans pour autant accepter un tel marchandage. Leurs postures restent incomprises, alors que se multiplient ces «collaborations» pénales. De plus, au lendemain de la décision de Bolzaneto [suite aux événements du sommet du G8 à Gênes en 2001], qui entérine l’impunité de l’Etat vis-à-vis de la torture, un délit qui n’existe pas en Italie, il devient difficile de discuter de la question de la douleur, si pour un camp elle n’est pas reconnue.
Premier réfugié italien extradé en 2002 par le gouvernement français, vous bénéficiez aujourd’hui d’un régime de semi-liberté. Marina Petrella pourrait-elle en bénéficier si la France persiste dans sa volonté de l’extrader ?
Pas du tout. D’abord parce que Marina qui a déjà passé huit ans derrière les barreaux en Italie et onze mois en France s’est vu
refuser une confusion des peines. Donc, une fois en Italie, elle devra recommencer sa peine depuis le commencement jusqu’à
perpétuité. De zéro à l’infini. Selon les lois en vigueur et puisqu’elle a été condamnée à la perpétuité, elle devra attendre dix
ans avant d’envisager de déposer une demande de permission de 45 jours par an. Habituellement, elles sont accordées quelques années après, soit vers la quinzième année. Le régime de semiliberté ne peut être demandé qu’après la vingtième année. Pour cette femme de 54 ans, mère de deux enfants, c’est pratiquement une condamnation à mort.
Sans compter que le président de la commission justice au sénat, Filippo Berselli, du parti alliance nationale (ex-fascistes) a
déposé un projet de loi, discuté en septembre 2008, qui prévoit la fin des aménagements de peine et en particulier pour les condamnés à perpétuité. Le régime de semi-liberté et celui de la libération conditionnelle, qui peut être demandée après 26 ans derrière les barreaux, risquent d’être supprimés. Marina Petrella ne pourra alors bénéficier des remises de peines qui ont été concédées dans les années 1990 aux autres prisonniers politiques, en lieu et place de l’amnistie.
En quoi consiste votre quotidien depuis votre récente mise en semi-liberté ?
C’est une vie normée par les interdits. Les rencontres, la vie sociale, les trajets sont circonscrits. C’est une vie chronométrée. Je quitte la prison à 7h00 du matin pour y retourner à 22h30. Entre les deux, je dois être à mon domicile pendant certaines tranches horaires. Puis je dois me rendre sur mon lieu de travail et ne pas m’en éloigner. Je me déplace avec mes livres, mes documents qui, d’ailleurs, m’ont été volés hier dans le coffre de mon scooter. Mais au moins je ne suis pas rongé par l’inactivité forcée, l’oisiveté intellectuelle et physique incontournables dans le système carcéral.
Que cachent ces procédures d’extradition relancées entre l’Italie et la France ?
Après l’attentat mortel contre Marco Biagi, conseiller du gouvernement italien tué en mars 2002 par un nouveau groupuscule reprenant le vieux logo des Brigades rouges-Pcc, les autorités italiennes étaient à la recherche d’un coupable. Plus tard, au printemps 2003, les pièces de la commission rogatoire internationale, demandée par la justice italienne et réalisée par la division nationale anti-terroriste (Dnat) sous la direction du juge Bruguière, ont montré qu’à l’été 2002 la magistrature de Bologne et l’antiterrorisme italien ont sollicité les autorités françaises afin qu’elle me repère et m’arrête dans le cadre de l’enquête Biagi et non pas pour le vieux décret d’extradition. Finalement, l’extradition ne portait pas sur les faits de 1987 pour
lesquels j’avais été acquitté une première fois en 1989, et puis condamné en appel à 22 ans et 6 mois. Ces faits-là étaient partiellement prescrits. Et comme le précisait le décret signé par le premier ministre Edouard Balladur en septembre 1994, l’extradition était engagée «pourvu que les condamnations ne soient pas prescrites». Manifestement le décret n’était plus valable. Pour m’extrader il fallait faire une nouvelle demande d’extradition pour la seule peine qui était encore en vigueur… Ils ont préféré régler l’affaire autrement… sous le tunnel du Mont-Blanc où j’ai été livré comme un colis. A en croire les autorités italiennes, les attentats de 1999 et 2002 étaient le résultat de l’action déstabilisatrice des exilés parisiens qui, sous couvert de la doctrine Mitterrand, auraient installé un véritable sanctuaire de la lutte armée dans la capitale française. Le montage était politiquement bien soigné puisque l’attaque portait contre deux personnages connus pour s’engager pour une amnistie des réfugiés italiens : Oreste Scalzone et moi-même. En effet, avec l’exportation de l’enquête Biagi en France, l’Italie pouvait finalement régler ses comptes avec la doctrine Mitterrand et les tenants de l’amnistie. Le paradoxe de toute l’affaire, c’est que ni Scalzone ni moi-même n’avons fait partie des Brigades rouges-Pcc. On nous a collé une identité politique qui ne nous appartenait pas. L’enquête à mon encontre concernant Biagi a été classée en novembre 2004 par un non-lieu prononcé car «l’hypothèse même de l’accusation n’avait pas de fondement». Cela n’a de facto rien changé à mon parcours pénitencier bien compromis par une rentrée en Italie marquée par une accusation très lourde pour les faits des années 80. J’ai obtenu un régime de semi-liberté non pas à la moitié mais presque aux deux tiers de la peine. Ce qui est encore plus grave, ce sont les motivations des rejets qui, pendant quatre ans, ont marqué mes demandes. A plusieurs reprises le juge d’application des peines (Jap) s’en est pris à mon livre Exil et châtiment dans lequel je racontais les dessous de l’extradition et contre mes articles publiés dans la presse, remettant en question mon droit de libre parole et ma liberté de pensée. Les mêmes sujets qui, en France, m’avaient permis d’accéder au doctorat et d’enseigner à l’Université avaient pour le Jap italien un contenu criminel très dangereux. Mes liens avec les professeurs de Paris VIII étaient considérés comme la preuve de «contacts avec des milieux influents» qui auraient pu me soutenir dans la fuite. Seul mon transfert à Rome et le changement de Jap m’a permis en janvier 2008 de sortir une première fois en permission et le 31 mai 2008 d’être remis en semi-liberté.
Qu’est-ce que l’Italie a retenu de ces «années de plomb»?
Je ne voudrais pas donner l’impression de me soustraire à l’attention et au respect que demandent les familles endeuillées à la suite d’actions politiques réalisées par des groupes de la gauche révolutionnaire dans les années 1970. Mais alors que chaque camp pleure ses morts, on assiste aujourd’hui à une victimisation sélective. De 1945 à 1969, près de 200 manifestants, grévistes, occupants de terres ou d’usines, étudiants, ouvriers ou paysans ont été tués par les forces de police dans des opérations de rétablissement de l’ordre public. Ces crimes restent impunis à ce jour. Ce n’est pas pour rien que le parti communiste italien demandait alors le désarmement des forces de police en charge des manifestations publiques. La violence politique a été une pratique de l’Etat italien qui a contribué à structurer le conflit socio-politique. Elle n’a pas été introduite par la gauche. A partir de 1969, et pendant une décennie, les attentats néofascistes sur les places, dans les gares et les trains ont fait des centaines de morts. Il a été démontré que les services secrets italiens et les néofascistes étaient impliqués. Et là encore, ces crimes sont restent en grande majorité impunis. Le premier homicide politique de gauche du commissaire Calabresi a eu lieu en 1972. Et c’est seulement en 1976 que les Brigades rouges ont choisi de passer à ce type de stratégie. Il faut avoir à l’esprit ce climat pour comprendre et expliquer la violence politique de la gauche italienne et des militants qui ont hérité du poids de tous ces morts. Ce contexte est aujourd’hui totalement oublié et on tend à décrier ces années comme une crise de violence folle et aveugle provenant de la seule extrême gauche. De plus, durant cette période, la répression pénale a atteint des records. Entre 1970 et 1989, si l’on additionne les peines de prisons infligées pour des faits liés à la violence politique, on atteint 50.000 années. La génération qui avait 20 ans dans les années 1970-80 est la plus sanctionnée de l’histoire de l’Italie depuis l’unification de l’Etat en 1861. Dans le camp de la gauche, 4.087 militants ont été condamnés pour «des actes liés à des tentatives de subversion de l’ordre constitutionnel», appartenance à des «as- sociations subversives» ou pour «constitution de bandes armées». Sur les 1.337 personnes condamnées appartenant à la «famille» des Brigades rouges, en activité pendant 18 ans, 70% des inculpés étaient des ouvriers, des employés du tertiaire ou des étudiants. Comme le montrent les chiffres, une bonne partie des inculpés sont des militants originaires des villes du Sud qui au lendemain de la guerre sont venus travailler dans les centres industriels du triangle Turin, Milan, Gênes. Cette vague de migration, qui se prolonge jusqu’au début des années 1970, donne naissance à un nouveau type d’ouvriers, très radicalisés (ainsi durant «l’automne chaud» de 1969 et les événements de 1972-1973), et plus tard à une constellation de jeunes «enragés», issus du prolétariat des banlieues, qui accèdent en masse à l’instruction supérieure après 1968.
D’autres pays ont-ils accueilli des réfugiés italiens? Ont-ils pratiqué des extraditions?
En effet, mis à part la France, le Brésil, le Nicaragua, l’Argentine, la Grece et le Canada ont également accueilli des militants d’extrême gauche. Seule l’Algérie a livré à la justice italienne les deux militants de gauche qui se trouvaient sur son territoire. Ceux d’extrême droite ont été accueillis par la Grande-Bretagne, avec une forme équivalente de la doctrine Mitterrand qu’on pourrait appeler la «doctrine Thatcher». Les autorités judiciaires et politiques britanniques ont refusé d’extrader ces militants, appliquant la même politique tenue par la France durant la même période, mais cela n’a pas provoqué de débat ou polémique, que ce soit en Italie ou en Europe. Une fois les condamnations prescrites, ces hommes sont rentrés en Italie. Le Liban, le Japon, l’Espagne de Franco puis l’Espagne démocratique et les dictatures sud-américaines ont également accueilli plusieurs de ces militants. Et le leader d’extrême droite, Roberto Fiore, de Forza nuova, est même député au parlement européen.


 Nell’edizione in edicola ieri, sia Libération che le Monde hanno dedicato ampio spazio alla vicenda, riportando stralci delle perizie mediche che descrivono «uno stato depressivo gravissimo», traversato da «una crisi suicidaria sincera» assolutamente «incompatibile con la detenzione». La Petrella definisce la sua cella una «camera mortuaria» e ripete che a questo punto la sua morte «è l’unico regalo d’amore che potrò fare alle mie figlie perché permetterà loro d’elaborare finalmente il lutto» che il carcere a vita impedirebbe. Intervistato, Louis Joinet, l’architetto della dottrina Mitterrand, spiega che ovunque nel mondo «la maggior parte dei processi di ritorno alla pace o alla democrazia comportano un margine d’impunità e passano per una amnistia». In Italia gli anni erogati e scontati raggiungono la cifra di 50mila. Ancora troppo pochi? Lo stato di salute della Petrella e l’opportunità di curarla fuori dal carcere erano già stati evocati dalla signora Carla Bruni-Sarkozy in una intervista apparsa il 20 giugno sempre su Libération. Dando prova di una inattesa apertura, la prima donna di Francia aveva risposto a una precisa domanda sulla sorte da riservare ai rifugiati italiani sfuggendo i tradizionali cori giustizialisti che ormai echeggiano su entrambi i versanti delle Alpi.
Nell’edizione in edicola ieri, sia Libération che le Monde hanno dedicato ampio spazio alla vicenda, riportando stralci delle perizie mediche che descrivono «uno stato depressivo gravissimo», traversato da «una crisi suicidaria sincera» assolutamente «incompatibile con la detenzione». La Petrella definisce la sua cella una «camera mortuaria» e ripete che a questo punto la sua morte «è l’unico regalo d’amore che potrò fare alle mie figlie perché permetterà loro d’elaborare finalmente il lutto» che il carcere a vita impedirebbe. Intervistato, Louis Joinet, l’architetto della dottrina Mitterrand, spiega che ovunque nel mondo «la maggior parte dei processi di ritorno alla pace o alla democrazia comportano un margine d’impunità e passano per una amnistia». In Italia gli anni erogati e scontati raggiungono la cifra di 50mila. Ancora troppo pochi? Lo stato di salute della Petrella e l’opportunità di curarla fuori dal carcere erano già stati evocati dalla signora Carla Bruni-Sarkozy in una intervista apparsa il 20 giugno sempre su Libération. Dando prova di una inattesa apertura, la prima donna di Francia aveva risposto a una precisa domanda sulla sorte da riservare ai rifugiati italiani sfuggendo i tradizionali cori giustizialisti che ormai echeggiano su entrambi i versanti delle Alpi. Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che
Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che  permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.
permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura. all’ergastolo legata alla sua militanza nelle Brigate rosse durante gli anni 70. La notizia è stata battuta dalle agenzie lunedì in tarda serata.
Le parole degli Stati sono come le foglie morte che si lasciano trascinare dalla direzione del vento. Non più parole date ma parole vuote. Questo deve aver pensato Marina quando lunedì mattina si è vista notificare il decreto nella matricola del carcere di Fresnes.
La firma è arrivata dopo che per mesi le autorità parigine non facevano più mistero dell’imbarazzo che aveva suscitato la vicenda nelle stanze del governo. Di fronte alla Chambre e alla corte di Cassazione, che nei mesi scorsi hanno concesso il loro parere favorevole sulla conformità giuridica della richiesta d’estradizione, si era dissolto il maldestro tentativo con il quale l’allora presidente del consiglio Prodi e il suo guardasigilli Mastella avevano tentato di accreditare la cattura di una pericolosa latitante in attività. Altri non avevano esitato a richiamare il principio della certezza della pena, di quelle che almeno non sono andate prescritte nel frattempo. Evidentemente si percepiva un deficit di legittimità a distanza di tanti decenni. Per questo si è scelto di aggiornare le richieste d’estradizione ricorrendo ad ogni tipo d’espediente: congelando la personalità dei militanti di un tempo, avvalorando l’idea che l’essere non sia più un divenire ma un semplice essere stato, cristallizzato e fossilizzato.
Marina Petrella, invece, lavorava da anni per i servizi sociali del comune d’Argenteuil, si era risposata e aveva dato alla luce una seconda figlia che oggi ha 11 anni. Inoltre non era fuggita dall’Italia come una clandestina, ma aveva lasciato il paese quando si era arenata l’ipotesi di una soluzione politica per le “insorgenze” degli anni 70. Aveva già scontato otto anni di carcere, partorito e allattato la sua prima figlia nella sezione speciale del carcere femminile di Rebibbia.
La reticenza con la quale i consiglieri giuridici del governo francese avevano cominciato a guardare questo dossier si era rafforzata dopo l’improvviso crollo delle sue condizioni di salute. Ricoverata ad aprile nell’ospedale psichiatrico di VilleJuif (sud di Parigi), su richiesta urgente della direzione del carcere, a seguito di un grave stato
all’ergastolo legata alla sua militanza nelle Brigate rosse durante gli anni 70. La notizia è stata battuta dalle agenzie lunedì in tarda serata.
Le parole degli Stati sono come le foglie morte che si lasciano trascinare dalla direzione del vento. Non più parole date ma parole vuote. Questo deve aver pensato Marina quando lunedì mattina si è vista notificare il decreto nella matricola del carcere di Fresnes.
La firma è arrivata dopo che per mesi le autorità parigine non facevano più mistero dell’imbarazzo che aveva suscitato la vicenda nelle stanze del governo. Di fronte alla Chambre e alla corte di Cassazione, che nei mesi scorsi hanno concesso il loro parere favorevole sulla conformità giuridica della richiesta d’estradizione, si era dissolto il maldestro tentativo con il quale l’allora presidente del consiglio Prodi e il suo guardasigilli Mastella avevano tentato di accreditare la cattura di una pericolosa latitante in attività. Altri non avevano esitato a richiamare il principio della certezza della pena, di quelle che almeno non sono andate prescritte nel frattempo. Evidentemente si percepiva un deficit di legittimità a distanza di tanti decenni. Per questo si è scelto di aggiornare le richieste d’estradizione ricorrendo ad ogni tipo d’espediente: congelando la personalità dei militanti di un tempo, avvalorando l’idea che l’essere non sia più un divenire ma un semplice essere stato, cristallizzato e fossilizzato.
Marina Petrella, invece, lavorava da anni per i servizi sociali del comune d’Argenteuil, si era risposata e aveva dato alla luce una seconda figlia che oggi ha 11 anni. Inoltre non era fuggita dall’Italia come una clandestina, ma aveva lasciato il paese quando si era arenata l’ipotesi di una soluzione politica per le “insorgenze” degli anni 70. Aveva già scontato otto anni di carcere, partorito e allattato la sua prima figlia nella sezione speciale del carcere femminile di Rebibbia.
La reticenza con la quale i consiglieri giuridici del governo francese avevano cominciato a guardare questo dossier si era rafforzata dopo l’improvviso crollo delle sue condizioni di salute. Ricoverata ad aprile nell’ospedale psichiatrico di VilleJuif (sud di Parigi), su richiesta urgente della direzione del carcere, a seguito di un grave stato  di degradazione psico-fisica constatato dagli stessi periti nominati dal governo, Petrella è rimasta otto settimane in completo isolamento, in una “cella liscia” (assolutamente spoglia). Per tutto questo tempo non ha avuto contatti con l’esterno (divieto di colloqui con i familiari e di ricevere corrispondenza), salvo le visite del suo avvocato, Irène Terrel.
Le sollecitazioni politiche arrivate dall’Italia, dopo l’insediamento della Destra vittoriosa nelle elezioni del 13 aprile hanno probabilmente convinto le autorità francesi che era venuto il momento d’abbandonare ogni perplessità. Il suo avvocato ha già depositato un ricorso sospensivo della esecuzione dell’estradizione di fronte al Consiglio di Stato che fa leva sulla violazione del principio di irretroattività giuridica. In passato le autorità di Parigi avevano più volte rifiutato di attivare la procedura d’estradizione nei suoi confronti, e dunque ne avevano legittimato la presenza sul suolo francese del tutto consapevolmente. Altro punto sollevato è quello del tempo irragionevole intercorso tra i fatti addebitati e l’esecuzione penale della sentenza, oltre 30 anni di distanza.
Ma nel frattempo le condizioni psicologiche della Petrella si sono ulteriormente aggravate. Dimessa il 31 maggio per esser ricondotta in carcere, la direzione dell’istituto di pena ne ha chiesto un nuovo immediato ricovero. Tutti i medici che l’hanno visitata concordano, spiega sempre la Terrel, che si è di fronte ad una “grave tendenza suicidaria” provocata da una “caduta di spirito vitale”, una sorta di sciopero della vita di fronte alla prospettiva dell’ergastolo. I periti hanno constatato uno stato psicologico “posseduto dall’immagine del seppellimento”, dall’insopportabile idea di una morte senza lutto che si presenterebbe ogni settimana di fronte alle proprie figlie venute a rendergli visita. Quelle figlie che senza possibilità di scelta vedono la loro vita incagliata all’unico passato giudiziario e penale che non passa, momento imprescrittibile di una storia d’Italia che ha volentieri sotterrato e tuttora ingoia nell’oblio eccidi, massacri, ruberie. Un paese che ha dato forma ad un singolare paradosso: non ha conservato la memoria degli anni 70 ma è stata incapace d’oblio. Alla memoria storica svuotata dei fatti sociali ha sostituito la memoria giudiziaria, all’oblio penale ha sovrapposto l’oblio dei fatti sociali.
L’applicazione della clausola umanitaria, viene sottolineato nel ricorso, postilla acclusa in calce per volontà dello stesso Stato francese alla convenzione sulle estradizioni del 1957 che ha vigenza legale sul periodo in cui sono stati commessi i fatti contestati, rimane dunque l’extrema ratio di questa vicenda. I famigliari dei rifugiati italiani ed i diversi collettivi di sostegno hanno indetto una manifestazione per oggi in una piazza parigina a supporto di questa richiesta. Certo è che di quella dottrina Mitterrand che aveva tentato di offrire all’Italia delle forme d’uscita dalla spirale del confronto violento, leggendo quel che accadeva come un lacerante conflitto sociale, una latente condizione di guerra civile e non una immotivata e cieca violenza, è rimasto ben poco. Alla fine la zattera dei rifugiati, riparo precario d’esistenze sospese, è rimasta senza approdo davanti al porto della sua Itaca immaginaria.
di degradazione psico-fisica constatato dagli stessi periti nominati dal governo, Petrella è rimasta otto settimane in completo isolamento, in una “cella liscia” (assolutamente spoglia). Per tutto questo tempo non ha avuto contatti con l’esterno (divieto di colloqui con i familiari e di ricevere corrispondenza), salvo le visite del suo avvocato, Irène Terrel.
Le sollecitazioni politiche arrivate dall’Italia, dopo l’insediamento della Destra vittoriosa nelle elezioni del 13 aprile hanno probabilmente convinto le autorità francesi che era venuto il momento d’abbandonare ogni perplessità. Il suo avvocato ha già depositato un ricorso sospensivo della esecuzione dell’estradizione di fronte al Consiglio di Stato che fa leva sulla violazione del principio di irretroattività giuridica. In passato le autorità di Parigi avevano più volte rifiutato di attivare la procedura d’estradizione nei suoi confronti, e dunque ne avevano legittimato la presenza sul suolo francese del tutto consapevolmente. Altro punto sollevato è quello del tempo irragionevole intercorso tra i fatti addebitati e l’esecuzione penale della sentenza, oltre 30 anni di distanza.
Ma nel frattempo le condizioni psicologiche della Petrella si sono ulteriormente aggravate. Dimessa il 31 maggio per esser ricondotta in carcere, la direzione dell’istituto di pena ne ha chiesto un nuovo immediato ricovero. Tutti i medici che l’hanno visitata concordano, spiega sempre la Terrel, che si è di fronte ad una “grave tendenza suicidaria” provocata da una “caduta di spirito vitale”, una sorta di sciopero della vita di fronte alla prospettiva dell’ergastolo. I periti hanno constatato uno stato psicologico “posseduto dall’immagine del seppellimento”, dall’insopportabile idea di una morte senza lutto che si presenterebbe ogni settimana di fronte alle proprie figlie venute a rendergli visita. Quelle figlie che senza possibilità di scelta vedono la loro vita incagliata all’unico passato giudiziario e penale che non passa, momento imprescrittibile di una storia d’Italia che ha volentieri sotterrato e tuttora ingoia nell’oblio eccidi, massacri, ruberie. Un paese che ha dato forma ad un singolare paradosso: non ha conservato la memoria degli anni 70 ma è stata incapace d’oblio. Alla memoria storica svuotata dei fatti sociali ha sostituito la memoria giudiziaria, all’oblio penale ha sovrapposto l’oblio dei fatti sociali.
L’applicazione della clausola umanitaria, viene sottolineato nel ricorso, postilla acclusa in calce per volontà dello stesso Stato francese alla convenzione sulle estradizioni del 1957 che ha vigenza legale sul periodo in cui sono stati commessi i fatti contestati, rimane dunque l’extrema ratio di questa vicenda. I famigliari dei rifugiati italiani ed i diversi collettivi di sostegno hanno indetto una manifestazione per oggi in una piazza parigina a supporto di questa richiesta. Certo è che di quella dottrina Mitterrand che aveva tentato di offrire all’Italia delle forme d’uscita dalla spirale del confronto violento, leggendo quel che accadeva come un lacerante conflitto sociale, una latente condizione di guerra civile e non una immotivata e cieca violenza, è rimasto ben poco. Alla fine la zattera dei rifugiati, riparo precario d’esistenze sospese, è rimasta senza approdo davanti al porto della sua Itaca immaginaria.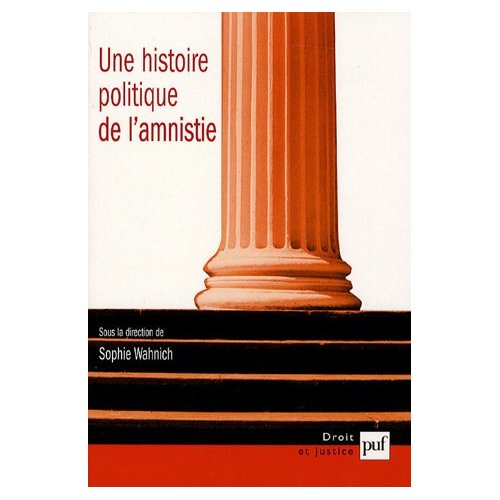 Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati.
Ma alla fine del Novecento una drastica inversione di tendenza sospinge paesi e società civili occidentali a ripudiare questo strumento di soluzione dei conflitti. Ciò non è vero ovunque, basti pensare alla Gran Bretagna di Blair che, nell’ambito del processo di soluzione politica della questione nord-irlandese, ha amnistiato tutti i militanti coinvolti negli scontri armati. Anche se l’esperienza più innovatrice viene dal Sud Africa di Mandela che, ispirandosi ai principi della giustizia ricostruttiva, ha scartato la via penale tradizionale per istituire un criterio d’accertamento dei fatti in cambio di clemenza e risarcimento pubblico delle vittime. Operazione che però ha messo sullo steso piano la violenza istituzionale che appoggiava il sistema segregazionista e quella antistituzionale che lottava in armi contro l’apartheid. Ipotesi che terrorizzerebbe qualsiasi esponente, passato e presente, dello Stato italiano chiamato a dover rispondere delle stragi della strategia della tensione e delle centinaia di morti che hanno insanguinato la gestione dell’ordine pubblico nei primi decenni della repubblica, quando nessuno a Sinistra aveva ancora scelto la via della violenza. Tuttavia queste due esperienze restano episodi minoritari rispetto ad un diritto penale internazionale sempre più ostile alle istituzioni della clemenza. Proprio dal tentativo di trovare una risposta a questo discredito parte l’opera collettanea curata da Sophie Wahnich, storica e ricercatrice del Cnrs, Une histoire politique de l’amnistie. Il volume, frutto di una ricerca multidisciplinare avviata nel 2003 e condotta su scala comparativa tra diversi paesi europei, poggia sulla convinzione che ormai, date le interdipendenze, una soluzione amnistiale per le insorgenze politiche degli anni 70-80 possa essere trovata unicamente coinvolgendo i livelli istituzionali dell’Unione europea, attraverso nuove forme di clemenza sopranazionale. Storicamente le amnistie sono state sempre accompagnate da dispositivi di riscrittura della storia, spesso opposti tra loro: far dimenticare, accertare la verità o renderla illeggibile. Molto diversa è poi la natura delle clemenze che sanciscono forme d’impunità preventiva, tipiche dei poteri costituiti, come accaduto per le dittature militari sudamericane o per i colpi di spugna sui reati economico-finanziari. In questo caso l’amnistia ha aiutato l’oscuramento dei fatti. Altro significato hanno invece le clemenze che temperano, dopo decenni di carcere, le dure repressioni contro gli oppositori politici, ripristinando quando ormai gli eventi sono ampiamente accertati una situazione di normalità giudiziaria stravolta dalle misure d’eccezione. Ma tutte queste distinzioni scompaiono di fronte all’attuale tendenza a voler confondere qualunque amnistia con l’impunità. È questo l’atteggiamento tenuto in Italia da un ceto politico che ha tutto l’interesse a far dimenticare le proprie ascendenze riversando sui reprobi degli anni 70 le pagine più ingombranti del proprio Novecento. Una rimozione che impedendo la chiusura del decennio 70 riemerge continuamente sotto forma di spettri che agitano fobie, polemiche, grottesche imitazioni del passato, ciniche speculazioni delle agenzie repressive, col risultato di avvelenare lo spazio pubblico. Ma la regressione della clemenza ha altre ragioni ancora più strutturali che investono la mutazione dei sistemi politici occidentali insieme all’emergere impetuoso del paradigma vittimario. Le democrazie occidentali sono ben lontane dal costituire degli esempi di superamento dell’inimicizia politica. E ciò, anche in ragione di un’ideologia umanitaria che attorno al «criterio dell’inerme» ha perso ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali, o quell’orrorismo di cui ha recentemente scritto Adriana Cavarero (Feltrinelli 2007), e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza. In realtà chi dice umanità vuole ingannare, metteva in guardia Proudhon. Il diritto penale umanitario (tragico ossimoro) è divenuto lo strumento di distinzione tra bene e male, tra barbaro e civilizzato, favorendo l’emergere di assoluti etico-morali che depoliticizzano e destoricizzano sistematicamente gli eventi, fino a smarrire la differenza che passa tra l’illegalità degli oppressi e quella dei poteri costituiti. Non stupisce allora che la retorica umanitaria sia diventata la nuova arma ideologica con la quale gli Stati hanno moltiplicato guerre e spogliato della loro veste politica le infrazioni commesse da chi si organizza contro l’oppressione, relegandole a mera fattispecie criminale. Ma non tutti gli assoluti servono per essere rispettati, così nulla impedisce di scendere a patti con i tagliatori di teste Talebani, o chi pratica lo sterminio suicida come Hamas, mentre era assolutamente vietato negoziare con le Br. In questo caso il criterio non è più l’umano e l’inumano ma l’omologia tra le entità statali costituite dell’Occidente e quelle in formazione degli islamisti, radicalmente opposte al demone della rivoluzione sociale. Ciò rende più comprensibile anche quel grande stupro di senso che ha portato ad accomunare in un’unica giornata, non certo per ragioni di pietas, il ricordo delle vittime delle stragi di Stato e quelle della lotta armata. Resta da capire dove collocare i morti ammazzati come Pinelli o le centinaia di manifestanti falciati, dal 1946 fino a Carlo Giuliani, dalle forze dell’ordine. Vicende storiche opposte e inconciliabili sono riassunte in un unico paradigma che nulla c’entra col dolore ma assolve unicamente il potere. Altro che ricerca della verità e tentativo di riconciliazione. Il Sud Africa è lontano e le vittime delle stragi muoiono una seconda volta. L’uso strumentale della figura della vittima è uno dei passaggi centrali di questo processo, a cui è dedicato un intero capitolo nel quale si spiega che il diritto alla riparazione simbolica dell’offeso è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Questo processo di privatizzazione della giustizia trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica. Il sistema giudiziario perde il suo ruolo di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di riparazione psicologica della persona offesa. Una svolta culturale cui sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam. Ma può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile per il mezzo di una condanna penale? In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all’elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza e l’ostracismo perpetuo restano l’unica soluzione accettabile perché il proscioglimento o la reintegrazione civile dell’accusato ostacolerebbe la guarigione mentale della vittima. L’uso strumentale della retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell’onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l’aggravamento delle sanzioni, la limitazione dei diritti dell’accusato e l’immoralità delle amnistie, fino al paradossale esercizio di un’etica selettiva che perde improvvisamente tutta la sua intransigenza di fronte a quella ragion di Stato che premia pentiti e dissociati. un circo Barnum e, come in un mattinale della questura, s’inventa pure un fantomatico dibattito tra ‘uscisti’ ed ‘entristi’ della lotta armata. Soprattutto prende di petto Oreste Scalzone, che dopo trent’anni ha avuto reati e condanna prescritti. Il suo è un minestrone di parole che ammucchiano colore, gossip, dicerie, fandonie, pregiudizi. Ce l’ha persino col loro modo di parlare. L’argot inevitabile d’ogni migrante che ha dovuto apprendere la nuova lingua per necessità. Ma poi aggiunge che alcuni tra loro pubblicano libri, fanno ricerca universitaria, aprono librerie e negozietti, senza rendersi conto della contraddizione. Ha da ridire anche sul fatto che non vestono Prada e si meraviglia di come si possa campare ventisei anni di espedienti, cioè di precariato. Domanda interessante, questa, che dovrebbe rivolgere ai cantori nostrani della deregolamentazione del mercato del lavoro.
un circo Barnum e, come in un mattinale della questura, s’inventa pure un fantomatico dibattito tra ‘uscisti’ ed ‘entristi’ della lotta armata. Soprattutto prende di petto Oreste Scalzone, che dopo trent’anni ha avuto reati e condanna prescritti. Il suo è un minestrone di parole che ammucchiano colore, gossip, dicerie, fandonie, pregiudizi. Ce l’ha persino col loro modo di parlare. L’argot inevitabile d’ogni migrante che ha dovuto apprendere la nuova lingua per necessità. Ma poi aggiunge che alcuni tra loro pubblicano libri, fanno ricerca universitaria, aprono librerie e negozietti, senza rendersi conto della contraddizione. Ha da ridire anche sul fatto che non vestono Prada e si meraviglia di come si possa campare ventisei anni di espedienti, cioè di precariato. Domanda interessante, questa, che dovrebbe rivolgere ai cantori nostrani della deregolamentazione del mercato del lavoro. Chi vede Parigi dagli appartamenti dei grandi boulevards, e guadagna con un solo articolo il corrispettivo di quattro stipendi da operaio e otto da precario nei call center, è preso d’angoscia di fronte ad una simile prospettiva e percepisce i marciapiedi delle città, il caldo maleodorante del suo reticolo sotterraneo di vie ferrate, come un’insidia dura e ingenerosa. Dante parlava dell’esilio con parole molto amare: «tu lascerai ogni cosa diletta/ […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Sarà che ognuno fa le sue esperienze, saranno le diavolerie della tecnologia, ma a Parigi ci sono tanti ascensori e infinite scale mobili e poi ad esser salato è il burro, non il pane. Insomma, se la città la vivi dai sottotetti dei quartieri popolari e multietnici, quella durezza diventa generosità, solidarietà, complicità naturale, intreccio di vite che arrivano da mille angoli del pianeta, ognuna con la sua valigia di storie. Scalzone, e altri come lui, tutto questo l’hanno vissuto sempre al presente, senza nostalgie, senza rimpianti e con le radici che ormai crescevano all’insù.
Chi vede Parigi dagli appartamenti dei grandi boulevards, e guadagna con un solo articolo il corrispettivo di quattro stipendi da operaio e otto da precario nei call center, è preso d’angoscia di fronte ad una simile prospettiva e percepisce i marciapiedi delle città, il caldo maleodorante del suo reticolo sotterraneo di vie ferrate, come un’insidia dura e ingenerosa. Dante parlava dell’esilio con parole molto amare: «tu lascerai ogni cosa diletta/ […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Sarà che ognuno fa le sue esperienze, saranno le diavolerie della tecnologia, ma a Parigi ci sono tanti ascensori e infinite scale mobili e poi ad esser salato è il burro, non il pane. Insomma, se la città la vivi dai sottotetti dei quartieri popolari e multietnici, quella durezza diventa generosità, solidarietà, complicità naturale, intreccio di vite che arrivano da mille angoli del pianeta, ognuna con la sua valigia di storie. Scalzone, e altri come lui, tutto questo l’hanno vissuto sempre al presente, senza nostalgie, senza rimpianti e con le radici che ormai crescevano all’insù.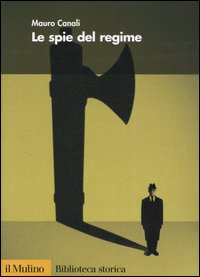 Immorale è il viaggio quando si rimane stranieri, ha scritto tempo fa Claudio Magris. E stranieri i fuoriusciti non lo sono mai stati. La nostalgia è stata quella degli altri, come racconta Milan Kundera, anche lui un tempo esiliato. Nóstos e Àlgos sono parole greche che indicano «ritorno» e «sofferenza». Nostalgia è dunque la tristezza che provoca l’impossibilità di tornare. Ma in altre lingue l’etimologia è diversa e trae origine dal latino ignorare. In questo caso, la nostalgia si esprime come «sofferenza per l’ignoranza» di non sapere quel che accade lontano da noi. Ma Scalzone, in tutti questi anni, non ha avuto il tempo di rimpiangere e ignorare proprio nulla, come Ulisse nell’alcova di Calipso. Coinvolto tra mille incontri e scoperte in tutte le battaglie della nuova modernità liquida, come la chiama Zygmunt Bauman: migranti, senza tetto, giovani delle banlieues, precari, altermondialisti, scioperi come quello generale del ’95, mentre a casa sua facevano tappa musicisti, poeti, teatranti e giramondo, scappati e scampati da magistrature, eserciti e polizie di mezzo mondo, compreso qualche fascista gravemente ammalato e un democristiano ricercato. Per farsi aprire bastava esibire come passaporto un mandato di cattura.
Immorale è il viaggio quando si rimane stranieri, ha scritto tempo fa Claudio Magris. E stranieri i fuoriusciti non lo sono mai stati. La nostalgia è stata quella degli altri, come racconta Milan Kundera, anche lui un tempo esiliato. Nóstos e Àlgos sono parole greche che indicano «ritorno» e «sofferenza». Nostalgia è dunque la tristezza che provoca l’impossibilità di tornare. Ma in altre lingue l’etimologia è diversa e trae origine dal latino ignorare. In questo caso, la nostalgia si esprime come «sofferenza per l’ignoranza» di non sapere quel che accade lontano da noi. Ma Scalzone, in tutti questi anni, non ha avuto il tempo di rimpiangere e ignorare proprio nulla, come Ulisse nell’alcova di Calipso. Coinvolto tra mille incontri e scoperte in tutte le battaglie della nuova modernità liquida, come la chiama Zygmunt Bauman: migranti, senza tetto, giovani delle banlieues, precari, altermondialisti, scioperi come quello generale del ’95, mentre a casa sua facevano tappa musicisti, poeti, teatranti e giramondo, scappati e scampati da magistrature, eserciti e polizie di mezzo mondo, compreso qualche fascista gravemente ammalato e un democristiano ricercato. Per farsi aprire bastava esibire come passaporto un mandato di cattura.  I nostalgici sono rimasti in Italia, alcuni perché hanno fatto degli anni ’70 l’oggetto del loro incarognito risentimento, come Sergio Segio. Uno che si racconta avvinto da un ineluttabile destino. «Non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo», scrive in un libro dove inanella una serie impressionante di goffe citazioni scapigliate, iscrivendosi nel «novero dei destinati alla sconfitta che non scelgono l’esilio ma di andare fino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Convinzione che lo porta a rivendicare una sorta di primazìa etica: l’aver prima commesso l’errore giusto ed in seguito aver ripudiato nel modo più giusto la giustezza dell’errore passato. Prova d’eccellenza assoluta, che giustificherebbe il suo irrefrenabile desiderio d’accedere allo status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista.
I nostalgici sono rimasti in Italia, alcuni perché hanno fatto degli anni ’70 l’oggetto del loro incarognito risentimento, come Sergio Segio. Uno che si racconta avvinto da un ineluttabile destino. «Non c’è salvezza possibile per chi ha sognato di cambiare il mondo», scrive in un libro dove inanella una serie impressionante di goffe citazioni scapigliate, iscrivendosi nel «novero dei destinati alla sconfitta che non scelgono l’esilio ma di andare fino in fondo, pagando quel che bisogna pagare al sogno a lungo coltivato». Convinzione che lo porta a rivendicare una sorta di primazìa etica: l’aver prima commesso l’errore giusto ed in seguito aver ripudiato nel modo più giusto la giustezza dell’errore passato. Prova d’eccellenza assoluta, che giustificherebbe il suo irrefrenabile desiderio d’accedere allo status di persona non comune che un tempo si diceva persino comunista.
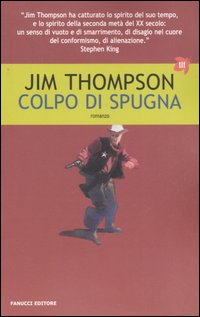 rappresenta da oltre vent’anni un’anticipazione del possibile, ciò che avrebbe potuto essere il futuro italiano se fosse stata varata una soluzione politica per gli anni ’70. Una smentita cocente per gli imprenditori dell’emergenza, un esempio da cancellare con ferocia e motivo d’incontenibile livore per chi tra dissociazioni e pentimenti, in cambio di laute ricompense premiali, non perde occasione di salire in cattedra e recitare l’autocritica degli altri.
rappresenta da oltre vent’anni un’anticipazione del possibile, ciò che avrebbe potuto essere il futuro italiano se fosse stata varata una soluzione politica per gli anni ’70. Una smentita cocente per gli imprenditori dell’emergenza, un esempio da cancellare con ferocia e motivo d’incontenibile livore per chi tra dissociazioni e pentimenti, in cambio di laute ricompense premiali, non perde occasione di salire in cattedra e recitare l’autocritica degli altri. contrapponendoli a quelli del capitale. Il fatto che ormai – sostiene Della Loggia – nessuna delle contraddizioni moderne nasca più dalla lotta di classe avrebbe provocato il definitivo declino di questa cultura politica a vantaggio (o svantaggio, secondo i punti di vista) di una mutazione antropologica della sinistra, succube del dominio «edonistico-acquisitivo» (che tradotto potremmo definire: abbandono al piacere consumistico) di una società individualista, antistatalista, avvinta dall’egemonia aggressiva di un’etica soggettivista e libertina. Defunta sarebbe dunque l’anima sociale, Della Loggia scrive «popolare», della sinistra ma anche dei cattolici, conseguenza di quelle profonde mutazioni della struttura socio-economica che hanno introdotto nuovi «spartiacque», non più improntati sul confronto tra interessi materiali contrapposti ma ormai caratterizzati soltanto da un contrasto valoriale su «temi immateriali ed etici», che designerebbero le nuove frontiere tra destra e sinistra. Una «conversione dall’economia all’etica» che segnala ormai i tempi radicalmente diversi dell’agenda politica e questo anche a seguito del mutamento di composizione sociale di una sinistra sempre più rapita da un «programmatico relativismo culturale» e da «fremiti d’anticlericalismo». In sostanza, il cattocomunismo è morto perché sarebbe venuta meno la sua base sociale, il lavoro industriale e il mondo contadino, sopravanzata da ceti medi e pubblico impiego, e perché è scomparso ogni riferimento a quell’etica antiborghese e antiliberale che riusciva a saldare attorno a modelli culturali tradizionalisti e valori antidiluviani Peppone e Don Camillo. A Galli Della Loggia questa deriva non piace affatto, non perché rimpianga – lui che è liberale – la lotta di classe, ma per il venire meno di alcuni fondamenti etici dell’Occidente, in difesa dei quali egli oggi non esita a schierarsi tra le fila dei teocon.
contrapponendoli a quelli del capitale. Il fatto che ormai – sostiene Della Loggia – nessuna delle contraddizioni moderne nasca più dalla lotta di classe avrebbe provocato il definitivo declino di questa cultura politica a vantaggio (o svantaggio, secondo i punti di vista) di una mutazione antropologica della sinistra, succube del dominio «edonistico-acquisitivo» (che tradotto potremmo definire: abbandono al piacere consumistico) di una società individualista, antistatalista, avvinta dall’egemonia aggressiva di un’etica soggettivista e libertina. Defunta sarebbe dunque l’anima sociale, Della Loggia scrive «popolare», della sinistra ma anche dei cattolici, conseguenza di quelle profonde mutazioni della struttura socio-economica che hanno introdotto nuovi «spartiacque», non più improntati sul confronto tra interessi materiali contrapposti ma ormai caratterizzati soltanto da un contrasto valoriale su «temi immateriali ed etici», che designerebbero le nuove frontiere tra destra e sinistra. Una «conversione dall’economia all’etica» che segnala ormai i tempi radicalmente diversi dell’agenda politica e questo anche a seguito del mutamento di composizione sociale di una sinistra sempre più rapita da un «programmatico relativismo culturale» e da «fremiti d’anticlericalismo». In sostanza, il cattocomunismo è morto perché sarebbe venuta meno la sua base sociale, il lavoro industriale e il mondo contadino, sopravanzata da ceti medi e pubblico impiego, e perché è scomparso ogni riferimento a quell’etica antiborghese e antiliberale che riusciva a saldare attorno a modelli culturali tradizionalisti e valori antidiluviani Peppone e Don Camillo. A Galli Della Loggia questa deriva non piace affatto, non perché rimpianga – lui che è liberale – la lotta di classe, ma per il venire meno di alcuni fondamenti etici dell’Occidente, in difesa dei quali egli oggi non esita a schierarsi tra le fila dei teocon.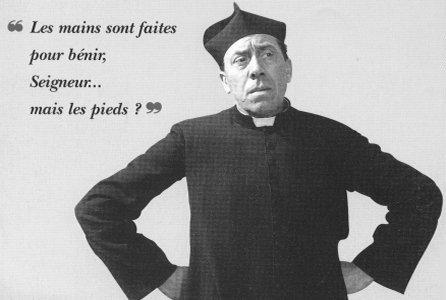 del cattocomunismo. Una scuola ideologica nella quale agivano due matrici culturali, una antiborghese e l’altra antiliberale, unite dal progetto di realizzare una saldatura dei ceti popolari divisi in origine dal credo religioso e dal ruolo politico conservatore tradizionalmente giocato dalla Chiesa-istituzione. Molto meno radicale della teologia della liberazione, il progetto cattocomunista mirava a saldare la tradizione solidarista della dottrina sociale della chiesa con aspetti del marxismo. In questa ottica la democrazia di massa organizzata nei due grandi partiti popolari, quello comunista e quello cattolico, altro non erano che la «democrazia che si organizza», secondo una famosa formula pronunciata da Togliatti. Un’ipotesi che si concepiva come uno stadio molto più avanzato della democrazia rispetto ai modelli costituzionali di scuola democratico-liberale sorretti dal principio del bilanciamento dei poteri o del governo limitato. Spiccava, in sostanza, una visione corporativa e iperstatalista della società e della politica, nella quale sarebbero prevalse richieste di rappresentanza degli interessi reali a discapito di quelli formali, e il principio del consenso sociale contro quello della maggioranza giuridica.
del cattocomunismo. Una scuola ideologica nella quale agivano due matrici culturali, una antiborghese e l’altra antiliberale, unite dal progetto di realizzare una saldatura dei ceti popolari divisi in origine dal credo religioso e dal ruolo politico conservatore tradizionalmente giocato dalla Chiesa-istituzione. Molto meno radicale della teologia della liberazione, il progetto cattocomunista mirava a saldare la tradizione solidarista della dottrina sociale della chiesa con aspetti del marxismo. In questa ottica la democrazia di massa organizzata nei due grandi partiti popolari, quello comunista e quello cattolico, altro non erano che la «democrazia che si organizza», secondo una famosa formula pronunciata da Togliatti. Un’ipotesi che si concepiva come uno stadio molto più avanzato della democrazia rispetto ai modelli costituzionali di scuola democratico-liberale sorretti dal principio del bilanciamento dei poteri o del governo limitato. Spiccava, in sostanza, una visione corporativa e iperstatalista della società e della politica, nella quale sarebbero prevalse richieste di rappresentanza degli interessi reali a discapito di quelli formali, e il principio del consenso sociale contro quello della maggioranza giuridica.