Postfazione a Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, di Angela Davis, Minimum Fax 2009
di Guido Caldiron e Paolo Persichetti
«L’aria era impregnata del fumo pungente del diesel e dell’odore di spazzatura marcia. La marmaglia dei prigionieri, più di metà neri o chicanos, era incolonnata per due, sei per catena, e ciascun gruppo riempiva un autobus: sembravano dei millepiedi umani. Dappertutto c’erano vicesceriffi in uniforme stirata alla perfezione. A ogni autobus erano stati assegnati tre vice, mentre gli altri stavano a guardare con le grosse 357 Magnum Python che penzolavano dalle mani. Alcuni poi accarezzavano dei fucili a canne mozze. Nonostante il puzzo, molti degli uomini respiravano a fondo, perché di aria fresca nella prigione senza finestre non ne entrava, e avevano già passato tre ore dentro celle di sicurezza di quattro metri per quattro, in gruppi di cinquanta ciascuna. Dietro di loro, gli affidabili della prigione stavano già spazzando le gabbie pronte per la seconda infornata del giorno».
Edward Bunker, Animal Factor

Nella storia di Angela Davis, come in quella di tanti altri afroamericani, il carcere occupa un posto centrale. Intorno al carcere ruota la sua vita di militante e di intellettuale. Del carcere e del suo «superamento» ci parla in questo libro. Anche se, ci spiega, «il carcere è considerato talmente “naturale” che è estremamente difficile immaginare che si possa farne a meno». Il dibattito e il confronto hanno però prodotto importanti modifiche al senso comune su temi altrettanto delicati. «Molti sono già giunti alla conclusione che la pena di morte è una forma antiquata di punizione che viola i principi basilari dei diritti umani», sottolinea Davis, prima di aggiungere: «Penso che sia venuto il momento di incoraggiare un dibattito analogo sul carcere».
Nelle due parti di cui si compone questo libro, il saggio di Angela Davis intitolato Il carcere è obsoleto? e l’intervista con Eduardo Mendieta, Per una democrazia dell’abolizione. Oltre l’impero, il carcere e la tortura, la dimensione del carcere è affrontata da un punto di vista storico, sociologico e politico. Si parla degli Stati Uniti, delle loro galere e della parte della popolazione americana che vi è reclusa, in maggioranza i membri delle «minoranze», neri e latinos. Si parla però anche di una «via carceraria alla questione sociale», del tentativo di chiudere in cella l’eccedenza costante di forza lavoro che cresce ogni giorno di più nell’economia del precariato e della disoccupazione. Si parla, infine, del carcere come strumento di controllo, insieme ad altri, di un mondo dominato e governato a partire da paura e insicurezza. Una storia americana che è sempre di più anche una storia mondiale: un elemento chiave di quella globalizzazione del populismo che si è candidata da tempo a governo dell’intero pianeta.
Per accompagnare le analisi di Angela Davis abbiamo scelto così di ricostruire la genesi, da quest’altra parte dell’Atlantico, di un fenomeno che trova nel carcere e nella trasformazione del significato stesso della Giustizia le sue maggiori caratteristiche. Un fenomeno che è stato riassunto nella formula di «populismo penale» e che ha conosciuto uno sviluppo costante nel nostro paese, e nell’intera Europa, nel corso degli ultimi decenni.
Per affrontare questo tema si deve prendere le mosse da una constatazione: al centro del dibattito e dell’azione politica si va imponendo negli ultimi anni il tema della «criminalità». Un vero e proprio strumento di «governo attraverso la paura», secondo la formula utilizzata dal sociologo dell’Università di Berkeley Jonathan Simon. Descrivendo in particolare il caso americano ne Il governo della paura, Simon ha spiegato che «le conseguenze dell’ascesa della questione criminale a uno status del genere sono state enormi: che si individui il valore della democrazia americana nelle sue caratteristiche di libertà o di uguaglianza, il governo attraverso la criminalità ha prodotto effetti negativi. In primo luogo, il massiccio dirottamento di risorse fiscali e amministrative verso il sistema di giustizia criminale – a livello statale e federale – ha configurato una trasformazione efficacemente descritta come transizione dallo “stato sociale” allo “stato penale”. Il risultato non è stato un governo più leggero, ma un esecutivo più autoritario, un potere legislativo più inerte e un sistema giudiziario più difensivo di quanto sia mai stato imputato allo stesso stato sociale».
Il quadro è allarmante: non riuscendo più a far vivere la speranza, le politiche di governo hanno fatto dell’angoscia una risorsa, nutrendo la psicologia sociale con gli impulsi più bui dell’animo umano. All’origine di questa terribile «innovazione» sembra esserci il consolidamento del sistema di produzione postfordista e del corrispondente modello politico neoliberale. Da una forma di capitalismo che cercava d’ottimizzare le sue prestazioni attraverso politiche che incrementavano l’impiego e utilizzavano la capacità d’acquisto dei salari per accrescere la domanda, si è passati a un modello che ha fatto – perlomeno fino all’attuale crisi economica internazionale – della precarizzazione della vita e della speculazione finanziaria la sua fondamentale fonte di profitto, ingenerando un nuovo tipo di società dominato dall’esclusione, dalla collocazione forzata nell’armata del precariato diffuso, dallo sfruttamento intensivo dei settori più marginali della forza lavoro. Siamo perciò di fronte a una società dove l’umanità è percepita come un’eccedenza sociale, economica e politica. Sovrannumeri di cui il potere intende liberarsi per alleggerire il ciclo produttivo, ripulire le città, rispedire nei luoghi di provenienza i migranti, fare piazza pulita di questuanti, posteggiatori e lavavetri, occupanti di case sfitte e writers, senza mancare d’escogitare stratagemmi istituzionali e sistemi elettorali che grazie al maggioritario rendono superflue ampie porzioni di voto popolare, riservando la scelta del governo a nuclei sempre più ridotti di cittadini influenti, espressione dei ceti forti. Il tutto declinato attraverso il linguaggio della messa al bando, della difesa della società e della neutralizzazione del male. Una società dove s’indeboliscono i legami sociali, viene meno ogni capacità inclusiva e prevale un dispositivo predatorio, una sorta di legge della giungla che conforma tutti i rapporti sociali ridisegnando una nuova dimensione ideologica a cui si è dato il nome di «populismo penale».
Una «cultura del controllo» risultato della costante tensione tra ideologia neoliberale del libero mercato e autoritarismo morale neoconservatore, dove il conflitto non trova più uno sbocco: privo di progettualità esprime solo rabbia, rivalsa, frustrazione, rancore. Una guerra dei forti contro i deboli, non solo dei primi contro gli ultimi ma dei penultimi contro chi viene subito dopo, di chi sta peggio col suo simile, come in una sorta di «vita mea mors tua», di sopraffazione permanente, di scontro molecolare. Dinamica che trova nelle città la sua massima applicazione, come suggerisce Loic Wacquant in Simbiosi mortale: «La metropoli punitiva riorganizzata – termine con il quale mi riferisco ai grandi centri urbani, etnicamente eterogenei e tipicamente segregati cui si è storicamente ancorato il defunto regime fordista-keynesiano, costituisce un luogo privilegiato per analizzare le connessioni esistenti fra il nuovo clima penale e il neoliberismo, e per due ragioni. La prima è che, allo stesso modo in cui le grandi città si sono caratterizzate quali avamposti dell’economia “globalizzata” nell’era post Bretton Woods, analogamente esse hanno giocato un ruolo chiave rispetto all’ideazione e al consolidamento delle nuove strategie penali: costituiscono infatti altrettanti nodi di produzione, definizione e diffusione della penalità neoliberale, vale a dire laboratori per lo sviluppo e la sperimentazione di discorsi e programmi orientati alla gestione preventiva e punitiva dell’ordine pubblico e della criminalità, esemplificati dalle pratiche di “tolleranza zero” e da un insieme di prassi tese a ripulire le strade dai rifiuti sociali». «La seconda ragione, invece», sottolinea ancora Wacquant «è che le città stesse attraversano un processo di ristrutturazione determinato proprio dalla deriva verso la regolazione punitiva dei poveri e l’emergere dello Stato penale. Il diffondersi progressivo degli attori, delle categorie e delle procedure tipiche di questo Stato accentua il processo di polarizzazione che separa una luminosa e accattivante downtown, spazio di consumo e di svago riservato ai residenti di classe medio-alta e ai turisti, e un arcipelago oscuro e temibile di no-go areas, percepito come brodo di coltura di una underclass i cui “comportamenti antisociali” minacciano il benessere fisico e morale del corpo urbano».
Il paradigma su cui si è costruito questo processo è quello della cosiddetta «Tolleranza zero», la teoria elaborata dai sociologi della nuova destra che è diventata uno degli argomenti centrali della Rivoluzione conservatrice degli ultimi decenni: lungo un percorso ideale, culturale e politico che va da Ronald Reagan a Silvio Berlusconi. All’origine di questa lettura della società – fatta propria anche da ampi settori delle post-sinistre, come indica la Terza via di Blair ma anche, più modestamente, la polemica anti-lavavetri del centro sinistra dell’ultimo governo Prodi – c’è un articolo pubblicato nel marzo del 1982 sull’Atlantic Monthly, una delle più prestigiose riviste conservatrici americane, con il titolo di «Broken Windows», letteralmente «vetri rotti», e firmato da George L. Kellin e James Q. Wilson. Un articolo che spiegava come il tollerare che i vetri di un immobile fossero rotti o restassero a lungo senza essere riparati rappresentava solo l’inizio di una catena di degrado: quell’edificio sarebbe diventato rapidamente una sorta di covo di criminali. «Se i vetri non sono riparati subito, i vandali si sentiranno autorizzati a romperne anche altri. Non solo, se l’edificio risulterà abbandonato, potranno entrarvi, accendere dei fuochi all’interno o magari pensare di occuparlo». Il punto decisivo per Kelling e Wilson era che non si consentisse di accumulare degrado o vandalismi, o per estensione piccoli reati contro le cose, senza un intervento deciso da parte delle autorità. Solo la prevenzione di quelli che nel mondo anglosassone sono definiti come «comportamenti antisociali», gli atti di vandalismo di varia natura, o i reati minori, può preservare un quartiere, una città o un’intera società dall’estendersi di veri e propri fenomeni criminali. I due autori, che avrebbero negli anni successivi alla pubblicazione di questo testo collaborato a lungo con diversi organismi di polizia, immaginavano un nuovo ruolo per le forze dell’ordine, orientato in primo luogo a rispondere alle paure dei cittadini.
La dottrina delle «finestre rotte» criticava esplicitamente la sociologia urbana formatasi negli Stati Uniti dopo le grandi rivolte dei ghetti afroamericani degli anni Sessanta che aveva messo l’accento sulla crisi sociale che gravava su una parte consistente delle città americane. Come evidenzia Alessandro De Giorgi in Zero Tolleranza, «secondo i criminologi della nuova destra il soggetto criminale è un individuo pienamente in grado di decidere se tenere o meno un comportamento deviante» e «nessun rilievo, rispetto alle strategie del controllo, deve essere attribuito alle condizioni sociali e al contesto nel quale il soggetto agisce». La linea del populismo penale è stata tracciata: «A questo cambiamento di prospettiva sul piano analitico», conclude infatti De Giorni, «corrisponde una svolta sul piano operativo e una complessa ridefinizione delle funzioni stesse della penalità: allo scopo riabilitativo sotteso alle politiche del trattamento si sostituisce l’obiettivo della deterrenza e dell’intimidazione».
In Europa, a «gestire» politicamente questo passaggio sono state in un primo momento le nuove destre che, nel loro emergere durante l’ultimo decennio, hanno fatto del tema della sicurezza la chiave del proprio successo. Come racconta Denis Salas ne La volonté de punir «il tema dell’insicurezza invade il discorso politico e si impone nei programmi elettorali. A un mondo aperto e incerto, questi partiti oppongono una società chiusa e ripiegata sul passato. Contro la globalizzazione di tutti i pericoli, fanno appello a una nazione mitizzata e trovano il loro pubblico tra gli scontenti e i dimenticati dei processi globali. La carta sociale e geografica situa chiaramente il loro elettorato: i quartieri delle grandi concentrazioni urbane dove agisce la piccola o media delinquenza». «È questa la Francia lepenista», spiega ancora Salas: «quella della decomposizione del mondo operaio e di una perdita d’identità che conduce alla xenofobia. Come non ricordarsi, da questo punto di vista, dell’invito lanciato da Jean Marie Le Pen alle “vittime dell’insicurezza, della povertà e della miseria” a “ritrovare la speranza” tra i due turni delle elezioni presidenziali del 2002». Quando il leader del Front National era risultato il più votato dopo il candidato gaullista Jacques Chirac, cancellando dal ballottaggio elettorale i rappresentanti delle sinistre e portando la minaccia xenofoba a un passo dalla conquista del potere.
In questo clima politico e dentro queste nuove contraddizioni sociali ha così messo radici un groviglio confuso di sentimenti che intrecciano la paura per l’avvenire e l’ossessione per il declino sociale, accentuando i processi d’identificazione vittimistica. L’insicurezza sociale e mentale, diffusa e multiforme, oltre a colpire direttamente le famiglie delle classi popolari, è dilagata sempre più nei ceti medi che i nuovi discorsi marziali dei politici e dei media sulla delinquenza convogliano ossessivamente sulla questione dell’insicurezza criminale.
«La paura in politica, come osservava Hobbes, ha due volti: uno guarda lontano, verso i nemici che la nazione deve fronteggiare; l’altro guarda in se stesso, verso i conflitti e le ineguaglianze che la nazione stessa produce. L’astuzia del potere politico sta nel convertire il primo di questi sguardi nel secondo, utilizzando la minaccia dei nemici all’esterno per reprimere i nemici all’interno», spiega Corey Robin, docente di Scienze politiche a New York, in Paura. La politica del dominio. «Logorata ed esausta a seguito di sempre inconcludenti test di adeguatezza», aggiunge in Amore liquido Zygmunt Barman, «spaventata a morte dalla misteriosa, inesplicabile precarietà delle sue fortune e dalle nebbie globali che nascondono ai suoi occhi qualunque prospettiva, la gente cerca disperatamente dei colpevoli per le proprie pene e tribolazioni. E come c’è da attendersi, li trova sotto il lampione più vicino, nell’unico posto premurosamente illuminato dalle forze della legge e dell’ordine: “Sono i criminali che ci rendono insicuri, e sono gli stranieri che generano criminalità”».
Una delle figure centrali di questa grande svolta punitiva approdata in Europa dagli Stati Uniti è diventata perciò l’icona della vittima presentata come «autentica incarnazione dell’individuo meritevole: quasi un modello ideale di cittadino». «Negli anni Ottanta», scrive ancora Jonathan Simon, «la vittima della criminalità è emersa dall’ombra del soggetto dei diritti civili per costituirsi come soggetto politico idealizzato in sé. In una sorta di estensione all’“uomo qualunque”, le rivendicazioni delle vittime di criminalità fecero propria la critica di complicità che gli attivisti dei diritti civili e le femministe avevano articolato a proposito del coinvolgimento dello Stato nella violenza criminale». E «una volta separata dal soggetto dei diritti civili, la vittima della criminalità può legarsi facilmente a un altro nucleo fondamentale di mobilitazione politica: il contribuente, vittimizzato dal governo, minacciato da un’avida classe politica di perdere i propri averi e persino la capacità di avere una casa propria». Siamo in ogni caso di fronte a «una trasformazione radicale della relazione tra le vittime e la società, una trasformazione così profonda che sembra poter modificare l’equilibrio di quest’ultima», scrivono Caroline Eliacheff e Daniel Soulez Larivière in Il tempo delle vittime.
Tuttavia l’investitura legittimante che viene offerta dall’acquisizione di questa posizione sociale è caratterizzata da un accesso fortemente limitato e diseguale: non tutte le “vittime” sono uguali, anzi, non tutte sono “vittime”. La postura dell’innocente è infatti riconosciuta sulla base di ben selezionati requisiti di ordine sociale, economico, culturale e etnico che variano secondo le latitudini. Ma, in ogni caso, può un eventuale sentimento d’ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile soltanto per il mezzo di una condanna penale? Come sottolinea Antoine Garapon in Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, «le vittime non si aspettano dalla Giustizia soltanto di essere “risarcite” del danno subito, ma anche e soprattutto di essere riconosciute». Ma «questa attesa», si chiede ancora il giurista, «non rischia di snaturare il processo, di cui non è certo l’obiettivo? Una tale domanda di riconoscimento rischia di introdurre una confusione tra il privato e il pubblico […], tra la violazione pubblica e la sofferenza personale, tra la reciprocità della cittadinanza e la compassione religiosa». Non solo: negli Stati Uniti la concessione dello status di vittima non suscita alcuna controversia e produce tutti i suoi effetti positivi solo nel caso in cui portatori della rivendicazione siano individui bianchi appartenenti al ceto medio. Allo stesso modo in Europa i criteri si basano sull’appartenenza comunitaria, la religione e l’identità politica. Il rumeno, il musulmano, il rom non hanno chance. Per i gruppi stigmatizzati in partenza, nei confronti dei quali si presume una contiguità originaria con l’universo criminale o la genealogia del male, non vi è alcuna possibilità di accedere al ruolo di vittima. Anche perché, come ribadito con precisione da Alessandro Dal Lago in Non persone, «qualunque sia l’essere dell’uomo, la sua esistenza è connotata dalla posizione all’interno (o all’esterno) di un ordinamento concreto. Le implicazioni della natura giuridico-positiva (e quindi, in ultima analisi, politica) della “persona” sono abbastanza evidenti. Se è vero che una delle conquiste degli ordinamenti politici moderni è il conferimento di “diritti” solo a chi rientra a pieno titolo in tali ordinamenti, chi ne è escluso (o chi non vi è incluso) non habet personam, e quindi è uomo solo in senso naturale, non sociale. La cittadinanza (l’insieme di diritti di chi è legittimamente incluso in un ordinamento) è quindi condizione esclusiva della personalità sociale, e non viceversa, come recitano sia il senso comune filosofico sia quelle dichiarazioni o convenzioni internazionali che affermano o riaffermano i “diritti universali dell’uomo o della persona”».
In effetti, più della vittima in sé è la nozione di “vittima meritevole” che trova affermazione e legittimazione. Non basta aver subito un torto o un danno per poter essere riconosciuti come tali, occorre innanzitutto entrare a far parte della categoria legittimata a esserlo. L’uso strumentale della figura della vittima è uno degli aspetti centrali di questa nuova ideologia punitiva che ha innescato un processo regressivo di privatizzazione della giustizia. Il diritto della vittima alla riparazione simbolica è lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato soltanto in base alla natura e all’entità della pena da infliggere e al riconoscimento di una capacità d’interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Ogni retorica riabilitativa è scomparsa dietro una pura logica di rappresaglia che i poteri pubblici delegano alla vendetta privata, costruita sulla spersonalizzazione e la disumanizzazione assoluta di chi viene immesso nel recinto dei colpevoli.
Questo processo di privatizzazione del diritto di punire trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una funzione terapeutica, favorendo la riparazione psicologica della vittima. A questa svolta culturale sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam, poi estesa alle molteplici forme di traumatismo civile, sociale, politico e naturale. Un’interpretazione che non ha mancato di sollevare obiezioni, perché sancisce una connaturata fragilità dell’individuo moderno, ormai ritenuto incapace di reggere i conflitti. In questo modo l’esaltazione narcisistica della sofferenza diventa infatti una risorsa che le parti in lotta introducono nella dimensione simbolica del conflitto, percependosi l’una come vittima dell’altra. Una competizione della sofferenza che mina ogni possibile terreno di soluzione, ogni pausa o riconciliazione civile. Alla fine la vittima genera solo altre vittime, ricordava infatti Hannah Arendt.
Quest’ideologia presenta tuttavia sfaccettature diverse tra la realtà nordamericana e quella europea. Differenze legate alla presenza di diversi modelli sociali, istituzionali e giudiziari. Il tema della complicità fra il crimine e lo Stato, tacciato per questo d’elitismo e corruzione, appartiene, per esempio, al repertorio classico della critica neoconservatice e dei libertarians americani (i fautori dello Stato minimo) nei confronti di quello che viene ritenuto un eccessivo presenzialismo statale (da questi definito big government) nelle questioni di società. Al contrario, da noi, chi mette l’accento sulla centralità della lotta alla mafia, denuncia il lassismo del governo nella lotta alla criminalità auspicando un sempre maggiore coinvolgimento dello Stato.
Il sistema giudiziario di tipo accusatorio fa sì che nel modello nordamericano si configuri una contrapposizione politico-ideologica tra gli incarichi elettivi e quelli indipendenti che reggono il sistema della giustizia penale, definito da Jonathan Simon il «complesso accusatorio». Lo sceriffo della contea insieme all’attorney locale (il procuratore) sono ritenuti i protagonisti della guerra senza quartiere al crimine. Mentre il giudice terzo, in quanto garante delle forme della legge, è percepito come un ostacolo se non addirittura una figura connivente con la delinquenza. La tradizione inquisitoria che caratterizza ancora il sistema giudiziario italiano, via di mezzo tra rito istruttorio e «semiaccusatorio», consente invece alla nostra magistratura di essere individuata come il perno centrale della lotta non solo alla criminalità ma più in generale all’ingiustizia. L’impegno profuso nel contrastare la sovversione sociale degli anni Settanta, la lunga stagione delle leggi penali speciali e dei maxiprocessi che ha traversato il decennio degli Ottanta, e poi la stagione di Tangentopoli hanno conferito alla magistratura, e in particolare ad alcune importanti procure, il ruolo di vero e proprio soggetto, portatore di un disegno generale di società. I giudici sono così diventati i protagonisti di quella che è stata presentata come «la rivoluzione italiana» dei primi anni Novanta, di cui Marco Revelli ha offerto in Le due destre una delle migliori sintesi. «Quello che sembra d’intravedere tra le brume dei primi anni Novanta», scrive il sociologo torinese, «sotto la superficie increspata delle inchieste giudiziarie, dietro la rappresentazione televisiva degli imputati eccellenti e degli arresti a catena, è la dissoluzione di tutti e tre i patti non scritti che avevano, in qualche modo, presieduto alla sopravvivenza della Prima Repubblica, ben oltre la sua effettiva durata in forma costituzionale. In primo luogo il residuo patto sociale tra capitale e lavoro […], in secondo luogo il patto che potremmo definire finanziario tra Stato-apparato e contribuenti o, se si preferisce, tra finanza pubblica e risparmio». E, infine, il «terzo patto che aveva retto il prolungamento, post mortem, della Prima Repubblica: il patto politico stabilito tra cittadini e classe eletta di governo nella confusa metamorfosi della società civile e della società politica a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Patto di delega e mediazione, in base al quale veniva in qualche modo scambiato consenso contro consumo». «È in questo clima», conclude Revelli, «che i “mediatori” vengono trasformati in “criminali” in struttura deviante. E che il prezzo della mediazione, vissuto prima come necessità funzionale, viene d’un colpo percepito socialmente (e giudiziariamente) come “furto”».
Tornando all’ideologia vittimaria, va rilevato come nel nostro paese non abbia ancora assunto una sua fisionomia codificata e stabile. In un’epoca in cui i fenomeni sociali prendono una conformazione «liquida», anche il vittimismo diventa non solo pervasivo ma proteiforme, mutevole: e così nelle lande del Settentrione leghista fanno breccia gli argomenti tipici della destra statunitense sul contribuente vittimizzato dalle tasse governative, sul costo eccessivo di un welfare per i poveri e le minoranze urbane, cioè le stesse comunità accusate di generare criminalità, che nella retorica leghista diventano i migranti e le regioni meridionali. Così il sociologo Aldo Bonomi ha scelto «il risentimento e il rancore» quale cifra delle trasformazioni più profonde che attraversano questa parte del nostro paese. Ne Il rancore, il suo libro-viaggio nel «malessere del nord», Bonomi indaga ad esempio le ragioni del risentimento delle regioni settentrionali dell’Italia verso il complesso del mondo politico, accusato di essere troppo lento nel risolvere i problemi posti dallo sviluppo produttivo, ma anche di non capire i bisogni dei nuovi ceti emersi dalla rivoluzione economica dell’ultimo ventennio, su tutti il cosiddetto «popolo delle partite Iva». «Sono cambiate le forme di produzione, la composizione sociale, i modi per rappresentare interessi, passioni e forme di convivenza, i quali hanno come primo luogo di condensa il territorio», spiega Bonomi «Qui i problemi grandi, quelli della modernizzazione per stare nello spazio globale, e quelli piccoli, delle forme di convivenza di una società che cambia, sono più visibili e diretti».
Nonostante sia evidente la matrice ultrareazionaria e il carattere ferocemente conservatore dei suoi esiti politici, al dilagare del populismo penale, almeno in Italia, non è estranea la cultura di una parte della sinistra. La democrazia coniugata nella sua forma giudiziaria ha così favorito e accelerato la svolta a destra della società italiana. «La lunga sequenza delle “emergenze” sponsorizzate in prima persona dal Pci –», scrive Salvatore Palidda, «il terrorismo, la mafia, tangentopoli, ecc. – ha prodotto un’attitudine istituzionale alla messa in mora dei diritti fondamentali. Di più: ha delegittimato la vigenza effettiva del dettato costituzionale (“nato dalla Resistenza”) in nome della sua difesa verbale. Al termine di questa lunga stagione emergenziale resta soltanto il potere pratico della legittimazione manipolante di qualsiasi politica venga decisa dal “centro” dello stato. Che nel frattempo, avendo visto scomparire e delegittimare – con Tangentopoli – la politica e – col procedere dell’integrazione europea – la sovranità monetaria e diplomatica, si è ridotto alla pura funzione esecutiva: magistratura e polizia».
Le conseguenze di queste politiche sulla situazione delle carceri italiane sono poi sotto gli occhi di tutti. «Se nel 1990 nelle nostre prigioni c’erano 25.931 detenuti, nel ’91 se ne contavano già 35.469, che divennero 47.316 nel ’92, fino a stabilizzarsi intorno alle 50mila presenze giornaliere negli anni successivi», indicava già nel 2002 in Massima sicurezza l’operatore carcerario Salvatore Verde, aggiungendo: «L’indice di carcerazione nel nostro paese passa bruscamente dalle 45 alle 89 persone ogni 100mila abitanti […]. Ancor più evidente è questo sconvolgimento se guardiamo ai flussi di ingresso nelle prigioni. Se nel ’90 entrarono 57.735 persone, nel 1994 gli incarcerati superarono le 100mila unità». Ma non sono solo i numeri a indicare la differenza rispetto al passato. Se all’epoca dell’ingresso in carcere di Giulio Salierno, entrato in cella come militante neofascista condannato per omicidio e uscito come sociologo marxista tra i più attenti alla realtà dell’emarginazione e del controllo sociale – come ha raccontato nella sua Autobiografia di un picchiatore fascista – nell’Italia della fine degli anni Cinquanta i detenuti provenivano prevalentemente dal «proletariato bracciantile, adulto e meridionale», non è così nell’ultimo decennio. Come spiega Salvatore Verde: «La composizione sociale del nuovo popolo delle carceri si presenta radicalmente mutata rispetto ai soggetti che avevano agitato la scena carceraria negli anni Settanta e Ottanta. In carcere affluisce un variegato panorama di figure sociali (caratteristiche del) sottoproletariato giovanile metropolitano. Il tossicodipendente e l’immigrato diventano le principali figure bersaglio. Sono questi i soggetti che sconvolgono le statistiche penitenziarie di questi anni e che pagheranno i costi più pesanti della deriva criminalizzatrice delle politiche del controllo sociale».
BIBLIOGRAFIA
Zygmunt Bauman, Amore liquido, Laterza, 2004
Aldo Bonomi, Il rancore, Feltrinelli, 2008
Robin Corey, Paura. La politica del dominio, Università Bocconi, 2005
Alessandro Dal Lago, Non persone, Feltrinelli, 1999
Antoine Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner, Odile Jacob, 2002
Marco Revelli, Le due destre, Bollati Boringhieri, 1996
Denis Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette, 2008
Giulio Salierno, Autobiografia di un picchiatore fascista, minimum fax, 2008
Jonathan Simon, Il governo della paura, Raffaello Cortina Editore, 2008
Salvatore Verde, Massima sicurezza, Odradek, 2002
Loic Wacquant, Simbiosi mortale, Ombre Corte, 2002
Caroline Eliacheff e Daniel Soulez Larivière, Il tempo delle vittime, Salani, 2008
 Lo Scop infatti, oltre a sedare le proteste ha avuto la funzione, poi ereditata dal Gom, di acquisire informazioni.
Lo Scop infatti, oltre a sedare le proteste ha avuto la funzione, poi ereditata dal Gom, di acquisire informazioni.

 accolta nell’indifferenza generale, appena poche righe nella cronaca locale. Loyos era quello che i giornali hanno etichettato come il “biondino”. Spersonalizzato e mostrificato insieme a Karl Racs, anche lui subito soprannominato “faccia da pugile”. I due, secondo la questura e la procura, avevano aggredito una coppia di fidanzatini minorenni nel parco della Caffarella, stuprando brutalmente la fanciulla. In realtà i responsabili di quello scempio erano altri, a loro volta cittadini romeni che nei giorni precedenti avevano commesso diverse aggressioni contro coppiette nella stessa zona, seminando una quantità incredibile d’indizi. Un’indagine più accorta avrebbe trovato subito quelle tracce e scoperto agevolmente i veri colpevoli. Invece le cose sono andate diversamente. La politica ha interferito pesantemente nell’inchiesta. Un ennesimo decreto sicurezza è stato varato dopo una violenta campagna allarmistica. Servivano subito due colpevoli. Loyos e Racs erano stati fotosegnalati dalla polizia dopo un altro stupro, avvenuto il 21 gennaio precedente, in un luogo poco distante dal loro accampamento di fortuna. Insomma erano i capri espiatori perfetti. L’adolescente aggredita non mise molto a indicare il viso del biondino. Seguendo una classica tecnica a imbuto gli erano state mostrate un numero limitato di foto. Nonostante ciò aveva designato un’altra persona. Solo in seconda battuta “riconosce” Loyos. La polizia lo trova subito. Erano le 18 circa del 17 febbraio. 8 ore dopo (alle 2 di notte) confessa davanti al pm: «L’abbiamo violentata per sfregio…». Chiama in causa anche l’amico Racs. Pochi giorni dopo ritratta, spiegando di aver subito violente percosse. Nessuno lo ascolta. In questura sono occupati a smaltire la sbornia della conferenza stampa trionfale dei giorni precedenti. I giornali dipingono agiografici ritratti. Il questore non sta nella pelle: «Un lavoro di pura investigazione, d’intuito e senza l’aiuto di supporti tecnici. Da veri poliziotti». Gli fa eco il capo della Mobile Vittorio Rizzi: «Finalmente non sarò più il nipote di Vincenzo Parisi» (capo della polizia dal 1987 al 1994).
accolta nell’indifferenza generale, appena poche righe nella cronaca locale. Loyos era quello che i giornali hanno etichettato come il “biondino”. Spersonalizzato e mostrificato insieme a Karl Racs, anche lui subito soprannominato “faccia da pugile”. I due, secondo la questura e la procura, avevano aggredito una coppia di fidanzatini minorenni nel parco della Caffarella, stuprando brutalmente la fanciulla. In realtà i responsabili di quello scempio erano altri, a loro volta cittadini romeni che nei giorni precedenti avevano commesso diverse aggressioni contro coppiette nella stessa zona, seminando una quantità incredibile d’indizi. Un’indagine più accorta avrebbe trovato subito quelle tracce e scoperto agevolmente i veri colpevoli. Invece le cose sono andate diversamente. La politica ha interferito pesantemente nell’inchiesta. Un ennesimo decreto sicurezza è stato varato dopo una violenta campagna allarmistica. Servivano subito due colpevoli. Loyos e Racs erano stati fotosegnalati dalla polizia dopo un altro stupro, avvenuto il 21 gennaio precedente, in un luogo poco distante dal loro accampamento di fortuna. Insomma erano i capri espiatori perfetti. L’adolescente aggredita non mise molto a indicare il viso del biondino. Seguendo una classica tecnica a imbuto gli erano state mostrate un numero limitato di foto. Nonostante ciò aveva designato un’altra persona. Solo in seconda battuta “riconosce” Loyos. La polizia lo trova subito. Erano le 18 circa del 17 febbraio. 8 ore dopo (alle 2 di notte) confessa davanti al pm: «L’abbiamo violentata per sfregio…». Chiama in causa anche l’amico Racs. Pochi giorni dopo ritratta, spiegando di aver subito violente percosse. Nessuno lo ascolta. In questura sono occupati a smaltire la sbornia della conferenza stampa trionfale dei giorni precedenti. I giornali dipingono agiografici ritratti. Il questore non sta nella pelle: «Un lavoro di pura investigazione, d’intuito e senza l’aiuto di supporti tecnici. Da veri poliziotti». Gli fa eco il capo della Mobile Vittorio Rizzi: «Finalmente non sarò più il nipote di Vincenzo Parisi» (capo della polizia dal 1987 al 1994).
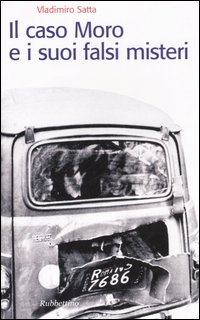 capovolgimento di fronte che stravolge l’esito fin troppo scontato attribuito alle cose. In questo caso vittima del destino cinico e baro è Giovanni Fasanella, autore del libro-intervista realizzato con Alberto Franceschini,
capovolgimento di fronte che stravolge l’esito fin troppo scontato attribuito alle cose. In questo caso vittima del destino cinico e baro è Giovanni Fasanella, autore del libro-intervista realizzato con Alberto Franceschini, polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura.
polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura. Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).
Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).