Libri – L’Amnistia Togliatti, Mimmo Franzinelli, Mondadori, Milano 2006, pp. 392, € 19
Paolo Persichetti
Liberazione Giovedì 27 aprile 2006
L’ultimo lavoro di Mimmo Franzinelli, L’Amnistia Togliatti, un saggio che ricostruisce la storia del decreto presidenziale di clemenza predisposto dal guardasigilli Palmiro Togliatti, sembra dover riaccendere a distanza di sessant’anni le stesse  polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura.
polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura.
Non è così! Risponde Luzzato, «l’amnistia Togliatti fu una vergogna nazionale» perché nacque dal duplice intento di reclutare nuovi militanti tra le fila dei vinti e risparmiare conseguenze giudiziarie alle azioni delle forze partigiane. Non fu sempre Togliatti a definire «eccesso di nervosismo» la rabbia dei parenti delle vittime? Per questo, conclude: «il libro di Franzinelli va consigliato come la più istruttiva delle letture possibili per chi voglia sottrarsi a un discorso sull’amnistia che strizza l’occhio all’amnesia». Già, perché a ben vedere il vero obiettivo polemico non è tanto la clemenza del 1946, ma quella in discussione da un quindicennio sugli anni 70. Un provvedimento che se approvato, sostiene Luzzato, si trasformerebbe in una «pietra tombale sugli orrori condivisi della nostra guerra civile». L’intonazione polemica del recensore del Corriere, che da qualche tempo è esulcerato dalle incursioni storiche di alcuni giornalisti sugli anni della guerra civile e i primordi della Repubblica (si veda in proposito La crisi dell’antifascismo, Einaudi 2004), è tale che sembra non voler risparmiare nemmeno l’istituto stesso dell’amnistia, rappresentata come un evento immorale, un diniego di giustizia, una fuga dalle responsabilità, un misconoscimento della verità.
Due secoli di amnistie
Senza voler chiamare in causa l’antichità classica, ci basta sapere che l’Ottocento e il Novecento sono stati secoli di amnistie che hanno seguito, in modo spesso contraddittorio e parziale, rivolgimenti e traumatismi civili e politici. L’Italia post-unitaria è stata marcata dall’adozione ripetuta di misure di clemenza collettiva. Almeno 230 sono state quelle censite tra il 1861 e il 1943. Ben altre 6 amnistie politiche sono state varate fino al 1970. Da allora più nulla.
C’è chi ha proposto, come Stéphane Gacon (L’Amnistie, Seuil 2002), una classificazione dei suoi diversi modelli. Uno di questi sarebbe l’amnistia-perdono, caratteristica dei regimi autoritari, che spesso si presenta come un ambiguo atto di generosità, un gesto di forza vischiosa e paternalista, il più delle volte accompagnato dalla «umiliazione di una richiesta», lì dove il perdono ricambia la sottomissione. Provvedimenti che in genere presuppongono valutazioni soggettive del beneficiario e dispositivi premiali in cambio di una richiesta d’acquiescenza al potere. Si tratta di un perdono inquisitorio, una logica che ricorda molto da vicino i dispositivi premiali intrapresi in Italia, tra il 1979 e il 1987, come le ampie riduzioni di pena previste per i dissociati della lotta armata.
L’amnistia-rifondazione, invece, non chiede nulla in cambio ma interviene per riunificare un paese diviso, ricompattandone il corpo politico, come accadde, con le leggi aministiali del 1872 e del 1898, alla fine della guerra civile americana, o con l’amnistia della Comune di Parigi che gettò le basi della terza Repubblica francese.
C’è poi l’amnistia-riconciliazione, un modello che segue la fine dei periodi dittatoriali. Sembra essere il caso dell’Italia dell’immediato dopo guerra, della Francia dopo la fine della Repubblica collaborazionista di Vichy o della Spagna post-franchista. Questi provvedimenti, nella gran parte dei casi, sono ispirati da valutazioni d’opportunità, ragioni di forza maggiore motivate dal fatto che i regimi caduti hanno potuto contare su un vasto consenso sociale costruito negli anni del loro dominio. Circostanza che rende problematica un’epurazione politica troppo estesa.
L’amnistia del 1946
Nel caso dell’amnistia italiana del 1946, vi è poi un’ambivalenza tutta particolare: per un verso, essa corrisponde all’avvio della politica d’egemonia condotta dal Pci, che mira così a recuperare larghi settori di quel fascismo antiborghese, frondista e di sinistra, in coerenza con quella che era stata la sua analisi del fascismo, riassunta nella formula del «regime reazionario di massa». Una convinzione che aveva spinto il Partito comunista clandestino al velleitario appello verso i «fratelli in camicia nera» nel tentativo di arrivare ad infiltrare le corporazioni e le organizzazioni di massa della dittatura negli anni della sua massima popolarità. Nella relazione con la quale Togliatti accompagna l’amnistia del 46, si spiega che la nuova Italia repubblicana non può nascere incoraggiando «la tradizione medioevale della messa al bando», per questa ragione era necessario un atto di clemenza che mirasse a recuperare quelli che erano stati «travolti da passione politica, o ingannati da propaganda menzognera… giovani resi incapaci da venti anni di dittatura di distinguere il bene dal male».  Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).
Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).
Il fallimento dell’amnistia Togliatti trova spiegazione, in realtà, nel mancato adeguamento statuale al mutamento di regime politico. Venne meno sul terreno giuridico-formale, come spiegò con esemplare lucidità Calamadrei: «lo stabile riconoscimento della nuova legalità» uscita dalla Resistenza. Quella discontinuità che rende «lecita» l’illegalità perché «vittoriosa» sull’assetto politico preesistente. Richiamandosi a Santi Romano, Calamandrei sosteneva che l’assenza di rottura giuridica impedì di trovare nello Stato nuovo, e non nelle leggi precedenti, la necessaria legittimità. Il risultato fu la sistematica depoliticizzazione delle azioni partigiane (come avvenuto anche nel corso degli anni 70-80), passate al vaglio del codice Rocco, concepito proprio per reprimere quel tipo d’inimicizia politica. Furono necessarie ancora tre amplissime amnistie nel 53, 56 e 66, per chiudere definitivamente il dopoguerra.
I mal di pancia di Luzzato: miseria della cultura postazionista
La tesi di Luzzato testimonia il singolare atteggiamento della cultura liberale che oscilla continuamente tra la denuncia del carattere «totalitario, terroristico e fazioso», dei comunisti, per cui da una parte sarebbe stato un crimine l’uccisione di Gentile, ma poi si rimprovera loro l’amnistia ai fascisti; per un verso si condannano le vendette del «triangolo rosso», ma poi si critica la politica di recupero dei giovani quadri frondisti del regime, recentemente ricordata dal libro di Mirella Serri (I Redenti. Gli intellettuali che vissero due volte. 1938-1948, Corbaccio, 2005). Di contro, a sinistra, ancora più meschino è il comportamento dei salvati di allora che, forse per far dimenticare di essere cresciuti negli asili dell’infamia, non hanno mai esitato a condannare i sommersi di oggi, opponendosi con ferocia perseveranza all’amnistia per gli anni 70.
L’amnistia Toglliatti appartiene a quel genere di clemenza che, intervenendo politicamente nell’immediatezza dei fatti, scommette sul futuro mettendo fine al rischio di un ciclo interminabile di rese dei conti. Per questo agisce come un «colpo di spugna», una sorta di oblio preventivo sulle colpe. Ma non è responsabilità di quell’amnistia, il clima più generale di rimozione e occultamento che investì, invece, le stragi più efferate dei nazi-fascisti, che di fatto si avvantaggiarono di una illegale amnistia di fatto, voluta dal potere politico in ragione dell’adesione italiana al Patto atlantico, come l’armadio della vergogna scoperto a Palazzo Cesi ha dimostrato. È inaccettabile, dunque, l’attacco all’istituto dell’amnistia e quella sorta di perverso bilanciamento della storia che Luzzato suggerisce: fare degli anni 70 il capro espiatorio del Novecento italiano per risarcire simbolicamente la mancata giustizia del dopoguerra. A differenza della clemenza preventiva del 46, l’amnistia per gli anni 70 interverrebbe in una situazione in cui la verità giudiziaria è stata già scritta e le pene ampiamente consumate, a distanza di oltre 30 anni dall’inizio del fenomeno e ben 18 anni dalla sua fine, quando in carcere vi sono ancora 132 detenuti per reati di sovversione e ben 119 latitanti all’estero (fonte Ministero della Giustizia aggiornata all’ottobre 2004), rinchiusi da un massimo di 28 anni ad un minimo di 18. Quale che sia il giudizio su quell’epoca, un dato ormai è certo: i militanti degli anni 70 hanno largamente scontato le loro pene, compreso il sovrasanzionamento dovuto alle leggi speciali dell’emergenza. Sono stati gli unici a pagare nella storia repubblicana. Si tratta ormai di chiudere simbolicamente un’epoca terminata da lunghi anni, e che alcuni settori della magistratura, degli apparati e del mondo politico, vorrebbero tenere artificiosamente ancora aperta per utilizzarla come una minaccia che ipotechi ogni presente e futuro di critica contro il potere.
Post scriptum
Quel che non è accettabile nella recensione di Luzzato è l’utilizzo della polemica contro l’amnistia Togliatti per attaccare, in realtà, l’ipotesi che un provvedimento del genere possa essere varato per il conflitto degli anni 70. Luzzato sembra quasi voler suggerire una sorta di perverso contrappasso: poiché ci fu clemenza contro i crimini fascisti è bene che ora i militanti della lotta armata degli anni 70 risarciscano simbolicamente anche quella mancata giustizia. Esiste una differenza sostanziale: nel giro di pochissimi anni (il maresciallo Graziani fu scarcerato nel 1953, accolto a braccia aperte da Andreotti), i fascisti furono tutti scarcerati. L’amnistia e l’indulto erano congeniati in modo tale che anche coloro che avevano subito condanne molto alte potessero uscire in libertà condizionale dopo 5 anni. Si trattò sostanzialmente di un’amnistia quasi preventiva. Mentre per i militanti della lotta armata dopo oltre 30 anni non si parla nemmeno più della opportunità di un provvedimento. L’amnistia la sta facendo il tempo.
Negli anni 90, uno degli argomenti in favore dell’indulto era quello di riportare l’entità delle pene ad una misura normale, togliendo il sovrasanzionamento dell’emergenza. Oggi, paradossalmente, non avrebbe più senso poiché la sanzione è stata largamente consumata.
La stessa cosa accadde in Francia. Non è vero in proposito quel che dice Luzzato. Anche se l’amnistia francese arrivò nel 1953, essa non fu esente dalle stesse polemiche che denunciavano una epurazione troppo lieve. Basti pensare alla vicenda Papon e Touvier! Per altro quel po’ di epurazione che avvenne Oltralpe fu essenzialmente un regolamento di conti a destra, tra gaulliani e petenisti.
Link
Politici e amnistia, tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’unità d’Italia ad oggi
Storia della dottrina Mitterrand
Dalla dottrina Mitterrand alla dottrina Pisanu
Una storia politica dell’amnistia
Amnistia per i militanti degli anni 70
La fine dell’asilo politico
Vendetta giudiziaria o soluzione politica?
Il caso italiano: lo stato di eccezione giudiziario
Giorgio Agamben, Europe des libertes ou Europe des polices?
Francesco Cossiga, “Eravate dei nemici politici, non dei criminali”
Francesco Cossiga, “Vous étiez des ennemis politiques pas des criminels”
Tolleranza zero, il nuovo spazio giudiziario europeo
Il Nemico inconfessabile, sovversione e lotta armata nell’Italia degli anni 70
Il nemico inconfessabile, anni 70
Universita della Sapienza, salta il seminario suggerito dalla digos
Università della Sapienza,il seminario sugli anni 70 della Pantera
Quella ferita aperta degli anni 70

 trovare un medico che ti facesse la ricetta. Eccetera eccetera eccetera. Dieci anni dopo, quando iniziarono gli anni 80, tutte le cose che vi abbiamo detto erano state cancellate. E in più era stato conquistato un forte tasso di uguaglianza salariale, la “scala mobile” aveva livellato gli stipendi e ridotto i profitti e le rendite, una legge dello Stato costringeva i proprietari di casa ad affittare a prezzi molto bassi, il potere degli operai nelle fabbriche era diventato notevole, eccetera eccetera. Dall’inizio degli anni 80 iniziò la riscossa dei potenti, che negli anni 70 avevano subito molti smacchi. Iniziò la restaurazione. Che comunque non riuscì – non è ancora riuscita – a cancellare quel decennio. Cosa sarebbe oggi l’Italia se, per magia nera, qualcuno potesse cancellare gli anni 70? Sarebbe come nell’800.
trovare un medico che ti facesse la ricetta. Eccetera eccetera eccetera. Dieci anni dopo, quando iniziarono gli anni 80, tutte le cose che vi abbiamo detto erano state cancellate. E in più era stato conquistato un forte tasso di uguaglianza salariale, la “scala mobile” aveva livellato gli stipendi e ridotto i profitti e le rendite, una legge dello Stato costringeva i proprietari di casa ad affittare a prezzi molto bassi, il potere degli operai nelle fabbriche era diventato notevole, eccetera eccetera. Dall’inizio degli anni 80 iniziò la riscossa dei potenti, che negli anni 70 avevano subito molti smacchi. Iniziò la restaurazione. Che comunque non riuscì – non è ancora riuscita – a cancellare quel decennio. Cosa sarebbe oggi l’Italia se, per magia nera, qualcuno potesse cancellare gli anni 70? Sarebbe come nell’800.
 condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.
condotta con implacabile serenità, anche a costo di rinunciare ai benefici di una legislazione che premiava i detenuti a condizione che esprimessero atti di contrizione, esibizioni pubbliche di pentimento, richieste spettacolari di perdono. La giustizia italiana non concesse i benefici e neppure l´affettività, perché l´umanità del trattamento carcerario prescritta dalla Costituzione si accontenta di considerare i detenuti ancor meno di animali rinchiusi in uno zoo. Vincenzo e Nadia continuarono a rivendicare la loro dignità di persone senza pretese e rifiutarono persino di tentare la via della spettacolarizzazione massmediatica del loro caso. Scelsero la via del silenzio che reputarono la forma di mediazione più consona alla tragedia della quale erano stati corresponsabili.

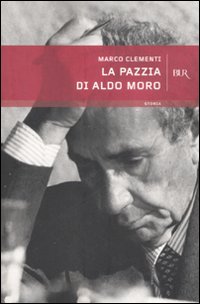 Il lavoro dello storico si basa sulla ricerca, la lettura, l’interpretazione e la scelta dei documenti, delle fonti primarie, senza le quali non può essere ricostruito alcun avvenimento. In un saggio così preparato, quindi, non si troveranno, se non raramente, espressioni ipotetiche, supposizioni, allusioni; il testo sarà quasi sempre all’indicativo, perché le fonti consultate permettono a chi scrive di avere una chiara visione di quanto va a raccontare. Il ragionamento segue il metodo induttivo. Ovviamente, ciò non significa che ogni libro di storia sia un capolavoro. Come in tutti i settori, esistono anche gli storici mediocri, ma questo è un altro discorso. A differenza dello storico, il lavoro dietrologico normalmente non si preoccupa troppo del riscontro documentale: parte da ipotesi, opera per deduzione e nella narrazione usa spesso il modo condizionale. Anche quando si serve di documenti, solitamente è difficile avere dei riscontri, perché si tratta spesso di documenti poco chiari, incompleti, di dubbia provenienza. La conseguenza principale di tutto ciò è che, mentre il saggio di uno storico produce una “verità storica” finita, che potrà essere smentita o rafforzata alla luce di nuovi documenti, il saggio dietrologico moltiplica le domande di partenza, senza fornire mai una risposta, rimandata regolarmente a un futuro più o meno lontano, quando il “mistero” risultasse finalmente svelato. Il saggio di uno storico, dunque, anche quando è dedicato ad un complotto (per esempio l’assassinio di Kennedy), cerca certezze ed eventualmente rimanda il lettore alla declassificazione dei fondi archivistici per le risposte in sospeso. Quello dietrologico aggiunge nuovi misteri, non svela mai nulla, né è in grado di rimandare il lettore a un futuro certo, perché non sono i fondi d’archivio ad interessarlo. La dietrologia, infatti, non cerca le responsabilità, politiche, amministrative, morali ecc., di un avvenimento, ma il colpevole (o i colpevoli), che fino a quel momento hanno impedito al bravo ricercatore di giungere alla verità (di quale verità si parli, inoltre, resta sempre poco chiaro. La verità storica, per fare un esempio, non è la Verità, ma corrisponde a quanto è possibile ricostruire in un dato momento sulla base delle fonti disponibili).
Il lavoro dello storico si basa sulla ricerca, la lettura, l’interpretazione e la scelta dei documenti, delle fonti primarie, senza le quali non può essere ricostruito alcun avvenimento. In un saggio così preparato, quindi, non si troveranno, se non raramente, espressioni ipotetiche, supposizioni, allusioni; il testo sarà quasi sempre all’indicativo, perché le fonti consultate permettono a chi scrive di avere una chiara visione di quanto va a raccontare. Il ragionamento segue il metodo induttivo. Ovviamente, ciò non significa che ogni libro di storia sia un capolavoro. Come in tutti i settori, esistono anche gli storici mediocri, ma questo è un altro discorso. A differenza dello storico, il lavoro dietrologico normalmente non si preoccupa troppo del riscontro documentale: parte da ipotesi, opera per deduzione e nella narrazione usa spesso il modo condizionale. Anche quando si serve di documenti, solitamente è difficile avere dei riscontri, perché si tratta spesso di documenti poco chiari, incompleti, di dubbia provenienza. La conseguenza principale di tutto ciò è che, mentre il saggio di uno storico produce una “verità storica” finita, che potrà essere smentita o rafforzata alla luce di nuovi documenti, il saggio dietrologico moltiplica le domande di partenza, senza fornire mai una risposta, rimandata regolarmente a un futuro più o meno lontano, quando il “mistero” risultasse finalmente svelato. Il saggio di uno storico, dunque, anche quando è dedicato ad un complotto (per esempio l’assassinio di Kennedy), cerca certezze ed eventualmente rimanda il lettore alla declassificazione dei fondi archivistici per le risposte in sospeso. Quello dietrologico aggiunge nuovi misteri, non svela mai nulla, né è in grado di rimandare il lettore a un futuro certo, perché non sono i fondi d’archivio ad interessarlo. La dietrologia, infatti, non cerca le responsabilità, politiche, amministrative, morali ecc., di un avvenimento, ma il colpevole (o i colpevoli), che fino a quel momento hanno impedito al bravo ricercatore di giungere alla verità (di quale verità si parli, inoltre, resta sempre poco chiaro. La verità storica, per fare un esempio, non è la Verità, ma corrisponde a quanto è possibile ricostruire in un dato momento sulla base delle fonti disponibili).
 rapporti, modi di comportarsi di quel periodo). Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
rapporti, modi di comportarsi di quel periodo). Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).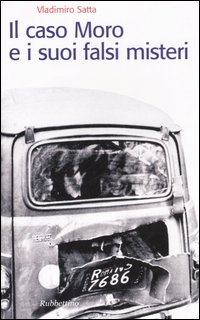 capovolgimento di fronte che stravolge l’esito fin troppo scontato attribuito alle cose. In questo caso vittima del destino cinico e baro è Giovanni Fasanella, autore del libro-intervista realizzato con Alberto Franceschini,
capovolgimento di fronte che stravolge l’esito fin troppo scontato attribuito alle cose. In questo caso vittima del destino cinico e baro è Giovanni Fasanella, autore del libro-intervista realizzato con Alberto Franceschini, polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura.
polemiche che l’accolsero all’indomani della sua emanazione, in occasione della proclamazione della Repubblica, il 22 giugno 1946. In questa direzione, infatti, è rivolta la recensione che lo storico Sergio Luzzato ha scritto sul Corriere della Sera del 19 aprile scorso. Una vera requisitoria contro l’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde, accusato di aver spalancato le porte delle carceri a fascisti e saloini imprigionati subito dopo la Liberazione. Colpevole ancora una volta della sua «proverbiale doppiezza» per aver disconosciuto la responsabilità di quella misura – come lui stesso scrisse – «giusta nelle intenzioni ma sbagliata nell’applicazione», a causa dell’uso politico che ne fece la Dc e dell’interpretazione distorta fornita dalla magistratura. Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).
Al tempo stesso però, come accade per le amnistie francesi del 1951 e del 1953, anch’esse accolte da furiose polemiche, di cui si ebbe testimonianza nel confronto tra Mauriac e Camus, l’applicazione concreta della clemenza viene influenzata dai nuovi scenari geopolitici scaturiti dalla fine del conflitto. La “guerra fredda” spinge i paesi occidentali a rompere il fronte resistenziale e recuperare buona parte del personale compromesso con i passati regimi, per poter garantire una continuità dell’apparato statale in funzione anticomunista. Dietro la «riconciliazione» non ci sono ireniche spinte morali alla concordia ma un cinico calcolo strategico. In previsione dello scontro, il centro-destra democristiano e la sinistra comunista cercano di rafforzarsi reclutando nel passato. In questo modo l’amnistia da luogo ad un singolare paradosso: essa non è più un’occasione per la ricomposizione del corpo politico ma un espediente che perpetua la divisione, seppur in forma nuova, alimentando quella guerra civile fredda che, dopo la parentesi consociativa degli anni 70, vedrà assumere, alla fine del 1989, i connotati di una «guerra civile legale». In realtà, alcuni regi decreti del 44 e del 45 avevano già introdotto alcune misure amnistiali che non tutelavano affatto le azioni della Resistenza armata. Ed è innanzitutto per sanare queste carenze che Togliatti vara un provvedimento molto più organico ed ampio, che estende il beneficio anche ai nemici sconfitti purché incolpati solo di delitti politici, lasciando al giudice il compito dell’accertamento dell’indole politica del reato. Il tutto in un’ottica, come poi spiegò Mario Bracci, uno dei 18 ministri del dicastero De Gasperi che approvarono il provvedimento, che accertasse «le responsabilità dei singoli», evitando la logica delle responsabilità storiche e collettive, che avrebbe finito per imporre l’emarginazione e la persecuzione indiscriminata e non quel «rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale», auspicate dallo stesso Togliatti. E sarà proprio questo il punto dolente del suo provvedimento. Una sorprendente dimostrazione d’angelismo politico o forse, in realtà, di quella precoce volontà di costruire un rapporto privilegiato con la magistratura, ritenuta un vettore di progresso in ragione del mito riformatore dell’azione giudiziaria. Invece, dando prova di un accurato zelo persecutorio, i magistrati della Cassazione, in gran parte reduci del regime, grazie a capziose interpretazioni giurisprudenziali, rovesciarono completamente le intenzioni del legislatore, applicando una clemenza di massa nei confronti dei fascisti, ben 10.034 di loro vennero amnistiati, ed escludendo sistematicamente i Resistenti che si videro riconoscere il beneficio solo in 153 casi. Lo stesso governo dovette promulgare, tre mesi dopo, un decreto che introduceva il divieto di emettere mandati di cattura o revocava quelli già spiccati contro i partigiani (Santosuosso e Colao, Politici e Amnistia, Bertani 1986).