Libri – Alberto Franceschini, a cura di Giovanni Fasanella, Che cosa sono le Br, Bur 2004 (Brigades rouges. L’histoire secrète des BR racontée par leur fondateur, Éditions du Panama 2005)
Libri – Guillaume Perrault, Génération Battisti, Plon, Paris 2005
Paolo Persichetti
23 gennaio 2006
Due libri pubblicati negli ultimi tempi in Francia hanno rilanciato in termini estremamente polemici la tesi secondo cui  le insorgenze armate apparse nell’Italia degli anni 70 avrebbero trovato una complicità culturale, se non aperto sostegno, nelle autorità di Parigi. È significativo dei tempi che corrono questo capovolgimento di prospettiva storica. Quella somma di fattori che presero forma nel dopoguerra, congelando per lungo tempo il sistema politico italiano, fino a renderlo privo d’alternanza per 49 anni, una fissità di sistema che secondo la storiografia più avvertita non poteva che facilitare l’apparizione di spinte rivoluzionarie in presenza di una potente tradizione sovversiva, contesto riassunto nella formula dell’«anomalia italiana», si capovolge nel suo contrario: l’«eccezione francese». Il problema non verrebbe più dalle carenze storiche di un paese che resta tuttora incapace di chiudere con un’amnistia stagioni da lungo tempo concluse, ma dalla sua vicina d’Oltralpe. Nell’intervista che Giovanni Fasanella ha fatto a Alberto Franceschini, la Francia viene dipinta come un «santuario del terrorismo», una centrale che avrebbe sistematicamente promosso la destabilizzazione della democrazia italiana. Siamo nel pieno di una narrazione storica che ripropone alcuni vieti cliché della retorica del complotto e della visione poliziesca della storia. L’obiettivo preso di mira è la cosiddetta «dottrina Mitterrand». Nel corso della sua grottesca testimonianza, un Franceschini ossessionato dalla cultura del sospetto racconta di come il padre, militante comunista ancora impregnato della mentalità staliniana, avuto sentore delle intenzioni bellicose del figlio, l’avesse messo sull’avviso: «ricordati che fuori dal partito c’è soltanto la Cia». Ancora prima della caduta del muro di Berlino, Parigi sarebbe stata dunque un vero incrocio d’intrighi internazionali, sostituendosi a Washington e Mosca nel ruolo di piattaforma destabilizzante dell’Italia. Così si arriva a sostenere che un asse socialdemocratico, guidato da Mitterrand, avrebbe tentato di giocare la terza forza tra le due maggiori potenze, destabilizzando volutamente la penisola grazie alla protezione offerta ai militanti della lotta armata. Quando la storia si trasforma in noir, il racconto può avvalersi di facili licenze narrative e trascurare il rigore cronologico degli eventi, fino a dimenticare che negli anni 70 la Francia era sotto la presidenza di Giscard D’Estaing.
le insorgenze armate apparse nell’Italia degli anni 70 avrebbero trovato una complicità culturale, se non aperto sostegno, nelle autorità di Parigi. È significativo dei tempi che corrono questo capovolgimento di prospettiva storica. Quella somma di fattori che presero forma nel dopoguerra, congelando per lungo tempo il sistema politico italiano, fino a renderlo privo d’alternanza per 49 anni, una fissità di sistema che secondo la storiografia più avvertita non poteva che facilitare l’apparizione di spinte rivoluzionarie in presenza di una potente tradizione sovversiva, contesto riassunto nella formula dell’«anomalia italiana», si capovolge nel suo contrario: l’«eccezione francese». Il problema non verrebbe più dalle carenze storiche di un paese che resta tuttora incapace di chiudere con un’amnistia stagioni da lungo tempo concluse, ma dalla sua vicina d’Oltralpe. Nell’intervista che Giovanni Fasanella ha fatto a Alberto Franceschini, la Francia viene dipinta come un «santuario del terrorismo», una centrale che avrebbe sistematicamente promosso la destabilizzazione della democrazia italiana. Siamo nel pieno di una narrazione storica che ripropone alcuni vieti cliché della retorica del complotto e della visione poliziesca della storia. L’obiettivo preso di mira è la cosiddetta «dottrina Mitterrand». Nel corso della sua grottesca testimonianza, un Franceschini ossessionato dalla cultura del sospetto racconta di come il padre, militante comunista ancora impregnato della mentalità staliniana, avuto sentore delle intenzioni bellicose del figlio, l’avesse messo sull’avviso: «ricordati che fuori dal partito c’è soltanto la Cia». Ancora prima della caduta del muro di Berlino, Parigi sarebbe stata dunque un vero incrocio d’intrighi internazionali, sostituendosi a Washington e Mosca nel ruolo di piattaforma destabilizzante dell’Italia. Così si arriva a sostenere che un asse socialdemocratico, guidato da Mitterrand, avrebbe tentato di giocare la terza forza tra le due maggiori potenze, destabilizzando volutamente la penisola grazie alla protezione offerta ai militanti della lotta armata. Quando la storia si trasforma in noir, il racconto può avvalersi di facili licenze narrative e trascurare il rigore cronologico degli eventi, fino a dimenticare che negli anni 70 la Francia era sotto la presidenza di Giscard D’Estaing.
Durante la guerra d’Algeria, l’Italia aveva sempre rifiutato di estradare i militanti dell’Oas e dell’Fln. Jean-Jacques Susini, coinvolto nell’attentato del Petit Clamart contro De Gaulle, rimase per molti anni sotto la protezione della polizia italiana. Non per questo il nostro paese venne accusato di essere una base antifrancese. Negli anni 80, Mitterrand ripagò l’Italia con la stessa moneta. Di fronte al flusso di rifugiati politici che traversavano le Alpi, fece del suolo francese una sorta di camera di decompressione del conflitto che dilagava in Italia, rifiutando le estradizioni nell’attesa di un’amnistia. «Al di la della risposta giudiziaria – ha spiegato una volta Louis Joinet, vero architetto di questa politica d’asilo (Libération del 23 settembre 2002) – si trattava di facilitare il cammino di chi tentava di uscire dalla lotta armata per andare verso una soluzione politica. L’importante era di non marginalizzare quelli che avevano una riflessione politica».
Per il giudice Rosario Priore, autore della postfazione, le cose non stanno affatto così. Deciso a seguire le tracce de l’abbé Augustin Barruel, afferma: «Con ogni probabilità il cervello parigino è esistito, agendo in perfetta intesa con le autorità di quel paese, come hanno provato le inchieste romane». L’istituto di lingue Hyperion avrebbe rimpiazzato la loggia degli Illuminati di Baviera. Ragione che lo spinse a sospettare dell’abbé Pierre, una delle personalità francesi più note, mentre il suo collega Ferdinando Imposimato voleva spiccare un mandato di cattura contro lo stesso Joinet, consigliere giuridico di Mitterrand. 
Nel pamphlet scritto per denunciare la campagna di sostegno condotta dalla sinistra e da una parte degli intellettuali francesi contro l’estradizione di Cesare Battisti, chiesta dall’Italia nel febbraio 2004, Guillaume Perrault, convinto che «mai democrazia sia stata così liberale nell’affrontare il terrorismo», si dilunga nel descrivere un’Italia paradisiaca, vero giardino di giustizia e di diritto, rappresentazione che non coincide affatto con l’opinione della destra italiana a cui il suo quotidiano fa riferimento. Preso dall’entusiasmo del neofita, per giustificare il fondamento delle estradizioni richieste contro i fuoriusciti, spiega le meraviglie del rito semi-accusatorio, introdotto nel processo penale italiano con la riforma del 1989 e più volte ritoccato. Dimentica però di precisare che tutti i maxi processi per «terrorismo» sono stati condotti col vecchio rito istruttorio e che l’Italia è il paese più sanzionato dalla corte di giustizia di Strasburgo. Crede – per averlo letto da magistrati come Bruti Liberati – che si possa parlare di giustizia d’emergenza solo in presenza di corti speciali, che l’Italia non ha introdotto, e non sa che l’emergenza può darsi anche attraverso la produzione di una legislazione speciale, che mai abolita trasforma l’eccezione in regola. Come è accaduto fin dalla fine degli anni 70 e come la Corte costituzionale ha riconosciuto, giustificando l’adozione da parte del governo e del parlamento di una legislazione d’eccezione mai emendata. Ripercorre, quindi, la selva di prese di posizione sulla vicenda che gli intellettuali della rive gauche, e molti esponenti della letteratura noir, hanno preso – in realtà – a danno di Battisti stesso e degli altri rifugiati, un po’ come la medicina che uccide il malato. Perrault ha facile gioco nel ridicolizzare l’improvvisata ricostruzione storica degli anni 70 proposta da questi intellettuali. Emergono toni che trasudano risentimento, stucchevoli accenti da letteratura termidoriana, commenti codini e farisei, grottesche uscite scandalizzate che ricordano i gridolini d’orrore di madame la marquise, e argomenti che ricordano le accuse del Merlo, una gazzetta che l’Ovra (la polizia segreta fascista) pubblicava a Parigi per calunniare e denigrare i rifugiati antifascisti. Tratti di un generone cialtronesco che straparla senza pensare. Non sfugge al giornalista una recensione, apparsa su Libération dell’8 ottobre 1998 che, recensendo un libro di Battisti, presenta l’insurrezione sociale degli anni 70 come: «l’epopea di una generazione d’Italiani in secessione armata contro una società che non riconoscono più come la loro, raccontata sullo sfondo di un susseguirsi di rapine, alcool e donne[…] Il protagonista va alla guerra come all’amore, quasi fosse un solitario Don Giovanni».
Per spiegare la folgorazione della sinistra francese più snob verso questa caricatura culturale e politica degli anni 70, l’ex ambasciatore Martinet (autore della prefazione) evoca il «complesso del Marrano». Alla stregua di quegli ebrei spagnoli che per sfuggire alle persecuzioni si convertirono al cattolicesimo, rimanendo tuttavia intimamente fedeli alla vecchia religione, la sinistra francese orfana della rivoluzione cercherebbe ancora dei simboli capaci di rinfocolare i vecchi ideali di gioventù. Per Martinet si tratta ovviamente di un abbaglio sconcertante, che testimonierebbe della persistenza di un arcaismo politico novecentesco dentro la sinistra francese, causa di un clamoroso malinteso che l’avrebbe condotta a prendere lucciole per lanterne e chiamare «rivoluzionari» dei semplici «criminali». La controprova sarebbe venuta dalla reazione indignata della sinistra italiana, ai suoi occhi ben più moderna, riformista e liberale. L’ex ambasciatore di Palazzo Farnese guarda senza dubbio con favore al modello social-liberale blairiano, è singolare dunque che non si accorga di come il primo ministro inglese non abbia esitato a sporcarsi le mani con il conflitto irlandese, negoziando con l’Ira, liberando tutti i prigionieri politici, anche quelli con reati di sangue (e l’Ira, come gli altri gruppi irridentisti cattolici o protestanti, metteva le bombe), e stabilito le tappe di un processo politico che ha condotto alla fine del conflitto. In Italia, invece, il tanto decantato Blair viene guardato dai liberali e social-liberali di sinistra come di destra soltanto per le sue politiche di liberalizzazione e privatizzazione economica e sociale. 
Martinet compie anche altre omissioni, dimentica così di spiegare come dietro i rimproveri stizziti piovuti dai cugini d’Oltralpe, ci fosse una sindrome altrettanto curiosa: quella dell’«album di famiglia». Per fare fronte alla perenne carenza di legittimazione istituzionale, la sinistra italiana è posta di fronte alla continua necessità di far dimenticare il proprio passato. Le polemiche seguite all’apparizione del volume di Mirella Serri, I Redenti, hanno ricordato come una buona parte dell’intellighenzia ex comunista abbia vissuto diverse vite, passando il proprio tempo a cancellare le precedenti: dal fascismo della gioventù, al comunismo della maturità, al post o all’anticomunismo della senescenza. In un simile contesto culturale, appare chiaro allora perché i prigionieri e i rifugiati degli anni 70 debbano continuare ad essere relegati nel ruolo di capri espiatori, inchiodati ad una funzione cristica: pagare per tutti «la tragedia del Novecento», rispettando alla lettera il rito della esportazione della colpa.
Racconta ancora Perrault che nel pieno delle feroci polemiche che la stampa italiana aveva lanciato contro la sinistra francese, il sindaco di Roma Walter Veltroni si sarebbe precipitato a telefonare al suo omologo parigino, Bertrand Delanoë, per dissuaderlo dall’appoggiare Battisti. Un’ammirevole sensibilità etica che gli era mancata quando, direttore dell’Unità, fece campagna per la liberazione di alcuni neofascisti rei confessi di una decina di omicidi (e formalmente condannati anche per la strage di Bologna – che Perrault mette sul conto dei gruppi armati di sinistra). La clemenza, sembra dire Veltroni col suo gesto, vale per gli avversari della sponda avversa, non per quelli alla propria sinistra. Ma il doppio linguaggio venuto dall’Italia nei mesi di astiose polemiche sul caso Battisti non termina certo qui. Tra i giustizialisti della sinistra favorevoli alle estradizioni, viene citato anche Antonio Tabucchi, sublime personaggio che eccelle nell’arte di selezionare i pentiti: cattivi quelli che accusano i propri amici (Sofri); buoni quelli che chiamano in causa i nemici (Andreotti o Battisti). Dalle fila della magistratura non sono venuti discorsi migliori: mentre il segretario dell’Anm denunciava «i progetti di fascistizzazione dell’ordinamento giudiziario», fuori d’Italia ci si indignava con gli esponenti della rive gauche che ripetevano ingenuamente quanto letto sulla stampa della sinistra italiana. La destra non era da meno, in casa accusava la magistratura di totalitarismo, ma all’estero pretendeva che le sue sentenze fossero venerate, salvo evidentemente quando queste riguardavano Berlusconi.
Sembra finita qui, e invece ecco emergere un retroscena ancora più inquietante: il 13 giugno 2003, il magistrato della procura antiterrorismo di Parigi, Gilbert Thiel, aveva organizzato insieme alla Direzione nazionale antiterrorismo una retata che sarebbe dovuta scattare il successivo lunedì 23. L’obiettivo era quello di arrestare tre fuoriusciti, tra cui Battisti, insieme ad altri due italiani non latitanti, Maj e Czeppel, i soli che di fatto poi vennero catturati. Un’operazione concordata con i vertici del Viminale e la collaborazione della procura bolognese. L’intera operazione era finalizzata a propagandare un legame diretto con l’arresto, avvenuto nel marzo precedente, di una militante del gruppo autore degli attentati D’Antona e Biagi e validare così la leggenda della «centrale francese», proprio mentre questa era clamorosamente smentita dalle indagini. L’intervento di Chirac che, dopo l’estradizione lampo organizzata dal suo rivale Sarkozy, nell’agosto 2002, aveva accentrato i fascicoli sui rifugiati italiani sotto il controllo dei suoi uffici, fece saltare tutto. Il presidente della repubblica francese, infatti, temeva che la retata venisse interpretata come un regalo a Berlusconi che il primo luglio avrebbe assunto, tra i clamori mediatici della grande operazione antiterrorismo, la presidenza della Ue.
Link
Italie, le thème du complot dans l’historiographie contemporaine – Paolo Persichetti
Ci chiameremo la Brigata rossa
Spazzatura, Sol dell’avvenir il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella
I marziani a Reggio Emilia
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Storia della dottrina Mitterrand

 Fu così che all’alba del giorno seguente venni scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori di ogni trasparenza, concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Quella furtiva consegna celava una flagrante violazione della legalità internazionale: una persona non può essere estradata per dei fatti posteriori a quelli indicati nel decreto, in assenza di una nuova richiesta e previa verifica del suo fondamento. Pur di avallare il teorema della centrale francese le autorità hanno agito aggirando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione europea sulle estradizioni.
Fu così che all’alba del giorno seguente venni scambiato nel tunnel del Monte Bianco. Metafora di un accordo sotterraneo, siglato al di fuori di ogni trasparenza, concluso nel ventre della terra, lontano dalla luce del sole, distante dal chiarore del giorno, dopo una folle corsa nella notte. Quella furtiva consegna celava una flagrante violazione della legalità internazionale: una persona non può essere estradata per dei fatti posteriori a quelli indicati nel decreto, in assenza di una nuova richiesta e previa verifica del suo fondamento. Pur di avallare il teorema della centrale francese le autorità hanno agito aggirando tutti gli obblighi previsti dalla convenzione europea sulle estradizioni.
 I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia.
I nemici dell’amnistia sembrano invece rimasti uguali nel tempo. I loro discorsi e le loro rappresentazioni appaiono immutate. Tratteggiano trame ordite da agenti di un complotto straniero che dopo la Comune chiamava in causa l’attività dell’Internazionale, mentre per i nostri anni Settanta guardano al Kgb o alla Cia, e più recentemente alla Dgse francese, secondo le diverse scuole di pensiero e parrocchie politiche. Anche solo evocare un’ipotesi d’amnistia indigna profondamente. La giustizia deve sempre seguire il suo corso fino in fondo, sfoggiando pene esemplari. Allora come oggi, l’appello alla severità accomuna ambienti della destra e della sinistra. All’epoca la riprovazione maggiore si rivolse contro le pétroleuses, queste nuove streghe dell’Ottocento accusate di aver appiccato incendi con le lampade a petrolio. Molte di loro furono fucilate senza processo. I parigini insorti vennero descritti come un «pugno di scellerati dagli ideali sanguinari e rapaci» (Journal officiel del 22 marzo 1871). La stampa si adoperò per presentare la Comune come una grande impresa di brigantaggio, trasformandola in un informe coacervo di crimini di diritto comune. La spoliticizzazione degli eventi resta il grande fondamento di ogni diniego d’amnistia. ribadito più volte in occasione di alcune recenti estradizioni e da cui trasuda una singolare idea delle istituzioni. Non sorprende tanto l’ipocrita insistenza, pronunciata con studiata pacatezza, sulla supposta forza paziente ma inesorabile dello Stato. Qui Pisanu ha voluto distinguersi dal suo collega di governo, il guardasigilli Roberto Castelli, che ha affermato lo stesso pensiero digrignando rabbiosamente i denti: «pensavate d’averla fatta franca andando all’estero a godervi la vita… Noi vi cercheremo comunque, dovunque e per sempre». Differenze di stile non di sostanza. Paziente o meno, la forza dello Stato resta per essenza strabica ed eccelle nell’esercizio selettivo della memoria. Colpisce semmai la risonanza biblica presente nelle parole del ministro: quella confusione tra i requisiti formali di uno Stato laico e di diritto col Dio terribile della punizione, l’arbitro ultimo e inesorabile del giudizio universale, molto diverso per altro dal Dio misericordioso dei vangeli. Ma la dottrina giuridica positiva ritiene che la sanzione sia altra cosa dal giudizio divino. Essa ha senso solo all’interno di una temporalità storica ben definita, oltre la quale perderebbe significato fino a capovolgersi. Non più giustizia ma vendetta, abuso, persecuzione. Per questo il codice penale prevede la nozione di prescrizione non solo del reato ma anche della pena. L’idea d’imprescrittibilità che recentemente, sotto la spinta dell’euforia penale, nuovo oppio dei popoli, ha guadagnato terreno, è rimasta comunque confinata a crimini eccezionali come quelli contro l’umanità. Certo per le pene più lunghe la prescrizione interviene solo dopo trent’anni, una distanza immensa. Eppure buona parte dei fuoriusciti oramai hanno superato la soglia dei vent’anni dalla condanna, cioè sono più vicini alla tempo della prescrizione che a quello della sanzione. Chi aspira a riportarli nelle carceri vorrebbe invece fermare il tempo e ricondurre indietro le lancette della storia come quei giapponesi persi nelle isole del pacifico.
ribadito più volte in occasione di alcune recenti estradizioni e da cui trasuda una singolare idea delle istituzioni. Non sorprende tanto l’ipocrita insistenza, pronunciata con studiata pacatezza, sulla supposta forza paziente ma inesorabile dello Stato. Qui Pisanu ha voluto distinguersi dal suo collega di governo, il guardasigilli Roberto Castelli, che ha affermato lo stesso pensiero digrignando rabbiosamente i denti: «pensavate d’averla fatta franca andando all’estero a godervi la vita… Noi vi cercheremo comunque, dovunque e per sempre». Differenze di stile non di sostanza. Paziente o meno, la forza dello Stato resta per essenza strabica ed eccelle nell’esercizio selettivo della memoria. Colpisce semmai la risonanza biblica presente nelle parole del ministro: quella confusione tra i requisiti formali di uno Stato laico e di diritto col Dio terribile della punizione, l’arbitro ultimo e inesorabile del giudizio universale, molto diverso per altro dal Dio misericordioso dei vangeli. Ma la dottrina giuridica positiva ritiene che la sanzione sia altra cosa dal giudizio divino. Essa ha senso solo all’interno di una temporalità storica ben definita, oltre la quale perderebbe significato fino a capovolgersi. Non più giustizia ma vendetta, abuso, persecuzione. Per questo il codice penale prevede la nozione di prescrizione non solo del reato ma anche della pena. L’idea d’imprescrittibilità che recentemente, sotto la spinta dell’euforia penale, nuovo oppio dei popoli, ha guadagnato terreno, è rimasta comunque confinata a crimini eccezionali come quelli contro l’umanità. Certo per le pene più lunghe la prescrizione interviene solo dopo trent’anni, una distanza immensa. Eppure buona parte dei fuoriusciti oramai hanno superato la soglia dei vent’anni dalla condanna, cioè sono più vicini alla tempo della prescrizione che a quello della sanzione. Chi aspira a riportarli nelle carceri vorrebbe invece fermare il tempo e ricondurre indietro le lancette della storia come quei giapponesi persi nelle isole del pacifico. Questa anacronistica disputa sul senso di colpa non
Questa anacronistica disputa sul senso di colpa non «Chiediamo all’Unione europea l’inclusione delle Brigate rosse nella lista delle organizzazioni terroristiche», ha affermato il ministro degli Esteri, Franco Frattini, durante il vertice della Nato svoltosi a Bruxelles a inizio aprile 2004. Una richiesta paradossale, poiché rivolta nei confronti di un’organizzazione che non esiste più da ben oltre un decennio e che difficilmente può essere giustificata dall’apparizione di uno scarno numero di imitatori sgominati in breve tempo. Dietro questa richiesta del governo italiano, oltre all’intenzione di mettere in difficoltà la Francia per la venticinquennale ospitalità concessa ai fuoriusciti, vi è la piena adesione all’idea che chiunque abbia, in un modo o nell’altro, preso parte a vicende politiche rivoluzionarie rappresenti una minaccia permanente. Si tratta della palese ammissione che ad essere perseguita non è più l’infrazione eventuale ma l’identità, addirittura remota, delle persone oggetto di queste misure restrittive. Costoro verrebbero considerate, contro ogni buon senso, in possesso di un savoir faire rimasto intatto e aggiornato tecnicamente nei decenni. È questo il nuovo sigillo che le democrazie attuali pongono sulla figura del nemico politico interno, eletto a pericolo permanente e immutabile. Assistiamo in questo modo ad una sorprendente osmosi culturale, ad una micidiale simmetria d’atteggiamento tra le parole di Pisanu e quelle degli autori degli attentati D’Antona e Biagi. Entrambi fanno tabula rasa del decennio 90. Entrambi legittimano le proprie posizioni realizzando una curiosa rimozione storica che cancella l’oltrepassamento realizzato dalla quasi totalità dei prigionieri e dai fuoriusciti della lotta armata, riguardo a una vicenda storica considerata conclusa da oltre un quindicennio.
«Chiediamo all’Unione europea l’inclusione delle Brigate rosse nella lista delle organizzazioni terroristiche», ha affermato il ministro degli Esteri, Franco Frattini, durante il vertice della Nato svoltosi a Bruxelles a inizio aprile 2004. Una richiesta paradossale, poiché rivolta nei confronti di un’organizzazione che non esiste più da ben oltre un decennio e che difficilmente può essere giustificata dall’apparizione di uno scarno numero di imitatori sgominati in breve tempo. Dietro questa richiesta del governo italiano, oltre all’intenzione di mettere in difficoltà la Francia per la venticinquennale ospitalità concessa ai fuoriusciti, vi è la piena adesione all’idea che chiunque abbia, in un modo o nell’altro, preso parte a vicende politiche rivoluzionarie rappresenti una minaccia permanente. Si tratta della palese ammissione che ad essere perseguita non è più l’infrazione eventuale ma l’identità, addirittura remota, delle persone oggetto di queste misure restrittive. Costoro verrebbero considerate, contro ogni buon senso, in possesso di un savoir faire rimasto intatto e aggiornato tecnicamente nei decenni. È questo il nuovo sigillo che le democrazie attuali pongono sulla figura del nemico politico interno, eletto a pericolo permanente e immutabile. Assistiamo in questo modo ad una sorprendente osmosi culturale, ad una micidiale simmetria d’atteggiamento tra le parole di Pisanu e quelle degli autori degli attentati D’Antona e Biagi. Entrambi fanno tabula rasa del decennio 90. Entrambi legittimano le proprie posizioni realizzando una curiosa rimozione storica che cancella l’oltrepassamento realizzato dalla quasi totalità dei prigionieri e dai fuoriusciti della lotta armata, riguardo a una vicenda storica considerata conclusa da oltre un quindicennio.
 veniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001.
veniva fornita negli anni in cui il diritto estradizionale non era stato ancora abrogato dall’entrata in vigore del mandato d’arresto europeo. Le nuove procedure, infatti, hanno introdotto il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di giustizia penale, tra gli stati membri dell’Unione. Una prassi che inaugura lo spazio giudiziario europeo sotto i cattivi auspici di un evidente disequilibrio tra le accresciute potenzialità repressive delle autorità statali e le ridotte garanzie di tutela dei singoli cittadini dell’Unione. L’obiettivo primario delle nuove norme entrate in vigore nel 2004 è quello di togliere al potere politico la possibilità di decidere, in ultima istanza, sulla estradizione. Infatti, nella vecchia tradizione sancita dai numerosi trattati bilaterali sorti nell’epoca dello jus publicum europeum, e poi recepita nelle diverse convenzioni europee pattuite nel corso del Novecento, la decisione (ben diversa dalla emissione di un semplice avviso tecnico) restava una prerogativa sovrana del potere politico. Più che di un processo di desovranizzazione siamo di fronte ad una nuova forma di sovranità, non più stabilita su scala nazionale e sulla base di una legittimità politica derivante dal suffragio, ma proiettata in uno spazio sovranazionale sorretto da una legittimità che non trae fondamento dal suffragio, ma dal processo d’integrazione e d’autonomizzazione di alcune tecnostrutture statali. I vari protocolli stabiliti con il sistema informatico Schengen, il mandato d’arresto europeo, Europol ed Eurojust stanno alle vecchie sovranità politiche come la Banca centrale europea sta alla vecchie politiche economiche nazionali di scuola keynesiana. Il diritto estradizionale ha rappresentato per oltre un secolo il meglio della cultura giuridica di scuola liberale. Maturato nella temperie delle lotte nazionali, democratiche e repubblicane del XIX° secolo, esso viene definitivamente sotterrato nell’epoca che vanta il dominio assoluto del modello neoliberale sul pianeta. Circostanza che suggerisce più di una riflessione sulla natura liberticida e dispotica del neoliberismo contemporaneo, marcato dall’eccezione permanente inaugurata subito dopo l’11 settembre 2001. La nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha
La nuova procedura d’estradizione avviata contro Cesare Battisti ha

 confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi.
confronti dei fuoriusciti riparati in Francia. Tra questi il primo a cadere nella rete è stato Cesare Battisti, attorno alla cui vicenda si è aperta un‘accesissima disputa giuridica e storica che ha chiamato in causa temi molto rilevanti: l’esercizio o meno della giustizia d’eccezione, il rapporto con il passato, il ruolo e l’uso politico della memoria; oppure questioni etiche come l’evocazione del male, il problema della colpa e dell’eventuale elaborazione sociale del lutto. Una discussione ampia e dai toni spesso crudi, a volte persino impropri e caricaturali, che dimostra come i passati rivoluzionari fatichino a diventare storia. Adagiati nel limbo della rimozione periodicamente vedono schiudersi le porte dell’inferno che risucchia brandelli di vita, trascina esistenze sospese. Lasciti, residui d’epoche finite che non diventano memoria, ma sono solo ostaggio di quel che riserverà la storia. Non un passato che torna ma un futuro che manca. Oltre trent’anni ci separano dall’inizio della lotta armata, almeno quindici dalla sua conclusione, riconosciuta con documenti politici e dichiarazioni ufficiali, tra il 1987 e il 1989, dagli stessi protagonisti. L’80% dei prigionieri è in carcere da un periodo che oscilla tra i 21 e i 26 anni; i restanti almeno da 16. Poi ci sono i casi estremi, come quello di Paolo Maurizio Ferrari rinchiuso da trent’anni. Tutto ciò non appaga affatto i partigiani della certezza della pena. I fautori della legalità ritengono, infatti, che vi siano tuttora conti aperti, anche quando le indagini hanno dimostrato che i due attentati del 1999 e del 2002, venuti inaspettatatamente ad interrompere oltre un decennio di silenzio, nulla hanno a che vedere con il passato e tanto meno con un fantomatico “santuario francese”, inizialmente accreditato dalle autorità per giustificare le estradizioni. La coazione a ripetere vuoti gesti del passato, era solo l’opera di un piccolo gruppo che ha trovato conforto nei suoi propositi grazie alla rimozione degli anni 70, al rifiuto ostinato dell’amnistia che ha congelato il tempo e cristallizzato le epoche, tentando di impedire a quel sapere incarcerato, a quelle esperienze sotto chiave o esiliate, di far valere le ragioni dell’irriproducibilità e inattualità dei modelli di lotta armata trascorsi. In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità.
In realtà l’esperienza italiana ha innovato il repertorio classico dello stato d’eccezione, mettendo in pratica un modello molto diverso da quella situazione di “sospensione” o “vuoto” del diritto di cui ha recentemente scritto il filosofo Giorgio Agamben (Lo stato d’eccezione , Bollati Boringhieri 2003). L’Italia non ha affatto sospeso il diritto ordinario; non ha avuto bisogno di dotarsi di giurisdizioni speciali (troppo forte era il ricordo del tribunale speciale fascista). Al contrario ha stravolto, deformato, inquinato il diritto penale corrente, camuffando sapientemente l’eccezione e rendendola in questo modo permanente. L’Italia ha fatto a meno di giudici militari perché, sotto la toga, la magistratura ordinaria ha indossato l’uniforme dello Stato etico, sposando una vocazione purificatrice e combattente del proprio ruolo, dotandosi di un potentissimo arsenale penale speciale. Larghi settori della società italiana rimproverano i prigionieri e in rifugiati di non aver mai fatto atto di pubblico pentimento e per questo di aver eluso il senso di colpa, mantenendo per giunta un atteggiamento ambiguo nei confronti di una cultura politica che non esclude il ricorso alla violenza. Il superamento del passato resta ancora un terreno di controversia. Ciò che per i prigionieri e i rifugiati è oramai storia, materia d’indagine e inchieste serrate, da discutere con le tecniche fredde e puntigliose delle scienze sociali; per i media, per la quasi totalità del ceto politico e per larghi settori della società civile è tuttora una ferita aperta, una piaga viva che non può e non deve cicatrizzarsi. Allo scandaglio del lavoro storico si contrappone la venerazione di una memoria trasfigurata nel culto di un dolore non riassorbibile. Al lavoro d’incorporazione del passato, doloroso e conflittuale, si sostituisce un atteggiamento di rifiuto che fa del passato una trincea su cui attestarsi. L’elaborazione del lutto diventa in questo modo, secondo una consolidata tradizione inquisitoriale, uno strumento di bonifica delle coscienze, che aggiunge alla sanzione sui corpi anche la correzione delle menti. Un percorso a senso unico che pretende di imporre i valori dei vincitori come l’orizzonte della maturità.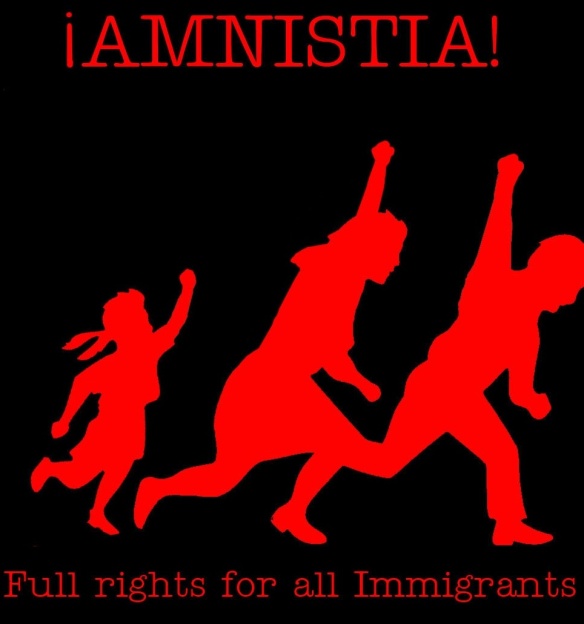 qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto
qualcosa che racchiude il massimo d’irrealismo politico e d’immoralità etica. Strano destino quello di un istituto nato con la democrazia ateniese e divenuto plomb. Si je reviens aujourd’hui sur cette question à propos de l’extradition des citoyens italiens réfugiés en France, c’est parce que ce qui est en jeu ici n’est pas seulement le rapport d’un État de l’Union européenne avec son passé plus ou moins lointain. En réalité, la question concerne tous les Européens, parce qu’il en va de l’image même de l’Europe qui est en train de se construire. Cette image repose sur le présupposé selon lequel, puisque tous les États membres de l’Union sont des Démocraties, il est impossible qu’il existe des réfugiés politiques provenant de l’un d’entre eux. Un tel principe est une fiction, dont l’hypocrisie est évidente. La figure de l’exilé a accompagné l’histoire de la démocratie depuis ses origines en Grèce classique, et il est probable qu’elle continuera à le faire, du moins tant que le processus de dépolitisation, actuellement en cours dans les pays industriels avancés, n’aura pas liquidé tout conflit politique.
plomb. Si je reviens aujourd’hui sur cette question à propos de l’extradition des citoyens italiens réfugiés en France, c’est parce que ce qui est en jeu ici n’est pas seulement le rapport d’un État de l’Union européenne avec son passé plus ou moins lointain. En réalité, la question concerne tous les Européens, parce qu’il en va de l’image même de l’Europe qui est en train de se construire. Cette image repose sur le présupposé selon lequel, puisque tous les États membres de l’Union sont des Démocraties, il est impossible qu’il existe des réfugiés politiques provenant de l’un d’entre eux. Un tel principe est une fiction, dont l’hypocrisie est évidente. La figure de l’exilé a accompagné l’histoire de la démocratie depuis ses origines en Grèce classique, et il est probable qu’elle continuera à le faire, du moins tant que le processus de dépolitisation, actuellement en cours dans les pays industriels avancés, n’aura pas liquidé tout conflit politique. Era una calda sera d’estate quella del 24 agosto 2002 e l’Italia aveva urgente bisogno di recuperare uno di quei giovani maledetti degli anni ribelli per offrirlo in pasto all’opinione pubblica. Una grossolana impostura, escogitata con l’intento di fornire l’immagine truccata di un brillante successo operativo dopo l’attentato mortale contro un collaboratore del governo. Marco Biagi era stato ucciso pochi mesi prima da un piccolo gruppo che aveva riesumato dal museo della storia una delle ultime sigle della lotta armata. Un paese distratto e annoiato, persino futile, conquistato dall’avidità dell’oblio, impaurito dalla possibilità di sapere, era stato scosso dal frastuono di quegli spari improvvisi. Irritato dal brusco risveglio, aveva rovistato furiosamente in un passato ormai sconosciuto. Cercava in spazi e tempi lontani i responsabili di quei colpi senza radici. Attribuiva al passato quella che era una surreale imitazione figlia del presente. Cercava nelle figure di ieri dei colpevoli per l’oggi.
Era una calda sera d’estate quella del 24 agosto 2002 e l’Italia aveva urgente bisogno di recuperare uno di quei giovani maledetti degli anni ribelli per offrirlo in pasto all’opinione pubblica. Una grossolana impostura, escogitata con l’intento di fornire l’immagine truccata di un brillante successo operativo dopo l’attentato mortale contro un collaboratore del governo. Marco Biagi era stato ucciso pochi mesi prima da un piccolo gruppo che aveva riesumato dal museo della storia una delle ultime sigle della lotta armata. Un paese distratto e annoiato, persino futile, conquistato dall’avidità dell’oblio, impaurito dalla possibilità di sapere, era stato scosso dal frastuono di quegli spari improvvisi. Irritato dal brusco risveglio, aveva rovistato furiosamente in un passato ormai sconosciuto. Cercava in spazi e tempi lontani i responsabili di quei colpi senza radici. Attribuiva al passato quella che era una surreale imitazione figlia del presente. Cercava nelle figure di ieri dei colpevoli per l’oggi. Era stato
Era stato proposta di dar vita ad una nuova formazione politica, che l’Unità pubblicava con rilievo la notizia di un gruppo di ex appartenenti al movimento del 77 bolognese intensionati ad aderire al nuovo partito occhettiano, la «Cosa», nato dopo l’annuncio della Bolognina. L’iniziativa non era frutto di una operazione unilaterale, bensì il prodotto di contatti e discussioni evidentemente giunti a buon punto. Non fu certo un caso se al termine della scorsa estate, durante un dibattito svoltosi nel corso della festa della Fgci a Castel Sant’Angelo, si ritrovarono dietro ad uno stesso tavolo Massimo D’Alema, Franco Berardi, detto Bifo, (uno degli esponenti più noti del movimento del 77 bolognese) e altri per discutere proprio del 1977. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti se è vero che ad Oreste Scalzone, esule a Parigi, poco tempo fa è stata respinta la richiesta di adesione al Pds, per altro con una motivazione che ha del grottesco. Lo statuto del nuovo partito, infatti, impedirebbe l’iscrizione a chiunque sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici o abbia subito condanna per delitto grave. L’ingresso in un partito politico appare, così, normativamente equiparato a quello in una amministrazione pubblica. Triste fine per il partito dei diritti che assume come propria regola interna una «pena accessoria» che compromette la piena affermazione dei diritti civili. Ancor di più viene da chiedersi quale sia ormai il senso della storia per quella parte del corpo politico che vorrebbe impersonare la sinistra. Quanti fondatori, dirigenti, militanti del Pci sono diventati pregiudicati secondo le norme del codice Rocco? Le stesse che, con l’aggiunta delle aggravanti della legge speciale Cossiga, hanno reso pregiudicato Scalzone e migliaia di altri partecipanti alle formazioni politiche della sinistra estrema (armata e non) nel corso degli anni 70 e 80.
proposta di dar vita ad una nuova formazione politica, che l’Unità pubblicava con rilievo la notizia di un gruppo di ex appartenenti al movimento del 77 bolognese intensionati ad aderire al nuovo partito occhettiano, la «Cosa», nato dopo l’annuncio della Bolognina. L’iniziativa non era frutto di una operazione unilaterale, bensì il prodotto di contatti e discussioni evidentemente giunti a buon punto. Non fu certo un caso se al termine della scorsa estate, durante un dibattito svoltosi nel corso della festa della Fgci a Castel Sant’Angelo, si ritrovarono dietro ad uno stesso tavolo Massimo D’Alema, Franco Berardi, detto Bifo, (uno degli esponenti più noti del movimento del 77 bolognese) e altri per discutere proprio del 1977. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti se è vero che ad Oreste Scalzone, esule a Parigi, poco tempo fa è stata respinta la richiesta di adesione al Pds, per altro con una motivazione che ha del grottesco. Lo statuto del nuovo partito, infatti, impedirebbe l’iscrizione a chiunque sia incorso nella interdizione dai pubblici uffici o abbia subito condanna per delitto grave. L’ingresso in un partito politico appare, così, normativamente equiparato a quello in una amministrazione pubblica. Triste fine per il partito dei diritti che assume come propria regola interna una «pena accessoria» che compromette la piena affermazione dei diritti civili. Ancor di più viene da chiedersi quale sia ormai il senso della storia per quella parte del corpo politico che vorrebbe impersonare la sinistra. Quanti fondatori, dirigenti, militanti del Pci sono diventati pregiudicati secondo le norme del codice Rocco? Le stesse che, con l’aggiunta delle aggravanti della legge speciale Cossiga, hanno reso pregiudicato Scalzone e migliaia di altri partecipanti alle formazioni politiche della sinistra estrema (armata e non) nel corso degli anni 70 e 80. 
 Le reticenze e le oscillazioni nel ripensare la politica di quella intera stagione, le premesse e le conseguenze, sono sicuramente parte dei diversi motivi che hanno condotto alla crisi e al declino della sinistra italiana. E rappresentano una pesante ipoteca su ogni sua possibilità futura. Dalla «scena madre», i nodi problematici di questa crisi si sono trasmessi alle nuove formazioni politiche. Il nodo irrisolto degli anni 70 è tema trasversale di tutta l’attuale sinistra italiana. Anche per il suo versante comunista, Rifondazione: fin troppo carico di incertezze e differenze interne è il suo impegno sul tema della fine dell’emergenza e di una soluzione politica radicale, nonostante l’attività coraggiosa ma ancora troppo isolata di alcuni suoi dirigenti. Forse esagerava un po’ Luigi Pintor nei giorni scorsi quando, commentando il dibattito alla camera su Cossiga, constatava con la sua solita amara ironia come ormai l’opposizione sembra essere un concetto d’altri tempi e la sinistra una mera espressione geografica. Sbagliava Pintor e sbagliavamo tutti noi a pensare una cosa del genere. Perché invece in Italia una sinistra esiste. È la sinistra perbene. A quanto pare l’unica sinistra possibile.
Le reticenze e le oscillazioni nel ripensare la politica di quella intera stagione, le premesse e le conseguenze, sono sicuramente parte dei diversi motivi che hanno condotto alla crisi e al declino della sinistra italiana. E rappresentano una pesante ipoteca su ogni sua possibilità futura. Dalla «scena madre», i nodi problematici di questa crisi si sono trasmessi alle nuove formazioni politiche. Il nodo irrisolto degli anni 70 è tema trasversale di tutta l’attuale sinistra italiana. Anche per il suo versante comunista, Rifondazione: fin troppo carico di incertezze e differenze interne è il suo impegno sul tema della fine dell’emergenza e di una soluzione politica radicale, nonostante l’attività coraggiosa ma ancora troppo isolata di alcuni suoi dirigenti. Forse esagerava un po’ Luigi Pintor nei giorni scorsi quando, commentando il dibattito alla camera su Cossiga, constatava con la sua solita amara ironia come ormai l’opposizione sembra essere un concetto d’altri tempi e la sinistra una mera espressione geografica. Sbagliava Pintor e sbagliavamo tutti noi a pensare una cosa del genere. Perché invece in Italia una sinistra esiste. È la sinistra perbene. A quanto pare l’unica sinistra possibile.