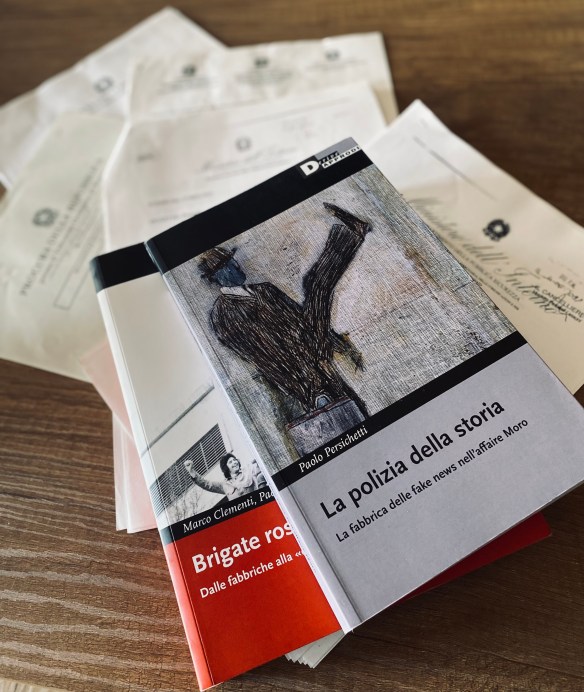Lo scorso 11 aprile, all’età di 78 anni, è morto Alberto Franceschini tra i fondatori delle Brigate rosse. La notizia tenuta riservata secondo le sue ultime volontà è trapelata soltanto il 26 aprile, giorno dei funerali di Papa Bergoglio.

Il Mega
In carcere Franceschini veniva chiamato con deferenza dai suoi fedelissimi: il «Mega». Una prova di immodestia che per quelle singolari coincidenze della storia non lo ha abbandonato neanche al momento della dipartita. Il soprannome gli era stato attribuito da alcuni detenuti politicizzatisi in carcere, appartenenti ai «proletari prigionieri» che dall’interno dei gironi infernali delle prigioni speciali avevano aderito alle «Brigate di campo», l’organizzazione carceraria messa in piedi dalle Brigate rosse nelle prigioni di massima sicurezza.
Le Brigate di campo, almeno nell’idea originaria, dovevano essere degli embrioni di democrazia del popolo detenuto: furono protagoniste nel loro momento migliore delle lotte all’interno delle carceri speciali per migliorare le condizioni di vita, gli spazi di agibilità e socialità, la libertà di discussione e studio, di rivolte come l’Asinara e Trani, di innumerevoli tentativi di evasione. Un formidabile strumento di contropotere e di democrazia dal basso. Purtroppo finirono col tempo per divenire in alcune situazioni degenerate delle leve di potere e terrore in mano a pochi individui, identificati come «capi» per il loro carisma, che decidevano della vita e della morte degli altri prigionieri, tacciando immediatamente di «resa» al nemico, «tradimento» e «infamità» chiunque non fosse allineato. Franceschini fu uno di questi, anzi fu l’indiscusso leader supremo di questo dispotismo carcerario che aprì la «caccia ai traditori» e provocò la morte di alcuni militanti a cui le forze di polizia avevano estorto informazioni sotto tortura mentre altri furono salvati in extremis in situazioni dove i suoi adepti non avevano la forza per imporsi.
Il naufragio politico e umano
Fino a quando non aveva consolidato un ferreo potere carcerario, per tutti Franceschini era solo «Franz». Questo slittamento semantico, questa trasformazione del nome è stata la prima metamorfosi del personaggio, seguita da altre. Occorre partire da qui, e in particolare dal tragico fallimento del Partito guerriglia, la fazione brigatista di breve durata nata nella primavera del 1981 da una scissione che dal carcere aveva lungamente ispirato, insieme a Curcio, per comprenderne le diverse vite e il suo definitivo naufragio politico e umano. Nel 1982, dopo otto anni di carcere si dissocia dalla lotta armata, esce dalle carceri speciali ed entra nel circuito delle «aree omogenee», istituti di pena premiali pensati per chi aveva preso le distanze da conflitto armato, dove la pressione carceraria era attenuata e le condizioni di vita agevolate. Nel 1987, grazie all’ultima legge sulla dissociazione ottiene cospicui sconti di pena iniziando il percorso di uscita dalla prigione. Ma più che ripudiare il proprio passato, o come direbbero i professionisti della correzione carceraria, «rivisitarlo criticamente», Franceschini elabora da quel momento una riscrittura della propria storia politica finalizzata a cancellare ogni traccia di quei momenti indicibili che avrebbero compromesso il suo percorso postcarcerario. La figura del rinnegato è un classico dell’antropologia umana, la differenza che lo distingue da colui che ripensa in modo critico la propria esperienza sta nella attribuzione delle responsabilità, nella collocazione del proprio io all’interno del bilancio esistenziale. Il rinnegato fa l’autocritica degli altri, esime se stesso da ogni colpa e trova nell’altrui comportamento tutte le responsabilità.
Pinerolo
Punti chiave nella vita di Franceschini sono il momento della sua cattura e le ripetute fallite evasioni. Viene arrestato per caso nel settembre del 1974. Non doveva essere insieme a Curcio in quel di Pinerolo dove il generale Dalla Chiesa aveva teso una trappola utilizzando Silvano Girotto come esca. I suoi compagni lo pensavano a Roma, rientrato nella base dove in quel periodo era sceso con Prospero Gallinari e Fabrizio Pelli per organizzare il sequestro di un politico democristiano e affondare così il colpo al «cuore dello Stato». Eppure anni dopo attribuì la responsabilità dell’accaduto a Mario Moretti, colpevole di non esser riuscito a rintracciare Curcio in tempo, dopo una rocambolesca ricerca notturna e il tortuoso percorso di un messaggio che avvertiva del pericolo.
Va detto che un ruolo centrale nella costruzione della leggenda contro Moretti l’ebbe Giorgio Semeria, un altro brigatista molto vicino a Franceschini. Anche qui decisiva fu la cattura e l’incapacità di accettare i propri errori. Arrestato una prima volta nel maggio del 72, seguendo Semeria la polizia realizzò una retata contro l’intera colonna milanese. Scarcerato per scadenza termini, venne riarrestato e quasi ucciso nel marzo del 1976 da un carabiniere alla stazione centrale di Milano grazie all’attività di un confidente, Leonio Bozzato, operaio dell’Assemblea autonoma di Porto Marghera che operava come informatore per conto del Sid nella colonna veneta diretta proprio da Semeria. Una volta in carcere, Semeria si convinse che dietro al suo arresto e quelli precedenti di Franceschini e Curcio ci fosse Moretti (del ruolo di Bozzato saprà solo anni dopo). Una ossessione sposata da Franceschini nonostante le smentite dei componenti dell’Esecutivo. Serve poco la politica ma tanta psicanalisi per leggere questi comportamenti che nei decenni successivi alimenteranno una dietrologia infinita. La storia ci dice ben altro: Franceschini e Semeria, una volta dissociati, usciranno dal carcere ottenendo come premio cospicui sconti di pena, mentre Moretti dopo 44 anni è ancora in esecuzione pena con sei ergastoli sulle spalle.
Il ritorno nel Pci e la dietrologia
Una volta fuori Franceschini ritrova l’abbraccio del vecchio Pci emiliano da cui proveniva. Il suo ex segretario ai tempi della militanza nella Fgci di Regio Emilia l’accoglie e gli offre un posto di lavoro all’Arci, in cambio farà da sponda alle ricostruzioni dietrologiche della storia brigatista avviando una stretta collaborazione con il senatore Sergio Flamigni, membro di diverse commissioni parlamentari d’inchiesta sul sequestro Moro. Il Pci aveva bisogno di Franceschini per dare forza all’alibi che doveva fornire una giustificazione al fallimento delle proprie strategie politiche: dal compromesso storico alla linea della fermezza durante il rapimento Moro. A tavolino costruisce la leggenda delle prime Brigate rosse «buone», contrapposte alle «bierre» militariste, sanguinarie ed eterodirette di Moretti. Eppure era tra i militanti che scelsero il passaggio alla clandestinità, presente nell’estate del 1974 quando si avviarono le fondamenta della nuova struttura organizzativa che poi segnerà il funzionamento delle Br negli anni successivi. Fu lui a gestire in prima persona il sequestro Sossi che segnava il cambio di strategia e l’attacco al cuore dello Stato. Sempre lui era sceso a Roma per compiere inizialmente quel sequestro di un esponente Dc che poi verrà portato a termine nel marzo 1978. Inventò di sana pianta l’esistenza del legame di Moretti col Superclan per celare la propria appartenenza al servizio d’ordine diretto da Simioni e il fatto che Moretti fu il primo a rompere ogni rapporto con quel gruppo. Una storia rovesciata che lo vedeva sempre nel ruolo immacolato di puro e ragionevole. Alcuni collaboratori racconteranno dei rimproveri da lui lanciati contro i compagni esterni perché la morte di Margherita Cagol tardava ad essere vendicata. Dal carcere si distinguerà per i continui inviti a elevare il livello di scontro all’esterno e organizzare evasioni. Richieste che distoglieranno le colonne esterne dal lavoro politico nei posti di lavoro e nei territori. E quando i tentativi di evasione falliranno, come quello messo in piedi dalla colonna romana dall’isola dell’Asinara, dopo averci lavorato una intera estate, imputerà il fallimento a una mancata volontà politica radicalizzando sempre più le sue posizioni fino a formulare, dopo un durissimo pestaggio subito nel carcere di Nuoro, richieste di rappresaglia che mettevano in luce i segni preoccupanti di squilibrio, come affondare uno dei traghetti che collegavano la Sardegna al continente.
Scriveva Bertolt Brecht che non c’è peggior nemico per gli elefanti liberi dell’elefante addomesticato.