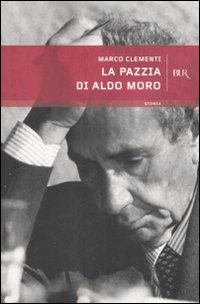Nelle cronache televisive e giornalistiche di questi giorni la figura di Prospero Gallinari è stata descritta come quella di un personaggio ambiguo e reticente, morto portando con sé (supposti) «segreti e misteri sul caso Moro». Un’accusa che serve a sorreggere un’antica calunnia: questi silenzi sarebbero stati la merce di scambio per uscire dal carcere. Una tesi che Miguel Gotor ha largamente sostenuto nel suo Il Memoriale della Repubblica, Einaudi 2011, cadendo tuttavia in palesi contraddizioni.
Nelle cronache televisive e giornalistiche di questi giorni la figura di Prospero Gallinari è stata descritta come quella di un personaggio ambiguo e reticente, morto portando con sé (supposti) «segreti e misteri sul caso Moro». Un’accusa che serve a sorreggere un’antica calunnia: questi silenzi sarebbero stati la merce di scambio per uscire dal carcere. Una tesi che Miguel Gotor ha largamente sostenuto nel suo Il Memoriale della Repubblica, Einaudi 2011, cadendo tuttavia in palesi contraddizioni.
Mario Moretti è da 32 anni in stato detentivo, semilibero dal 1997, anche se Gotor con una grossolana imprecisione scrive che è libero dal 1994. Un errore importante poiché su questa grave inesattezza poggia l’intera impalcatura del suo teorema.
Gallinari, come abbiamo visto (leggi qui) era agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute che lo rendevano incompatibile alla detenzione; Rita Algranati è in carcere. Due presunti componenti del commando che operò in via Fani sono all’estero. Uno di questi, Alvaro Lojacono, ha scontato la pena in Svizzera. Tutti gli altri, a 34 anni dai fatti (una distanza senza precedenti nella storia d’Italia e nel resto d’Europa), hanno terminato le loro condanne: chi perché essendosi dissociato ha usufruito da tempo di ampi sconti di pena; chi perché alla fine del lungo percorso penitenziario ha avuto accesso alla liberazione condizionale.
A queste accuse ha risposto Francesco Piccioni in una intervista apparsa su Contropiano (leggi qui).
Altri commentatori hanno poi offerto delle raffigurazioni grottesce e caricaturali di Gallinari, dipinto come uno «stalinista», pronto a sacrificare chiunque se il disegno superiore della rivoluzione lo avesse richiesto (Andrea Colombo), personaggio spietato, sospetto agente del Kgb, adepto della scuola del comunismo sovietico (Fasanella), dove avrebbe «imparato a coniugare la durezza ideologica con la disponibilità al compromesso, la rivendicazione orgogliosa delle proprie scelte, anche quelle più tragiche, con la tendenza a scendere a patti con il diavolo» (sempre Fasanella).
Ma chi era veramente Prospero Gallinari? Senza avere la pretesa di essere esaustivo, questo scambio che ho avuto in queste ore con Andrea Colombo dopo un suo articolo apparso sul sito online de Gli Altri, può aiutare a capirne qualcosa di più
Caro Andrea Colombo,
ripeto, il tuo pezzo poteva essere bello perché capace di cogliere alcuni aspetti decisivi della personalità di Prospero Gallinari e soprattutto di ricordare come non si sia mai fatto estorcere – come ha recentemente sottolineato Scalzone – “nessuna confessione d’innocenza” di fronte all’accusa rivelatasi alla fine inesatta di essere stato l’esecutore materiale di Moro, nonostante ciò l’avrebbe probabilmente aiutato ad uscire molto prima dal carcere per le sue difficilissime condizioni di salute.
Caratteristiche che tu però hai confinato unicamente alla dimensione umana del personaggio, mentre in una sorta di chiaroscuro ne hai demonizzato quella politica, dandogli dello “stalinista”.
Cito: «era un rivoluzionario generoso e di animo buono, ma era anche uno stalinista, uno di quelli che se il partito glielo avesse ordinato ti avrebbe eliminato, con le lacrime agli occhi ma senza esitare, convinto che questo fosse il suo dovere di rivoluzionario e di soldato della guerra di classe. Quella spietatezza politica era inaccettabile, certo, ma Prospero la condivideva con migliaia e migliaia di militanti dei suoi tempi. Che non erano i nostri, perché Prospero Gallinari era davvero un uomo e un rivoluzionario e un comunista “d’altri tempi”.
Affermazione che fa il paio con quella precedente, “Con noi, ragazzi di movimento, che negli anni ’70 il Pci lo odiavamo e lo combattevamo aveva pochissimo a che spartire. […]Ci guardava con sospetto, come quasi tutti i brigatisti, operai e contadini la cui continuità con la tradizione comunista era molto più ferrea della nostra».
Mi riferivo, con tutta evidenza a questi infelici passaggi quando ho accennato a quel dizionario dei luoghi comuni nel quale alla fine sei inevitabilmente scivolato. E mi sembra che nella replica tu abbia colto perfettamente il senso della mia critica, imbarcandoti tuttavia in un tentativo di precisazione del senso che attribuivi al termine “stalinismo” che non solo non rende giustizia a Prospero, ma trasforma questa categoria in una sorta di concetto metastorico del tutto fuorviante.
Andiamo per ordine: sostieni che la risposta di Gallinari su Tienanmen sarebbe un dettaglio banale! A me non sembra proprio, al contrario la trovo dirimente. Tu invece lasci ingiustamente pensare che sia stato un escamotage intelligente per dissimulare un’identità in quel momento impopolare. E la cosa, se mi permetti, è ancora più offensiva per la memoria di Prospero perché oltre a dargli dello stalinista gli dai pure del dissimulatore.
Le Br, nel bene o nel male, hanno sempre detto quello che sono state e sono sempre state quello che hanno detto. Se avessero appoggiato il “socialismo di mercato” cinese, come accade per tutte le varie tendenze con venature rosso-brune, nazional-bolsceviche, identitarie e comunitariste, che ormai dilagano ben oltre gli ambienti veterocomunisti, in quel momento l’avrebbero sostenuto senza problemi.
Ma la loro storia ci dice che hanno tentato di rappresentare l’opposto.
Nella tua replica introduci con molta leggerezza una equivalenza tra terzointernazionalismo e stalinismo per poi affermare che “voi”, cioè noi brigatisti di più generazioni, saremmo stati gli epigoni di quella cultura politica.
Capisco che nella tua affermazione sia contenuta una carica polemica antica derivante dalla tua originaria appartenenza ad una delle componenti dell’operaismo che si è sempre narrata come l’unica legittima rappresentante di quella storia, in realtà molto complessa, e si è autoincensata come l’antitesi intelligente e moderna, rivale e alternativa alle culture considerate “vetero” presenti nel resto del movimento, anzi “esterne” al movimento come vi piaceva tanto dire delle Brigate rosse.
Per fortuna, caro Andrea, la storia è ben più complessa, articolata, carica di sfumature e sorprendenti smentite. Dovreste liberarvi, tu e i tuoi amici postoperaisti e postnegriani, da certe leggende ideologiche, uscire dalle narrazioni autocelebrative e calarvi all’interno di una visione più laica degli anni 70, che alcune ricerche sociologiche sull’origine politica-ideologica dei militanti della lotta armata, e delle Brigate rosse in particolare, già consentono.
Da tempo questi dati ci dicono che il grosso dei militanti della lotta armata viene dal filone operaista, comprese le Br che pure, a differenza di altre formazioni armate più omogenee, hanno avuto una composizione socio-ideologica molto eclettica che nei 19 anni della loro storia ha reclutato nelle aree politiche più disparate, subendo anche influenze legate al peso delle diverse generazioni che vi affluivano.
Se le Br fossero state soltanto quella sorta di cartolina di Épinal in salsa emiliana legata alla vicenda del gruppo dell’appartamento o dei trentini della facoltà di sociologia, sarebbero finite con la trappola di Girotto-frate Mitra. Quella emiliana fu una enclave mitizzata e mediatizzata a cui crede ormai solo quel cospirazionista attardato di Fasanella, anche perché per anni molti di quel gruppo hanno rappresentato la parte visibile dell’organizzazione, quella finita in carcere.
In realtà l’insediamento più grosso e strutturale stava nelle fabbriche del triangolo industriale, proveniva dall’esperienza dei Cub, era l’anima operaia, quell’operaio massa nuovo e sovversivo.
Ma ciò che ha fatto sopravvivere questo gruppo per quasi due decenni è stata la capacità di uscire anche dalla fabbrica, radicarsi nel territorio, insediarsi nelle periferie romane e milanesi, fino a Napoli.
Nelle Br non confluiscono solo ex Fgci (fatto anche generazionale. Chi era giovane nei primi anni 60 passava da lì come avvenne per alcuni fondatori di Potop), qualcuno, o pezzi del gruppo feltrinelliano, ma comunisti libertari come Faina, larghe fette di Potere operaio, meno di Lc, maoisti, quelli prima confluiti per Potop (altri ex mao confluiti in Potop fondano gruppi armati concorrenti) e altri ancora, e poi quel magma definito genericamente Autonomia, prima e dopo il 77.
Il reclutamento in una città come Roma, soprattutto nella zona periferica sud-est, si prolunga fino alla metà degli anni 80.
Che il terzointernazionalismo non sia riassumibile nello stalinismo lo si deve affermare per rispetto delle altre famiglie del comunismo internazionale. Quanto meno avresti dovuto prendere delle precauzioni periodizzando. I troskisti, i bordighisti, per citarne solo alcune, sono a pieno titolo figli di quella tradizione.
Senza dover citare Revelli, quella proiezione verso l’assoluto del fine che giustifica ogni mezzo non è propria solo dello stalinismo, che l’ha portata alla sua aberrazione massima, all’abisso senza ritorno. E’ insita in molte altre culture non solo del comunismo rivoluzionario, in quelle leniniste, nel troskismo, nella tradizione anarchica, ma e propria anche delle culture nazionaliste e fasciste, appartiene – lo sai meglio di me – alla grande avventura sionista tuttora in corso.
Aggiungo che non manca nemmeno nelle esperienze dell’operaismo armato: devo forse ricordare le gesta di Segio o le imprese di Fioroni?
Si da il caso che nella biografia di Prospero Gallinari non troverai nulla di tutto ciò!
Ecco appunto, torniamo a Prospero. La sua cultura è un must particolare, originale, che ha delle similitudini con gli altri emiliani ma non è sovrapponibile a quella di altri dirigenti brigatisti come Moretti, Curcio, Senzani, Balzerani, Guagliardo, per stare al gioco dei nomi conosciuti.
Un comunismo contadino che mette radici nell’Emilia profonda, che ha legami forti con la memoria della Resistenza in una zona segnata duramente dalla guerra civile (legami giustificati anche dalla vicinanza anagrafica), nella quale è presente la tradizione insurrezionalista, con elementi secchiani e dunque certamente di scuola “emmelle”, ma che si intrecciano pure con l’opposizione ingraiana. Un sostrato che si misura, e qui sta l’intelligenza e l’originalità del percorso di Gallinari, con le nuove culture sovversive della metropoli degli anni 70: quella operaia prima e quella delle periferie urbane dopo.
Posso capire cosa c’entra tutto ciò con lo stalinismo?
Ti sei mai chiesto come sia stato possibile che uno come Gallinari abbia di fatto installato, fatto crescere, dato basi solidissime alla colonna romana, la colonna terziaria per definizione, quella sociologicamente più negriana…. Quella dell’operaio sociale, dei disoccupati, dei borgatari, degli studenti, dei lavoratori dei servizi, dei ferrovieri.
Chi mai tra questi giovani, Gallinari avrebbe guardato con sospetto, come sostieni?
Solo una persona con una grande duttilità, una enorme capacità di ascolto e di adattamento avrebbe potuto “accudire” quel fiume di giovani che volevano entrare nell’organizzazione.
Le tue, Andrea, sono incrostazioni ideologiche, pregiudizi che non reggono alla luce dei fatti e di cui faresti bene a liberarti.
Non c’è stata organizzazione meno terzointernazionalista delle Br, questo è il punto. Forse alcuni accenti del genere riapparvero nell’aspro dibattito interno che divise quanto restava delle Br-pcc alla metà degli anni 80, ma era un momento in cui la voglia di tirare bilanci e rifondare tutto spingeva a cercare spunti ovunque. Durò poco.
La Brigate rosse, in realtà, hanno innovato, praticando un’eresia organizzativa ed ideologica. Guardavano agli esempi della guerriglia urbana metropolitana, Marighella e non il Che. Antileniniste sul piano dell’organizzazione, rifiutavano il modello del doppio livello, legale e illegale, della separazione tra direzione politica e braccio armato propugnando l’unificazione tra politico e militare, con un discorso che traeva coerenza dal rifiuto della divisione del lavoro manuale e intellettuale.
Nelle Br non esistevano i capi che mandavano i gregari a sporcarsi le mani, l’intellettuale che dava la linea e gli altri che eseguivano. Il dirigente andava in prima linea, non diceva armiamoci e partite per poi giustificarsi, come fece un certo professore, dicendo: “hanno capito male i miei libri”. Era moralismo rivoluzionario? Probabile.
Comunque si trattava di una formula organizzativa differente da quelle di altre formazioni di matrice operista ortodossa che invece praticarono senza problemi questa dualità tipicamente terzointernazionalista.
Vengo infine all’ultima parte, lì dove affermi che Prospero era uno di quelli, «che se il partito glielo avesse ordinato ti avrebbe eliminato, con le lacrime agli occhi ma senza esitare, convinto che questo fosse il suo dovere di rivoluzionario e di soldato della guerra di classe. Quella spietatezza politica era inaccettabile, certo, ma Prospero la condivideva con migliaia e migliaia di militanti dei suoi tempi».
Qui siamo alla calunnia bella e buona. Diversa solo nello stile dalle parole che ha scritto Fasanella su Panorama.
Dovresti rileggere quanto ha ricordato Lanfranco Pace in una intervista apparsa sul Foglio di questi giorni sull’atteggiamento misurato con il quale Gallinari gestì la grave crisi provocata dal modo in cui Morucci e Faranda uscirono dalle Br, rubando parte dell’arsenale militare dell’organizzazione. Un comportamento gravissimo, definito allora “banditesco” e che nella storia delle organizzazioni rivoluzionarie ha sempre provocato l’eliminazione dei responsabili.
Nelle Br esisteva una prassi che consentiva a chiunque fosse in crisi o in disaccordo di andare via dall’organizzazione se avesse voluto, ritirandosi a vita privata se era ancora possibile. Quando chi usciva era già latitante, otteneva in dotazione l’arma personale, dei soldi e un minimo di aiuto logistico, a rischio – come avvenne molte volte – di cadere in trappole micidiali tese dalla polizia. Nessuno veniva messo alla porta, gettato in strada.
Morucci e Faranda non si accontentarono di ciò, ebbero un comportamento “poco leale”, nonostante ciò quella vicenda venne ricondotta da Gallinari all’interno di una gestione politica del dissenso. Giudizi molto duri ma nessuna rappresaglia. Aggiungo che a minacciare Morucci in carcere furono altri personaggi, no sto qui a fare il nome, ma sai benissimo di chi parlo.
E visto che parliamo di Morucci ricordo – come da egli stesso raccontato nei suoi libri – che fu lui e non certo Gallinari ad intrattenere rapporti molto stretti con Feltrinelli, quando era ancora responsabile del lavoro illegale di Potere operaio (e le Br erano appena un piccolo gruppetto), fino ad avere quasi una doppia appartenenza.
Feltrinelli aveva rapporti internazionali di peso, non solo con Cuba e le guerriglie sud americane ma anche con il blocco orientale. Perché mai allora l’etichetta di stalinista non ricade su di lui ma l’appiccichi a Gallinari? E perché mai è lui che dovrebbe rispondere della leggenda del superclan come va dicendo Fasanella?
Concludo ricordando il ruolo e il comportamento tenuto da Prospero negli anni di carcere anche nei momenti di massima tensione interna alle Br o con altri gruppi (7 aprile, movimento della dissociazione), sempre improntato a ricondurre sul piano del confronto politico, anche aspro ma sempre politico, le divergenze, le rotture, lontano da qualsiasi sopraffazione fisica.
Basta leggere le sue memorie, il rammarico con cui racconta gli anni bui delle rese di conti che nel clima allucinato delle carceri speciali portò tronconi scissionisti delle Br a scagliarsi contro altri pezzi della stessa organizzazione, scatenando una guerra contro le proprie ombre, alla ricerca del capro espiatorio di turno.
Gallinari difese quelli che avevano ceduto sotto la pressione degli interrogatori o delle torture dando prova di saggezza, umanità, buon senso, grande lungimiranza politica e umana.
Un grande dirigente, il cui atteggiamento restio ad entrare nei dettagli era una questione di stile non di reticenza. Un vecchio stile comunista, misurato, asciutto, che si sforzava di trattenere i sentimenti, di mettere in avanti sempre la lucidità.
Paolo Persichetti
* * * *
E’ morto il br Prospero Gallinari: era generoso, altruista, coraggioso
Andrea Colombo
Gli Altri online 14 gennaio 2013
Prospero Gallinari era una persona meravigliosa. Molti lo sanno ma temo che pochi lo scriveranno. Invece è bene che sia detto. Era generoso, altruista, coraggioso. Era uno di quelli di cui si dice “col cuore grande” e forse non è solo un caso che alla fine, dopo una lotta lunghissima, proprio il cuore lo abbia fregato.
Certo, Prospero ha sparato, Prospero ha ucciso. Tecnicamente Prospero è stato un assassino. Ma chiunque lo abbia conosciuto anche solo di sfuggita sa perfettamente che questa verità è bugiarda. Non rende neppur minimamente ragione della vita e dell’animo di Prospero Gallinari.
Era un uomo d’altri tempi. Un militante comunista di quelli che per due secoli hanno fatto la storia. Un partigiano nato per caso a guerra finita. Da ragazzo si faceva chilometri a piedi per andarsi a leggere l’Unità nel bar del paese più vicino alla fattoria in cui era cresciuto. Da uomo fatto era ancora quel ragazzo.
Con noi, ragazzi di movimento, che negli anni ’70 il Pci lo odiavamo e lo combattevamo aveva pochissimo a che spartire. «Io – mi ha detto una volta – sono sempre stato un militante del Partito comunista italiano e, anche se ti sembrerà strano, in tutte le organizzazioni di cui ho fatto parte ho sempre rappresentato l’ala moderata». Ci guardava con sospetto, come quasi tutti i brigatisti, operai e contadini la cui continuità con la tradizione comunista era molto più ferrea della nostra.
Per anni e anni Gallinari è rimasto in galera col cuore sempre più malconcio, passando da un infarto a un altro. Avrebbe avuto il diritto di scontare la pena fuori da quelle mura, con un male così grave. Non gli veniva consentito solo perché era considerato, a torto, l’uomo che aveva ucciso Aldo Moro. Avesse detto che no, non era vero, che si assumeva tutte le responsabilità di quell’esecuzione atroce ma a sparare non era stato lui, lo avrebbero tirato fuori subito. Nessuno osò mai proporgli un gesto simile. Sarebbe bastato a farsi togliere per sempre la parola.
Gallinari sarebbe morto in galera senza un fiato se Mario Moretti, nel suo libro-intervista a Riossana Rossanda e Carla Mosca, non avesse dettio che a uccidere, in quel garage di via Montalcini, era stato lui. Tutti gli impedimenti che fino a quel momento avevano reso impossibile la sua scarcerazione caddero come per miracolo.
Sia chiaro, Prospero era un rivoluzionario generoso e di animo buono, ma era anche uno stalinista, uno di quelli che se il partito glielo avesse ordinato ti avrebbe eliminato, con le lacrime agli occhi ma senza esitare, convinto che questo fosse il suo dovere di rivoluzionario e di soldato della guerra di classe. Quella spietatezza politica era inaccettabile, certo, ma Prospero la condivideva con migliaia e migliaia di militanti dei suoi tempi. Che non erano i nostri, perché Prospero Gallinari era davvero un uomo e un rivoluzionario e un comunista “d’altri tempi”.
Credo che a tutti quelli che lo hanno conosciuto, per quanto lontanissimi fossero dalle sue scelte, per quanto severamente lo possano aver criticato, mancherà moltissimo.
* * * *
Replica di Paolo Persichetti
15 gennaio 2013 at 19:52
C’è un episodio sconosciuto che vorrei raccontare: nel 1989 erano in corso nell’aula bunker di Rebibbia diversi maxi processi; l’appello del Moro ter, quello per insurrezione contro i poteri dello Stato, oltre a quello contro le Br-Udcc nel quale ero imputato. In quel momento si discuteva molto di soluzione politica, c’erano settori dello Stato che volevano chiudere la vicenda della lotta armata. L’atteggiamento dei media verso i prigionieri politici era cambiato e così accadeva che ogni tanto ci veniva offerta la parola. In una pausa delle udienze, il giornalista Ennio Remondino intervistò Prospero Gallinari e tra le diverse domande gli chiese anche con chi stessero i prigionieri delle Br: con il governo cinese, che aveva inviato i carri armati in piazza, o con i manifestanti di Tienamen? «Con gli occupanti della piazza, e con chi se no?», fu la risposta di Gallinari. Naturalmente Bruno Vespa, allora direttore del Tg1, tagliò quella frase che smontava uno dei cliché più classici e mistificatori incollati sulla pelle dei militanti della lotta armata.
Caro Andrea hai fatto la fine di Vespa. Peccato che il tuo pezzo molto bello sia alla fine scivolato nel dizionario dei luoghi comuni.
Paolo Persichetti
* * * *
Replica di Andrea Colombo
15 gennaio 2013 at 20:50
Caro Paolo, mi sono riletto il pezzo, scritto molto a caldo, per rintracciare gli eventuali luoghi comuni. Non sono sicuro che ci siano, anche se come medium internet non agevola l’approfondimento. Cmq provo a spiegarmi. Non sapevo di quella domanda di Ennio Remondino, ma non avrei avuto alcun dubbio sulla risposta di Prospero. Però, scusa, che c’azzecca? Se Prospero fosse stato con il Pcc, in quell’occasione, non sarebbe stato stalinista ma stupido, e non lo era.
Mi riferivo a qualcosa di meno banale, più tragico, per certi versi anche più funesto. Una intera generazione di comunisti, quella terzinternazionalista, ha accettato parecchie aberrazioni, sapendo che erano tali, dunque soffrendole, perché questo era l’interesse del partito e, dunque, della rivoluzione. Esempio non brigatista e non sanguinolento: quando il Pci decise di estromettere Giuliano Pajetta, la cui sola colpa era quella di aver fatto la resistenza in Jugoslavia, Giancarlo sapeva perfettamente che si trattava di una feroce ingiustizia e che suo fratello fosse oggetto di quella ingiustizia che gli rovinò la vita non lo faceva certo felice. Ma scelse di tacere perché questo chiedeva il partito, cioè la rivoluzione. Di esempi simili ce ne sono letteralmente migliaia: quello era lo stalinismo. Era atroce, era in qualche misura “inumano” ma aveva una sua altrettanto atroce nobiltà. Voi, secondo me, siete stati gli ultimi epigoni di quella cultura.
Non sarò reticente: so perfettamente che tutti gli inquilini di via Montalcini soffrirono come cani il 9 maggio del 1978. Però scesero lo stesso in garage perché ritenevano che questo chiedesse, anzi imponesse, la rivoluzione. Quella contraddizione è tragica e secondo me voi, magari non sempre essendone coscienti, la avete vissuta più di chiunque altro in quegli anni. E Prospero, credo, persino più degli altri.
Questo volevo dire, e non sono convinto, ripeto, che sia un luogo comune.
Link
Prospero Gallinari, un uomo del 900
Gallinari è morto in esecuzione pena. Dopo 33 anni non aveva ancora ottenuto la libertà condizionale
Prospero Gallinari quando la brigata ospedalieri lo accudì al san Giovanni
“Eravamo le Brigate rosse”, l’ultima intervista di Prospero Gallinari
A Prospero Gallinari volato via troppo presto
Ciao Prospero
Prospero Gallinari chiede la liberazione condizionale e lo Stato si nasconde dietro le parti civili
Per saperne qualcosa di più
La biblioteca del brigatista
Il nemico inconfessabile
La biblioteca del brigatista
Mario Moretti, Brigate rosse une histoire italienne
La révolution et l’Etat
La vera storia del processo di Torino al “nucleo-storico” delle Brigate rosse: il Pci intervenne sui giurati popolari
Caso Moro, l’ossessione cospirativa e il pregiudizio storiografico
Il caso Moro
Doppio Stato e dietrologia nella narrazione storiografica della sinistra italiana
Spazzatura, Sol dell’avvenir, il film sulle Brigate rosse e i complotti di Giovanni Fasanella








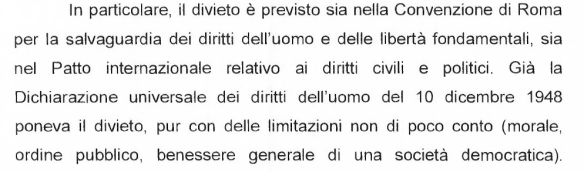
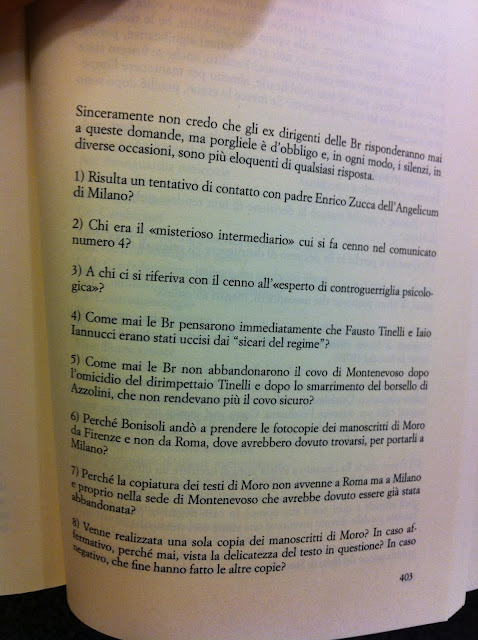
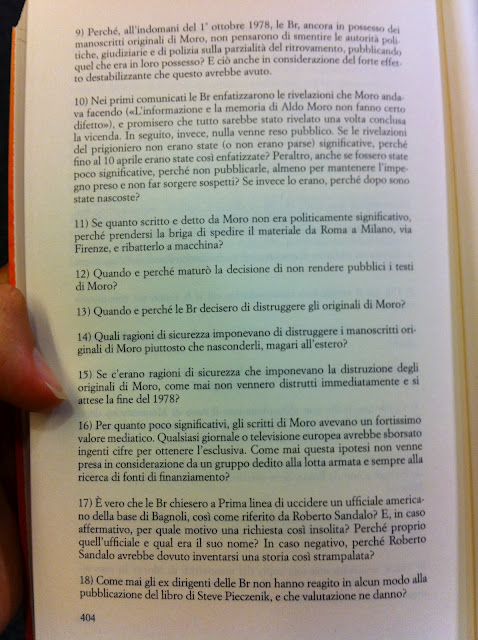

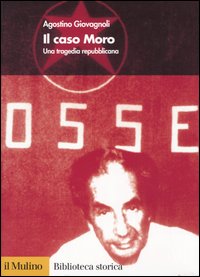 esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana. Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da
esistiti. È questo l’incipit con il quale lo storico Agostino Giovagnoli introduce il più recente lavoro sul sequestro del presidente della Dc, Il caso Moro. Una tragedia repubblicana. Un volume che dimostra come gli studi sugli anni 70 improntati ad una seria metodologia storica, seppur con fatica, stianno finalmente cominciando a farsi strada, dopo il pionieristico saggio sulla presunta “Pazzia” del presidente Dc, dato alle stampe da 
 straordinarie), il rapimento dell’imam milanese Abu Omar, realizzato dalla Cia con il coinvolgimento diretto del Sismi e l’inchiesta della procura milanese che ne è seguita, hanno portato alla luce l’esistenza di nuovi accordi segreti su cui i governi Berlusconi e Prodi hanno posto con perfetta continuità e spirito bipartizan il segreto di Stato. È da questa constatazione storica, difficilmente contestabile, che deve partire una riflessione sul modo in cui è stata raccontata a sinistra la sudditanza atlantica dell’Italia.
straordinarie), il rapimento dell’imam milanese Abu Omar, realizzato dalla Cia con il coinvolgimento diretto del Sismi e l’inchiesta della procura milanese che ne è seguita, hanno portato alla luce l’esistenza di nuovi accordi segreti su cui i governi Berlusconi e Prodi hanno posto con perfetta continuità e spirito bipartizan il segreto di Stato. È da questa constatazione storica, difficilmente contestabile, che deve partire una riflessione sul modo in cui è stata raccontata a sinistra la sudditanza atlantica dell’Italia.
 Sarebbe cominciata la delocalizzazione del lavoro, la ristrutturazione della produzione e il primato del capitale finanziario su quello produttivo. Ma il processo non era irreversibile. Nella loro ipotesi, bastava scoprire gli ingranaggi, gli uomini, i referenti dello Sim per fermarlo e Moro era uno di questi. Si trovano, nella teorizzazione dello Sim, grandi intuizioni e capacità di lettura della realtà (fu ipotizzata nel 1975), ma anche terribili ingenuità. La divisione del mondo in buoni e cattivi, in sodali e vittime innocenti non appartiene a una realtà complessa, che deve sempre tenere conto di moltissime forze, spesso in competizione, per restare in equilibrio. Quest’ultima considerazione si attaglia anche alla cosiddetta teoria del doppio Stato, recentemente tornata attuale dopo un intervento del presidente Napolitano e gli articoli di noti giornalisti, in particolare del
Sarebbe cominciata la delocalizzazione del lavoro, la ristrutturazione della produzione e il primato del capitale finanziario su quello produttivo. Ma il processo non era irreversibile. Nella loro ipotesi, bastava scoprire gli ingranaggi, gli uomini, i referenti dello Sim per fermarlo e Moro era uno di questi. Si trovano, nella teorizzazione dello Sim, grandi intuizioni e capacità di lettura della realtà (fu ipotizzata nel 1975), ma anche terribili ingenuità. La divisione del mondo in buoni e cattivi, in sodali e vittime innocenti non appartiene a una realtà complessa, che deve sempre tenere conto di moltissime forze, spesso in competizione, per restare in equilibrio. Quest’ultima considerazione si attaglia anche alla cosiddetta teoria del doppio Stato, recentemente tornata attuale dopo un intervento del presidente Napolitano e gli articoli di noti giornalisti, in particolare del