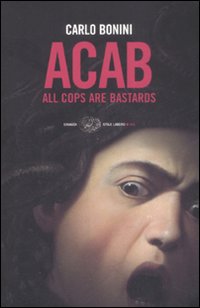Ciò che legittima il preteso monopolio dello Stato nel ricorso a mezzi coercitivi (vedi la nota definizione di Max Weber) e lo distingue da una qualunque banda, cosca, ‘ndrina, clan, branco è il principio di autolimitazione e automoderazione. Più l’uso della forza è normato, più la violenza è regolamentata, ridotta ai minimi termini, ai momenti più estremi, maggiore è il grado di legittimazione che la forza pubblica acquisisce. Ma nel momento in cui la violenza istituzionale abbandona questi requisiti, lo Stato ed i suoi appparati tornano ad essere una banda come le altre, non la banda legittima ma soltanto la banda più forte… finché dura.
Libri – autorecensione. Rabbia, odio, spirito di corpo. Nel libro di Carlo Bonini, Acab, Einaudi, i duri delle forze dell’ordine raccontati a partire dalle loro discussioni segrete sul Web. Quello che i celerini non dicono ma fanno
di Carlo Bonini
Repubblica 16 gennaio 2009
“Le violenze alla Diaz dopo il G8 di Genova? Non mi vergogno di nulla. L’Italia non è uno stivale. È un anfibio di celerino”.
Clic 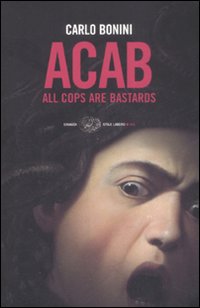
“Cari colleghi, riteniamo giusto rammentare, per senso di responsabilità, che DoppiaVela è uno spazio per i poliziotti messo a disposizione dalla polizia di Stato. Le critiche, le lamentele, le segnalazioni di disservizi, anche se esternate in modo aspro ma corretto, fanno parte delle normali dinamiche di dialogo tra l’amministrazione centrale e i singoli dipendenti. Trovano dunque una sede naturale all’interno del portale che non può, però, garantire spazi che la normativa vigente attribuisce ad altri soggettii”.
Clic.
Ogni volta che entrava in quella benedetta chat intranet, Drago ne gustava la dimensione perversa. A cominciare da quel nome un po’ ingessato – DoppiaVela, la sigla della centrale operativa nelle comunicazioni radio – e dal post politicamente corretto che metteva sull’avviso i naviganti. Perché la verità era che lì dentro si poteva finalmente essere un po’ guardoni e un po’ scorpioni. Masturbarsi dietro un avatar, leggendo l’illeggibile o scrivendo l’inconfessabile. Divorarsi a vicenda – sì, proprio come scorpioni in bottiglia – soltanto per scoprirsi più soli nella propria rabbia. Finita sulle prime pagine dei giornali con sei rotondi anni di ritardo, la “macelleria messicana” del dottor Fournier era stato un potente lassativo. Il forum era impazzito. Genova, troppo lontana e spaventosa per sembrare ancora vera, era diventata solo l’occasione per un outing collettivo. La prova, ammesso ce ne fosse bisogno, che il tempo era stato una pessima medicina. Che odio chiama odio.
Clic.
G. DA ROMA Ecco che spunta fuori un nostro bel funzionario, che da buon samaritano riaccende fiamme polemiche e propositi dinamitardi. Che, sicuramente, nelle prossime manifestazioni gli antiglobal metteranno in atto perché più autorizzati che mai. Ma quando la finiremo di fare sempre queste mere figure e inizieremo a tenere la bocca chiusa?
Per Aspera ad astra.
N. DA ANZIO Fournier poteva e doveva risparmiarsi la frase a effetto, “macelleria messicana”. Adesso, per i colleghi ci sarà la solita Santa Inquisizione mediatico-politica.
Unus sed leo.
I. DA GENOVA Ma questo Fournier dov’era durante gli scontri? Ancora non l’ho capito. Era fra i manifestanti? Ha respirato lacrimogeni? O aveva una mascherina? Secondo me si è messo a cantare perché non gli hanno dato nessuna promozione.
P. DA BARI È ancora in polizia o ha chiesto di passare alla politica?
Sono pronto a mostrare il petto e non voglio essere bendato. Ma tu hai il coraggio di guardarmi negli occhi? E che cazzo, mostra ai più di essere uomo. Barcollo ma non mollo.
D. DA LA SPEZIA Colleghi, basta di parlare di questo soggetto. È penoso e noi lo stiamo aiutando nella sua viscida campagna elettorale.
A. DA CAGLIARI Genova, presente con orgoglio e senza nulla da nascondere. Posso testimoniare di Bolzaneto! Non si tratta di essere grandi e non è veramente falsa modestia è solo servizio! Ero al VI reparto mobile di Genova.
L. DA SALUZZO Io c’ero. VI reparto mobile. Tanto orgoglio, tanta rabbia!
Clic.
(…)
C. DA ROMA Non capisco perché non vogliate parlare degli errori commessi. Qui si tratta di dire chiaramente:
I colleghi che gridavano Sieg Heil ci fanno vergognare, o no?
I colleghi che avrebbero minacciato di stupro le signorine antagoniste meritano la nostra esecrazione, o no?
I colleghi che si accanivano con trenta manganellate sul primo che passava senza sapere se era solo un povero illuso pacifista o un violento vero, hanno sbagliato, o no?
La collega che al telefono con il 118 di Genova, riferendosi alla Diaz, parla di “Uno a zero” dimostra di essere intelligente?
Su queste cose non ci può essere ambiguità!!!
L’esistenza è battaglia e sosta in terra straniera.
Clic.
E bravo il nostro C., pensò Drago. Stai a vedere che ora gli vanno addosso i padovani. Se ne stanno zitti da troppo tempo. Ma è più forte di loro. Se c’è da far vedere chi ce l’ha più duro, loro non sanno resistere. Rinfrescò la chat. Solo per vincere una scommessa troppo facile.
Clic.
E. DA PADOVA Caro C., rispondo alle tue domande:
“I colleghi che gridavano Sieg Heil ci fanno vergognare, o no?”
No. Non mi vergogno del fatto che in polizia ci siano dei coglioni. Non più del fatto che ci siano in Italia. Sono fiero di essere celerino e italiano, nonostante loro!
“I colleghi che avrebbero minacciato di stupro le signorine antagoniste meritano la nostra esecrazione, o no?”
No. Per questa domanda, oltre a valere la risposta sopra, concedimi anche il beneficio del dubbio. Chi prenderebbe seriamente un tentativo di violenza a una capra malata? Il popolo antagonista non brilla certo per l’attaccamento all’igiene! Non credo a quello che, sicuramente in malafede, sostengono questi personaggi!
“I colleghi che si accanivano con trenta manganellate sul primo che passava senza sapere se era solo un povero illuso pacifista o un violento vero, hanno sbagliato, o no?”
No. Pur essendo convinto assertore della totale inutilità di infierire su un manifestante inerme (questo è l’unico sbaglio, sprecare le forze su uno solo), sappi che è impossibile farsi rivelare dal manifestante durante la carica, se è un “povero illuso pacifista” o meno. È inoltre abbastanza difficile, dopo ore di sassaiole subite, magari con fratelli feriti anche gravemente, beccare uno dei personaggi che ti stanno avanti e picchiarli solo un pochettino. Quello che dico è che il povero illuso, visti gli stronzi che stavano con lui, poteva tornarsene a casa invece di manifestarci insieme! Se gli è andato bene fare da scudo per questi delinquenti, allora non si può lamentare di subirne le conseguenze! Che poi qualche collega si sia comportato come un qualsiasi essere umano sotto stress non mi sembra né incomprensibile né disdicevole. Sicuramente qualcuno avrà commesso sbagli. Sai quanti poliziotti c’erano a Genova? Di sicuro non mi vergogno per i loro errori!
“La collega che al telefono con il 118 di Genova, riferendosi alla Diaz, parla di “Uno a zero” dimostra di essere intelligente?” No. Ma come si dice a Roma, sti cazzi! Hanno messo a ferro e a fuoco una città, rischiando di farci fare una figura di merda a livello internazionale, provocando danni, feriti, spese enormi e si preoccupano della frase di una telefonista? Non mi vergogno per quello che ha detto. Mi vergogno perché oggi la madre di un teppista imbecille, dimostrando una mancanza di scrupoli e un cinismo degni di una Kapò, è riuscita a farsi eleggere senatrice della Repubblica; perché un partito italiano ha fatto intitolare un’aula all’imbecille!
Non voglio i soldi di questi politici. Non voglio i soldi da questo governo (e da un altro come questo). A difendermi ci penso da me, con l’aiuto di Dio e dei fratelli celerini, che mi stanno accanto e non mi tradiscono nel momento del bisogno.
Once in the Celere, always in the Celere.
C. DA ROMA Quindi, per te, avere al fianco un cretino non è un problema?
Lo dico serenamente: due che tengono e uno che mena non mi sembra da eroi. E poi ti rispondo da romano: “sti cazzi un par di palle”. Tu non lavori nel Cile di Pinochet e non ti pagano con lo stipendio in pesos messicani (forse è di cattivo gusto visto il titolo del thread di discussione, “macelleria messicana”, e me ne scuso con quanti si sentono feriti). Il giuramento che hai prestato parla di far rispettare le leggi, non di fartene di tue. In quanto al rischio della “figura”, mi pare che l’abbiamo fatta e basta. E le responsabilità, lo dico da mesi, non sono di chi stava in strada, ma di chi ha permesso che si arrivasse a questo. Siamo stati mandati lì, sapendo quello che ci avrebbero fatto e sapendo come avremmo reagito. Ti piace questo? Ti piace essere una pedina e poi pagarti l’avvocato? Io questo vorrei evitare. Vorrei capire come si può evitare che un collega mandato a fare il proprio dovere si ritrovi indagato in due processi e, dopo la Maddalena, forse anche nel terzo. Scusate la lunghezza.
L’esistenza è battaglia e sosta in terra straniera.
P. DA BARI Scusate, il Sig. Dott. Funz. Uff. Fournier quando lo faranno santo?
Sono pronto a mostrare il petto e non voglio essere bendato. Ma tu hai il coraggio di guardarmi negli occhi? E che cazzo, mostra ai più di essere uomo. Barcollo ma non mollo.
E. DA FIUMICINO Io penso che questi degni eredi di quei cattivi maestri che dicevano in piazza “Uccidere uno sbirro non è reato” ci considererebbero picchiatori fascisti anche se andassimo in servizio di Op vestiti di rosa e con un mazzo di fiori in mano.
B. DA PADOVA Quando alcune centinaia di ultras o di autonomi sono schierati a cinquanta metri da te con spranghe, catene, bombe carta e coltelli, io ritengo opportuno fargli così tanto schifo e paura che non devono pensare di poterci attaccare senza lasciarci le ossa!
L’Italia non è uno stivale. È un anfibio di celerino.
Clic.
Link
Violenza di Stato non suona nuova
G8 massacro alla Diaz, per i giudici d’appello il blitz fu ordinato da Ge Gennaro