Al centro di tutto la “vittima meritevole”. Come l’uso politico della nozione di vittima ha trasformato l’azione penale e l’idea di giustizia
Paolo Persichetti
Gli Altri 17 maggio 2013
Per lungo tempo l’idea di giustizia corredava il tentativo di raggiungere obiettivi universali in grado di ripercuotersi nel miglioramento delle condizioni di vita materiali e spirituali di ciascuno. Al concetto di giustizia si associavano l’idea di eguaglianza e fraternità (oggi diremmo anche sorellanza), di libero sviluppo dell’esistenza umana, oppure la salvezza. Insomma qualcosa che contribuiva al bene collettivo (tanto per stare al mutamento dei linguaggi, ora si pronuncia “bene comune”).
Oggi il concetto di giustizia non è semplicemente sovrapposto a quello di diritto, ma indica un diritto tutto particolare, il diritto di punire. Il desiderio di migliorare le sorti collettive è sopravanzato da una visione penitenziale del mondo che vede nell’azione penale, concepita come un paradiso incontaminato contrapposto alla realtà impura dell’agire politico, lo strumento per intervenire sulla realtà.
Questo nuovo senso comune, interamente immerso all’interno di una visione manichea del mondo che non offre scampo, o si è interamente vittime o totalmente colpevoli, ha proiettato la figura della vittima tra gli status sociali più ambiti, rendendola un’«autentica incarnazione dell’individuo meritevole: quasi un modello ideale di cittadino».
In una società dove sempre più viene meno ogni capacità inclusiva e prevalgono al suo posto dispositivi predatori, risultato della «tensione tra ideologia neoliberale del libero mercato e autoritarismo morale neoconservatore», le contraddizioni, i malesseri sociali, la fatica di vivere assumono l’aspetto di un viluppo confuso di sentimenti, di grumi di rancore che intrecciando la paura per l’avvenire e l’ossessione per il declino sociale accentuano i processi d’identificazione vittimistica.
Se c’è una vittima deve esserci per forza un carnefice, ciò preclude per definizione la possibilità che vi possa essere una comune condivisione vittimaria. Non potendo essere tutti vittime ecco che presto si apre la competizione. L’investitura legittimante offerta dallo status di vittima, infatti, resta caratterizzato da un accesso limitato e diseguale. Non tutti hanno il diritto di essere vittime e non tutte le vittime sono vittime allo stesso modo.
La postura vittimaria – spiegano gli studi che si occupano del fenomeno – è riconosciuta unicamente sulla base di selezionati requisiti di ordine sociale, economico, politico, culturale ed etnico; criteri che variano secondo le latitudini. Per i gruppi sociali stigmatizzati in partenza, nei confronti dei quali si presume una contiguità originaria con l’universo criminale o la genealogia del male, non vi è alcuna possibilità di accedere alla santità vittimaria.
In effetti, più della vittima in sé è la nozione di “vittima meritevole” che trova affermazione e legittimazione. La vittima forte non lascia scampo alla vittima debole. Non basta aver subito un torto o un danno per poter essere riconosciuti come tale, occorre innanzitutto entrare a far parte della categoria legittimata ad esserlo, un pantheon esclusivo.
Proiettata dall’ombra lunga d’Auschwitz, l’immagine della vittima trae la sua superiorità etica dalla figura dell’inerme, colui che è oggetto di un’aggressione totale di fronte ad una passività assoluta. Questa asimmetria originaria è tuttavia ben diversa dall’intricato groviglio di conflitti presenti nelle società attuali e che inevitabilmente rende spurio e controverso ciò che si tende a collocare tra le vittime odierne, difficili da districare nell’intreccio spesso simmetrico dei contrasti, delle tensioni e delle violenze.
Più che un giudizio di fatto, lo status di vittima è il risultato di un giudizio di valore talmente significativo, poiché fonte immediata di legittimazione politica, da essere divenuto esso stesso il luogo della disputa. Un terreno di battaglia innescato da quella «esaltazione narcisistica della sofferenza», di cui ha scritto Zigmunt Bauman in Modernità e olocausto, e che alla fine – come sosteneva Hannah Arendt – genera solo altre vittime, negando quel riconoscimento dell’altro che nel dispositivo agonistico del conflitto è il nemico, mentre in quello vittimario diventa l’assolutamente diabolico, il male universale, l’extraumano da bandire, colui che per definizione è fuori da ogni consesso civile.
Lungi dall’aver rafforzato il riconoscimento della dignità umana, la competizione vittimaria si è prestata ad una facile strumentalizzazione che è servita a rafforzare il potere dei Leviatani. Sul piano internazionale, grazie al pretesto dell’ingerenza umanitaria, il paradigma vittimario ha favorito il passaggio dall’etica guerriera alle guerre etiche, alimentando la grande ipocrisia della giustizia penale internazionale che ha permesso ai vincitori di processare i vinti. Come diceva Pascal, «non riuscendo a fare della ragione una forza, hanno fatto della forza l’unica ragione», abolendo ogni capacità di discernimento tra i crimini di lesa umanità universalmente riconosciuti, come tortura, schiavitù, genocidio, misfatti coloniali e le infrazioni commesse da chi ha esercitato il diritto di resistenza.
Sul piano interno, l’ideologia vittimaria ha accompagnato la deriva giustizialista e la controriforma del processo penale, trasformato da luogo di accertamento delle prove a teatro di una cerimonia catartica che dovendo offrire riparazione simbolica alla vittima anticipa anzitempo un giudizio senza scampo per il reo.
Infine, sul piano sociale passivizza i soggetti vittimizzati, amputandone l’interezza umana e la complessità politica e civile, così ridotta all’aspetto monodimensionale di chi esprime solo dolore e sofferenza e domanda una riparazione. Richiesta che non trovando l’appagamento promesso dal processo penale precipita spesso nella spirale del risentimento infinito.
Approfondimenti
Il paradigma vittimario



 rapporti, modi di comportarsi di quel periodo). Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).
rapporti, modi di comportarsi di quel periodo). Mughini avanza l’ipotesi che Sofri non sia colpevole diretto, ma che sapesse. E che conosca i nomi di chi uccise Calabresi. Tesi che già in passato aveva sostenuto. Personalmente questa ricostruzione non mi convince. Penso che Sofri sia innocente. E constato che, in ogni caso, contro di lui non sono state raccolte prove, e i processi che si sono conclusi con la sua condanna erano processi indiziari, tutti fondati sulle dichiarazioni di un pentito (non verificate e non verificabili) il quale in cambio della condanna di Adriano Sofri ha ottenuto per se la libertà dopo pochissimi mesi di prigione (pur essendo stato condannato come autore materiale dell’uccisione).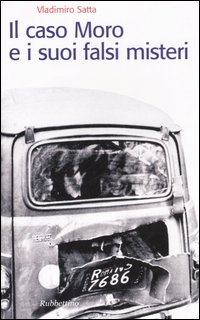 capovolgimento di fronte che stravolge l’esito fin troppo scontato attribuito alle cose. In questo caso vittima del destino cinico e baro è Giovanni Fasanella, autore del libro-intervista realizzato con Alberto Franceschini,
capovolgimento di fronte che stravolge l’esito fin troppo scontato attribuito alle cose. In questo caso vittima del destino cinico e baro è Giovanni Fasanella, autore del libro-intervista realizzato con Alberto Franceschini,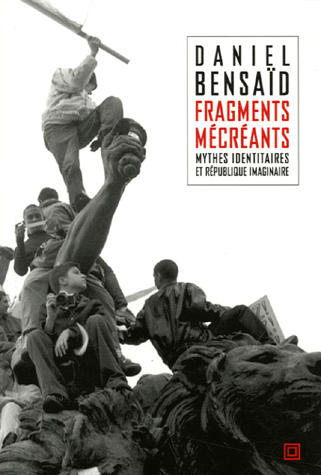

 Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che
Vorrei provare a dirvi cosa rappresenta la negazione della ricostruzione di un essere umano. Dobbiamo parlare di ricostruzione, visto che Marina non è uscita dalla sua storia politica nello stesso modo in cui ci è entrata. È successo un po’ più di 25 anni fa, quando già il vento della lotta armata cominciava ad andare via, quando i rumori metallici della notte tuonavano sempre più vicino, dopo che alcuni, quelli che poi sono stati chiamati “pentiti”, incominciavano a barattare delle riduzioni di pena in cambio di denuncie e delazioni, fu allora che la storia politica di mia madre è incominciata a finire. Erano i primi anni ’80. Dopo aver capito che le sue speranze di cambiare il mondo andavano incontro alla sconfitta e che l’impegno politico tenuto fino allora non poteva più continuare allo stesso modo, Marina decise di non fermare la sua vita, ma che dal suo percorso sarebbe potuta nascere una nuova storia. Questa nuova storia è incominciata con me che  permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.
permesso di uscire dal carcere e di essere libera fino al verdetto della Cassazione del 1993. Già a quell’epoca Marina non era più quel soggetto pericoloso dipinto dai media al momento del suo nuovo arresto. Ma l’Italia dimentica presto. Meglio ricorda solo quel che vuole. Seleziona la memoria. La Francia di Mitterand cercando di favorire una pacificazione del conflitto italiano degli anni ’70 ha accolto numerosi ex attivisti di quel periodo. I governi di sinistra come di destra hanno rispettato questo asilo di fatto. A noi, figli di quei rifugiati, è stato permesso di crescere, di vivere, di avere anche nuovi fratelli e sorelle. L’esilio c’è stato malgrado le contraddizioni, malgrado le incertezze di una vita difficile, precaria in attesa di un asilo. Un asilo che esprimeva una speranza di una vita nuova. Dal nulla di un “fine pena mai” che Marina aspettava in Italia è nata nel 1997 mia sorella. Una bambina francese che ora vede quel paese che gli ha dato una nazionalita ricacciare sua madre nel pozzo del carcere a vita. Da quel 1993 quindici anni sono passati. Quindici anni da quando un treno ci ha portato alla Gare de Lyon. Quindici anni da quando i nostri passi si sono mischiati a quelli dei nostri migranti d’inizio secolo. Anche speranzosi di una vita che non fosse la galera della miseria. Perché questo “pezzo” di tempo, che ha permesso di cambiare il loro impegno politico in un impegno sociale, non è più che legittimo per chiedere asilo? Perché non è ora di girare la pagina di questa storia, per permettere a noi nuove generazioni di avere un vero futuro e consentire a quelle persone come mia madre di vivere la seconda chance che gli è stata data? A venticinque anni di distanza dai fatti imputati, quindici anni dopo l’esilio, un nuovo primo ministro francese ha deciso che bisognava rimangiarsi la parola data da tutti i suoi predecessori. Il governo francese ha deciso di estradare mia madre, di cancellare la sua vita in Francia e di rinchiuderla non solo in un carcere ma di fare del passato la sua prigione. La Francia ha deciso tutto questo cedendo al populismo penale, all’ossessione sicuritaria ad una voglia di vendetta infinita che ha perso il significato della speranza. Il primo ministro ha deciso che la vita di mia madre doveva fermarsi. Ma quindici anni di esilio di fatto creano dei diritti e noi non lasceremo la Francia deresponsabilizzarsi dalla sua storia e cultura.